A cosa “serve” Gesù? Non a risolvere i problemi dell’uomo, ma ad affrontarli
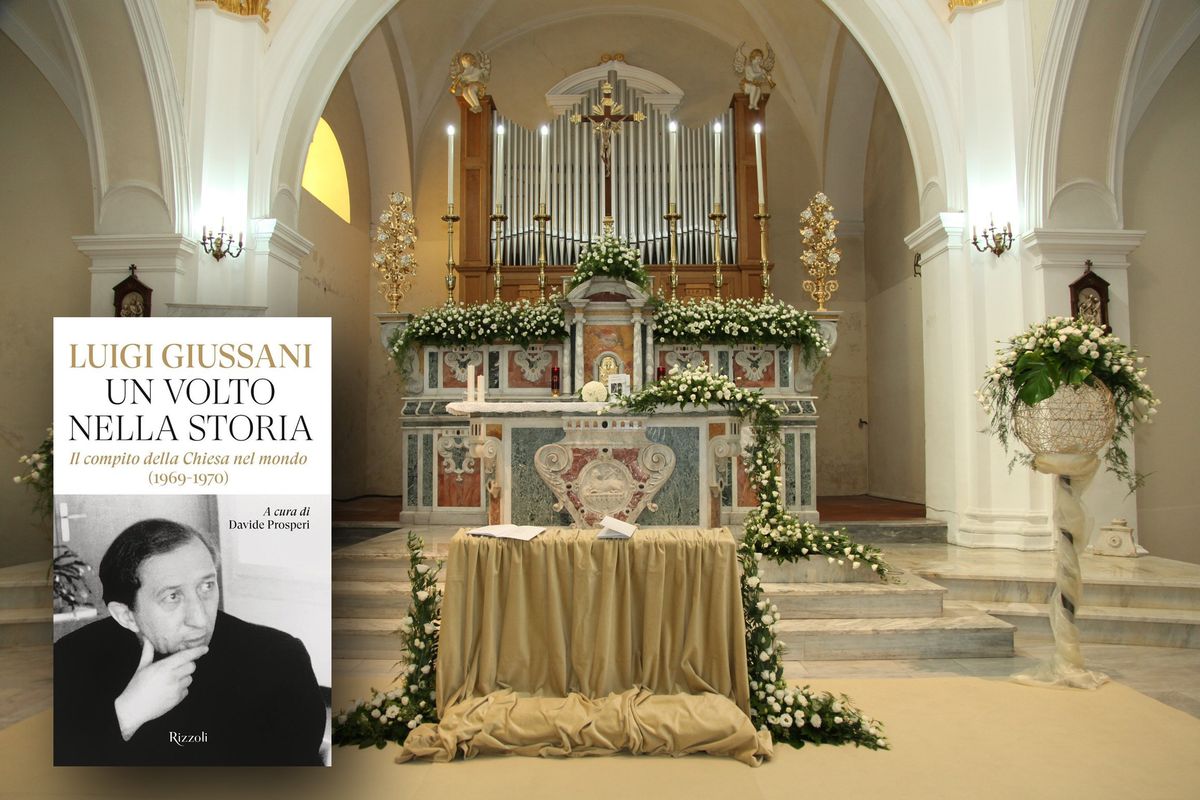
Come dobbiamo pensare, immaginare, il rapporto «Chiesa-mondo»? [...] Lo scopo del fatto cristiano, lo scopo di Cristo o lo scopo della Chiesa - perché è lo stesso, identico scopo quello di Cristo e della Chiesa - è l’educazione religiosa della umanità. È importante questa definizione ed è molto importante l’enucleazione di questo principio. Non posso, infatti, andare dal carrettiere lamentandomi perché non mi sa spiegare la fenomenologia di Hegel: ognuno ha un compito, ha una sua funzione, e deve essere avvicinato, giudicato, valorizzato secondo la funzione che ha. Qual è la funzione di Cristo? Qual è la funzione del fatto cristiano? Immediatamente, direttamente, è l’educazione religiosa dell’umanità: «Così parlò Gesù; poi alzando gli occhi al cielo, disse: “Padre, l’ora è venuta; dà gloria al Figlio tuo, perché anche il Figlio tuo dia gloria nel mondo a te. Attraverso il potere su ogni uomo che tu gli hai dato, egli doni la vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna: che essi conoscano te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo”». L’educazione religiosa dell’umanità è lo scopo di Cristo e della realtà cristiana nel mondo. E l’educazione religiosa della umanità è riassunta nelle parole che abbiamo lette, nel concetto di «vita eterna». L’educazione religiosa della umanità sta in questo: che conoscano il vero Dio e Colui che Egli ha mandato, Cristo; dove la parola «conoscenza», è chiaro, introduce ben altro.
Questa conoscenza di Dio e di Cristo, questa comunicazione di vita eterna, risulta la condizione profonda per la realizzazione dell’umano destino. Ma i problemi umani che cosa sono, se non il sussulto contingente provocato dalla dinamica per cui l’uomo è investito dall’attrattiva del suo destino ed è mandato verso di esso? Perciò possiamo dire che questa educazione religiosa della umanità, questa comunicazione di vita eterna, questa conoscenza di Dio e di Cristo risulta la condizione profonda perché i problemi umani possano essere risolti. Insomma, la vita eterna di cui ha parlato Cristo è l’origine e lo scopo di tutto, segna l’alfa e l’omega di tutto, come dirà l’Apocalisse. Se è l’origine e lo scopo di tutto, allora è ciò che determina ultimamente la possibilità della risoluzione della problematica di cui la vita è costituita.
Dobbiamo qui citare quella frase del Vangelo che certamente è stata, nella storia della nostra coscienza, una delle pietre miliari del nostro discorrere: «Chi mi segue avrà la vita eterna e il centuplo quaggiù». Per questo motivo ciò che dice Niebuhr, in quel bellissimo volume edito da Jaca Book, Uomo morale e società immorale - un libro che non si legge senza che venga provocato un salto qualitativo nelle proprie conoscenze e nella propria coscienza -, non è vero dal nostro punto di vista. In modo tipicamente protestante, egli sottolinea, con un pessimismo senza fondo, ciò che la visione della Chiesa attenua con discrezione: dice, infatti, in un certo punto, che la religione è sempre una cittadella di speranza costruita sull’orlo della disperazione.
Ora, che essere sull’orlo della disperazione faccia capire più facilmente la contingenza, l’effimero di tutti i nostri dogmi umani, di tutti i nostri programmi, i nostri sforzi, i nostri tentativi, che ne faccia capire la fragilità, la precarietà, la contingenza, l’effimero e, dall’altra parte, faccia potentemente intuire, presentire, affermare, per implicazione logica della nostra coscienza d’esistere, l’eterno, il divino, l’aldilà, l’oltre noi, questo è vero. Ma la religione non è appena questo. Infatti: «Chi mi segue avrà la vita eterna e il centuplo quaggiù».
Lo scopo di Cristo e della Chiesa, della realtà cristiana, è dunque la comunicazione della vita eterna, di quella conoscenza di Dio, di Cristo, che risulta, proprio perché alfa e omega di tutte le cose, condizione profonda per la realizzazione del nostro destino e, perciò, condizione profonda perché i problemi umani possano essere risolti.
Procedendo, in una seconda sottolineatura di questo principio, potremmo, abbastanza esaurientemente - non ingenuamente né troppo approssimativamente -, ricollocare tutti i nostri problemi umani entro quattro grandi categorie. Mi pare una categorizzazione, dicevo, non troppo approssimativa: il problema dell’amore, o della completezza personale, della completezza della persona come tale; il problema del lavoro, o della espressione, dell’affermazione della persona; il problema della cultura, o della ricerca del significato delle cose, dell’ambito che la propria persona vive e crea, il problema della ricerca della verità; il problema della politica, o il problema dell’umana convivenza.
Amore, lavoro, cultura, politica: i problemi indicati da queste parole non hanno direttamente una soluzione dal fatto cristiano come tale, cioè non è compito di Cristo e del fatto cristiano come tale il risolverli. Immaginatevi, per favore, se essere cristiani significasse per la ragazza trovare il ragazzo adatto o per il disoccupato trovare il lavoro. Vangelo di san Luca, capitolo 12,13-15: «Uno della folla gridò: “Maestro, dì a mio fratello che divida con me l’eredità comune” [un problema di elementare giustizia e di amore fraterno]. Ma egli rispose: “Amico, chi mi ha costituito giudice per regolare le parti che toccano all’uno o all’altro?”. Poi disse loro: “Guardatevi dalla cupidità, perché anche in mezzo all’abbondanza la vita dell’uomo non è affatto sicura dei propri beni”». E Cristo prosegue con una delle parabole più drastiche, più tremende, quella del ricco che, avendo fatto tanto raccolto, dice all’anima sua: «Eh, adesso sto bene, per sette anni sono a posto». «Stolto»! Ecco, «stolto» si sentì dire. Dunque, Cristo, di fronte all’invito a un gesto concreto di giudizio in un problema di giustizia o, se volete, anche di rapporti familiari, è stato perentorio nel dire: «Chi mi ha costituito giudice?». Cioè: «Non tocca a me stabilire questo». I problemi umani, nel senso contingente e drammatico della parola, immediatamente non tocca a Lui risolverli. La realtà cristiana non ha questo come scopo.
Qual è allora il nesso tra quello scopo che abbiamo visto prima e questa reticenza che ci appare strana fino a urtarci? Dov’è il valore del centuplo quaggiù? Cristo pone la condizione profonda perché i problemi umani possano essere risolti, pone la precondizione perché tali problemi possano essere affrontati veramente, autenticamente, pone la precondizione della loro solvibilità autentica. Insomma, a quel tizio che chiedeva un giudizio ha fatto intendere: «Tu vieni qui a lamentarti di tuo fratello non per amore della giustizia, ma per quello stesso attaccamento ai soldi per cui tuo fratello, più scaltro e furbo di te, ti ha fregato. Se tu fossi stato al suo posto, avresti fatto lo stesso. Allora, se io ti rispondo, non risolvo il problema: sarebbe come mettere un bendaggio a una ferita putrida, senza un medicamento che la faccia guarire; sarebbe come nascondere qualche cosa, non risolvere».
Cristo pone la precondizione per la solvibilità dei problemi umani. Questa precondizione non è semplicemente giustapposta, non è una pretesa senza nesso con la soluzione del problema, ma qualifica le soluzioni: non risolve, ma pone delle condizioni per la soluzione. Consideriamo ad esempio il problema del rapporto uomo-donna. Il problema dell’amore non può essere risolto senza la precondizione cristiana, che qualifica i termini della soluzione, mette delle condizioni perché la soluzione sia veramente soluzione. L’indissolubilità del matrimonio, la non poligamia derivano da questo.
Cristo pone la precondizione e nello stesso tempo qualifica i termini della soluzione. Altrimenti, senza religiosità cristiana, i problemi, ultimamente, cioè nella loro autenticità reale, non sono risolti, ma alterati, complicati, e perciò aumentati. [...]
Pensiamo per esempio agli sforzi di redenzione sociale, di cambiamento delle strutture, che non tengono veramente presente il fattore «persona», che rappresenta un grande inconveniente per i politici, per i filosofi, per i programmatori e per i teorizzatori: la persona, infatti, non può essere generalizzata, è un caso concreto, irriducibile ad altri, ed è un grave intoppo per tutti i teorizzatori di qualunque colore.
Facciamo un nota-bene alla fine di questo primo principio. È ancora una frase di Niebuhr molto interessante, sempre del libro citato, a suggerirlo: «Una società che è tormentata [come la nostra] da urgenti problemi politici ed economici, come quelli che si trova davanti il mondo contemporaneo, tende a disprezzare ogni forma di espressione che non abbia un’immediata incidenza sui suoi problemi più urgenti».
Perciò, una società come la nostra, tormentata da urgenti problemi, tende a disprezzare una realtà come quella cristiana, che non ha come immediato scopo la loro soluzione. Ed è questa la tentazione di tutti i tempi. Nei cristiani di cento anni fa, anche pieni di buone intenzioni, si conclamava la necessità che la Chiesa si adeguasse alla mentalità e alla cultura liberale; oggi si conclama la necessità che la Chiesa si adegui ad altre categorie. Ma non è questo il problema essenziale, o meglio, così come viene posto, il problema è estremamente equivoco. Cinquant’anni fa hanno chiamato «modernismo» una urgenza di questo tipo, quasi che il valore della Chiesa, il diritto a esistere del fatto cristiano, traesse il suo motivo dalla sua capacità di adeguazione alle categorie della cultura vigente. Così, oggi è predicato un concetto di povertà che è infinitamente più derivato da una concezione politica, da una concezione sociologica, che non dal Vangelo, anche se è attribuito al Vangelo. La categoria del Vangelo è infinitamente più sfumata, è infinitamente più umana, soprattutto è infinitamente più poggiata sulla libertà dell’uomo: non è una categoria politico-sociale, la povertà del Vangelo.






