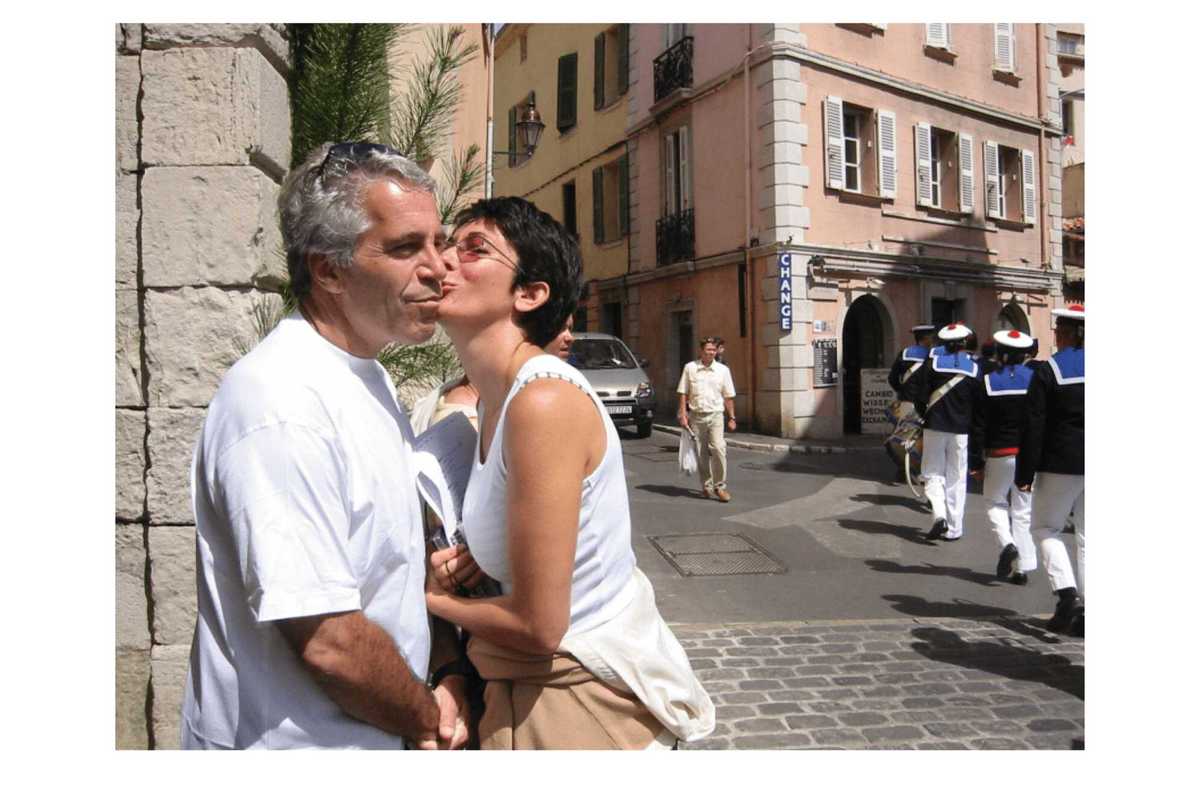L’Italia sveglia l’Ue sui limiti alla CO2. Sono 15 i Paesi che vogliono rivederli

Per l’Europa è arrivato il momento della scelta: continuare pervicacemente a seguire le scadenze dettate dal Green deal così come partorito dalla vecchia Commissione, a cominciare dalla tagliola dei nuovi limiti alle emissioni fissata nel 2025, o anticipare la revisione del meccanismo al prossimo anno? Insomma, seguire la transizione in modo ideologico o in modo pragmatico, considerando ciò che si può e ciò che non si può fare?
A suonare la sveglia ai partner europei ci ha pensato il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, che ieri ha presentato il «non paper» (documento non ufficiale, ndr) italiano sull’automotive al Consiglio competitività, raccogliendo un ampio consenso. Quindici i Paesi che si sono espressi in modo favorevole. Oltre agli 8 proponenti (Italia, Repubblica Ceca, Austria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Bulgaria) hanno supportato il documento anche Estonia, Cipro, Croazia, Grecia, Slovenia, Belgio e Lettonia. Contrari in quattro (Danimarca, Spagna, Svezia e Irlanda).
Nel documento si chiede alla Commissione di anticipare all’inizio dell’anno prossimo le clausole di revisione già previste per la fine 2026 per i veicoli leggeri e nel 2027 per i veicoli pesanti. Nessuno vuole mettere in discussione l’obiettivo della piena elettrificazione al 2035, come previsto dal Fit for 55 del Green deal, ma si vogliono creare le condizioni per non arrivarci con l’industria dell’auto decimata. «Se raggiungiamo l’obiettivo con un’industria net-zero, avremo indicato una strada di successo anche agli altri. Se, invece, raggiungiamo quella data con zero industria, avremo certificato il nostro fallimento e nessuno ci seguirà», ha detto Urso presentando il documento.
Secondo la tabella di marcia attuale, nel 2026 dovrebbe esserci la valutazione, da parte della Commissione, dei progressi che si sono fatti nel raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 100% delle emissioni delle auto. Questo step, in base al documento italiano, dovrebbe essere anticipato al 2025. È una richiesta che nasce dal grido di allarme del settore, costretto a chiudere stabilimenti e licenziare a fronte del crollo delle vendite.
Urso lo ha ripetuto al Consiglio Ue: «È un bollettino di guerra: ogni giorno vengono annunciate rinunce a realizzare gigafactory o la chiusura di quelle già create nel nostro continente o la chiusura degli stabilimenti, con licenziamenti di decine di migliaia di operai, perché le imprese automobilistiche non vogliono cadere sotto le penalità miliardarie che, dal prossimo anno, saranno loro somministrate». Dal prossimo gennaio, infatti, scatteranno le multe per chi non rispetta i limiti delle emissioni del parco auto. Per evitarle, le case automobilistiche potrebbero ricorrere al taglio della produzione delle endotermiche con tutto ciò che significherebbe in termini di perdita di posti di lavoro.
Nel «non paper» italiano si chiede anche una politica commerciale di tutela della concorrenza leale, «come fanno altri continenti», e «un sostegno importante, attraverso un piano automotive, alle famiglie europee che oggi non si possono permettere di comprare un’auto elettrica o ecologicamente sostenibile».
Sul tavolo del Consiglio competitività è arrivato anche un secondo documento preparato da Francia, Germania e Svezia nel quale si chiede un maggior impegno sulle batterie delle auto elettriche, fornendo alle imprese produttrici le condizioni per andare avanti. Numerose imprese europee attive in questo settore hanno rilevato forti difficoltà «a causa di una competizione globale non basata su un livello di concorrenza comune». Il documento dice che «bisogna mandare un segnale forte, che restiamo forti dietro gli sforzi concordati per assicurare una catena del valore delle batterie, competitiva e sostenibile in Europa». Northvolt, il gruppo svedese che per primo ha avviato una gigafactory in Europa ha annunciato 1.600 esuberi in Svezia, la riduzione dell’organico del 20% a livello globale e ha presentato istanza di fallimento.
Questi due documenti sembrerebbero trovare orecchie attente nella Commissione. Significativo quanto ha detto la vicepresidente con delega alla Concorrenza, Margrethe Vestager: «Il futuro dell’industria dell’automotive deve essere made in Europe». La dichiarazione segue quanto affermato dal presidente della Commissione, Ursula von der Leyen al Parlamento europeo, dove ha promesso di voler convocare un dialogo strategico sul futuro dell’automotive in Europa, ascoltando tutti i protagonisti. Urso ha sottolineato come queste dichiarazioni «ci rassicurano sul fatto che il dossier diventerà centrale nell’azione dei primi 100 giorni dell’attività della nuova Commissione», e che «come detto da Von der Leyen, se ne occuperà direttamente lei». Alle proposte italiane sono arrivate, inoltre, le adesioni di Confindustria, Bdi e Medef, le associazioni imprenditoriali di Italia, Germania e Francia.
Nell’Unione europea il settore dei trasporti impiega direttamente e indirettamente 14 milioni di persone.