Ma quale maschio bianco e tossico. Il ranger era fratello degli indiani
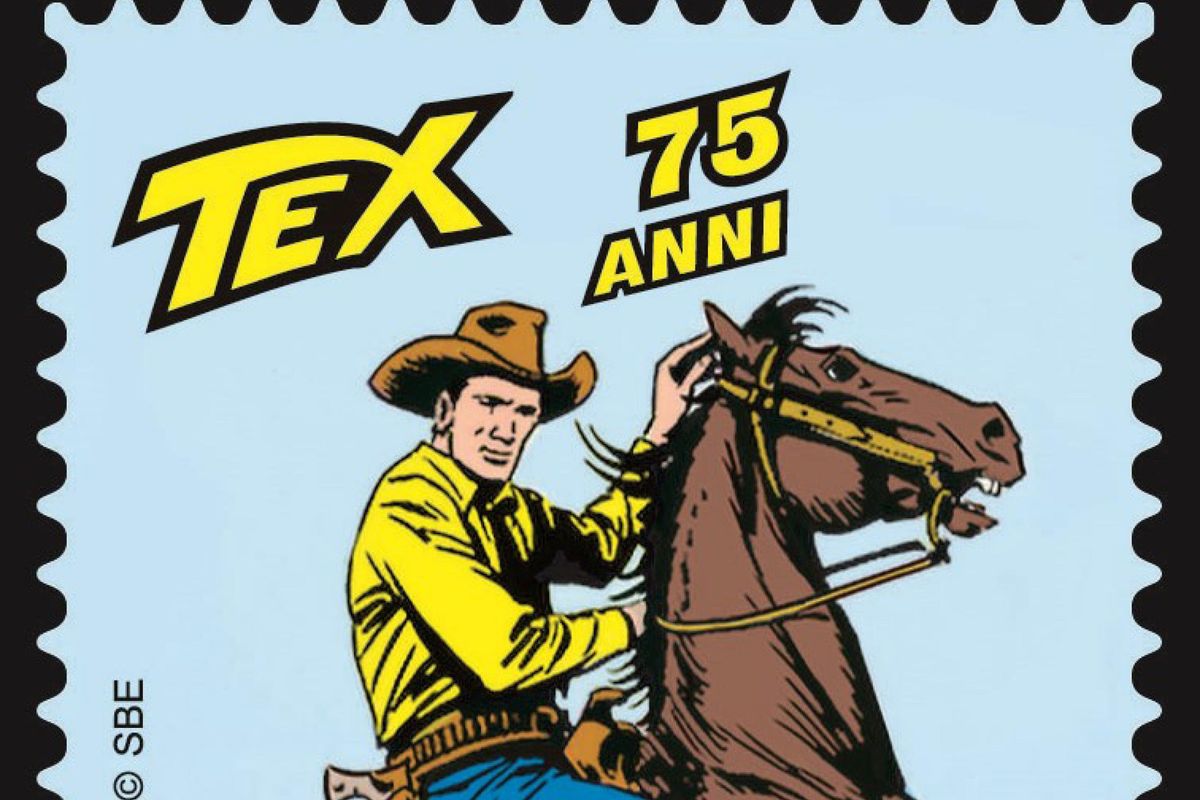
Non è più il tempo di Mefisto, di Yama o della Tigre Nera. Tex Willer, adesso, deve affrontare un nemico ancora più temibile: il revisionismo politicamente corretto, che è arrivato a indicarlo quale massimo esponente italiano di una cultura fondata sulla «superiorità del salvatore bianco tra i selvaggi dalla pelle scura». È accaduto ieri sulle pagine di Repubblica, in un lunghissimo articolo in cui Carlo Pizzati, oltre a sostenere alcune tesi spericolate (per esempio che la Rivoluzione francese e quella americana, l’Illuminismo e la sinistra occidentale siano tutti stati originati dalle critiche rivolte dagli indiani d’America alle monarchie europee), si scaglia contro il mito del cowboy plasmato nel Novecento dalla propaganda culturale Usa. E racconta anche qualcosa di sé, descrivendosi come un bambino veneto degli anni Sessanta e Settanta cresciuto a pane e fumetti di Tex, tanto da essere poi rimasto un appassionato - sebbene ormai pentito, anzi pentitissimo - del genere western.
Con tali premesse, la prima cosa che viene da domandarsi è come possa un cultore di Tex incappare nei grossolani errori sul personaggio commessi da Pizzati, definito nelle biografie reperibili in rete «scrittore, giornalista e docente universitario». Per ben due volte, infatti, egli attribuisce all’editore e sceneggiatore Sergio Bonelli l’invenzione di Tex, mentre il creatore del ranger fu nel 1948 (assieme al disegnatore Aurelio Galleppini) il padre di Sergio, ovvero il fumettista e scrittore milanese Gianluigi Bonelli: un’informazione a dir poco scontata per un lettore di Tex. Non solo, riferendosi agli albi che leggeva (o, a questo punto, avrebbe letto) da ragazzino, Pizzati parla inspiegabilmente di «disegni colorati arricchiti dalle trame di Sergio Bonelli» (che appunto era Gianluigi, anche se Sergio avrebbe scritto a sua volta alcune storie di Tex a partire dalla metà degli anni Settanta); Pizzati deve avere avuto per le mani dei numeri di Tex provenienti da un universo parallelo, visto che le avventure del ranger, da sempre, sono pubblicate rigorosamente in bianco e nero tranne qualche eccezione comunque risalente ad anni recenti.
Il sospetto che le letture di Tex effettuate a suo tempo da Pizzati siano un puro frutto della sua immaginazione si rafforza però, divenendo quasi certezza, di fronte alla sua valutazione di Aquila della Notte (nome indiano assunto da Tex in qualità di capo della tribù dei Navajos): sì, perché dire che Tex abbia contribuito a diffondere l’idea di una superiorità morale e culturale dell’uomo bianco rispetto ai nativi americani significa, né più né meno, affermare il falso, stando le cose in maniera esattamente opposta. Già nel lontanissimo 1950, quando gli altri fumetti d’avventura erano, in Italia, effettivamente legati a una visione stereotipata dei pellerossa (come del resto l’allora imperante cinema western americano), Tex sposa una donna navajo, Lilyth, e con questa ha un figlio, Kit (alias Piccolo Falco), che in età adulta dovrà spesso fare i conti con il fatto di essere spregiativamente considerato un «mezzosangue». Tex, come già detto, diventa a un certo punto capo dei Navajos, adottando un nome indiano, indossando abiti tipici di quella tribù e trascorrendo molto del suo tempo nella riserva navajo in Arizona; il suo migliore amico, dopo Kit Carson, è il navajo Tiger Jack, figura contraddistinta da senso dell’onore, carisma e non comune intelligenza. Da sempre impegnato in ogni modo nella difesa dei nativi e dei loro diritti, anche a costo di mettersi contro qualche alto graduato dell’esercito, Tex è addirittura fratello di sangue del celebre leader dei Chiricahua, Cochise (personaggio realmente esistito). Il tutto anni e anni prima che facesse la sua comparsa il western autocritico di film come Piccolo grande uomo o Soldato blu.
Insomma, se in Italia è stato possibile che milioni di persone iniziassero a guardare in modo rispettoso e perfino ammirato ai nativi americani, apprendendo la verità sul genocidio di cui furono vittime, il merito è soprattutto di Tex e in generale della casa editrice Bonelli, a cui si devono tra l’altro collane a fumetti del tutto aderenti alla realtà storica come Storia del West (1967) di Gino D’Antonio, I protagonisti (1974) di Rino Albertarelli, Ken Parker (1977) di Berardi & Milazzo e Magico Vento (1997) di Gianfranco Manfredi.
Pizzati, verso la fine del suo pezzo, scrive: «La verità del West è molto diversa». Può darsi, di sicuro lo è la verità su Tex. Diversissima.






