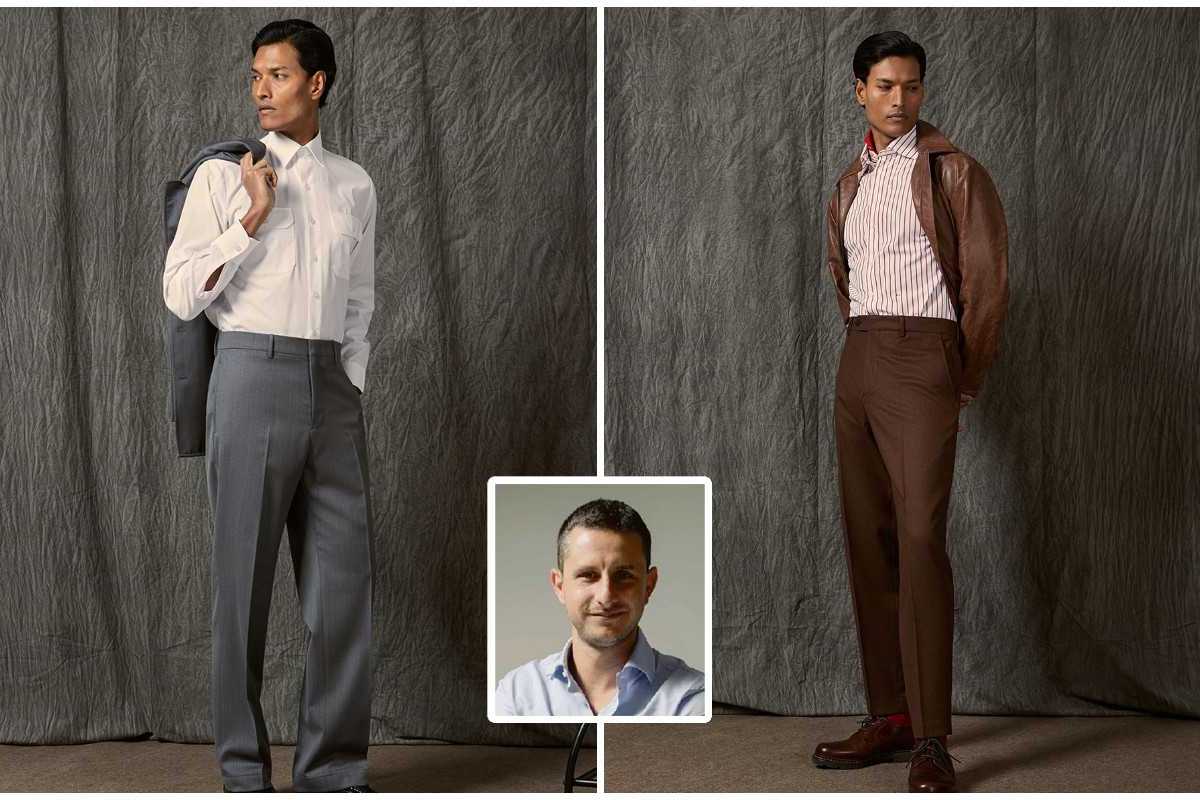Sui media è risorto il Covid. Ma a cosa serve davvero riesumare il cadavere dell’emergenza? A mettere sul piatto un altro argomento contro Giorgia Meloni, certo: al primo ricovero di troppo, al primo ospedale un po’ in affanno, al primo picco di contagi, si potrà accusare il governo di non aver «fatto abbastanza». Dopodiché, si ha pure un’altra impressione, a leggere la doppietta sulla Stampa di ieri - bollettino allarmistico e indignata denuncia sullo spreco delle dosi: che la comunicazione ansiogena sia funzionale a promuovere l’ennesimo round di punture. Giusto per evitare che anche i farmaci anti Omicron restino a marcire nei frigo delle Regioni, o nell’hub di Pratica di Mare. Dove, tra giugno e agosto, sono scaduti oltre 16 milioni di dosi.
Sommando le scorte accatastate nei magazzini dell’Aeronautica a quelle distribuite sul territorio, si arriva a cifre astronomiche: in totale, ricorda il quotidiano torinese, uno spreco di 102 milioni di dosi, per quasi 2 miliardi di euro buttati. Così La Stampa, alla buonora, scopre che quello degli acquisiti centralizzati da parte dell’Unione europea non è stato un grandissimo affare. E che, non soddisfatti dello sperpero, adesso siamo pronti a ricevere altri 9 milioni e 173.000 shot di un preparato che si fa presto a definire aggiornato, visto che è calibrato sulla variante Kraken, già soppiantata da Eris e Pirola. Si tratta di una vera e propria «tassa vaccinale che si fa fatica a comprendere», scrive il giornale. Forse, scoprire i dettagli del negoziato condotto via smartphone da Ursula von der Leyen e il ceo di Pfizer, Albert Bourla, potrebbe contribuire a svelare l’arcano. Ma non ci vuole un’approfondita investigazione per nutrire qualche dubbio sugli obiettivi della rediviva campagna terroristica, portata avanti da giornalisti ed esperti. I quali, durante la pandemia e, a quanto pare, pure dopo, si sono comportati da piazzisti di Big pharma, più che da analisti indipendenti.
Dite che esageriamo? Allora guardate l’ultimo episodio, che ha per protagonista il dottor Fernando Lunedi, referente di un ambulatorio di Veroli (Frosinone) dedicato al trattamento dei pazienti affetti da long Covid.
Qualche giorno fa, il medico si è fatto intervistare dalla Tgr Lazio, su Rai 3. E lì, in diretta, si è lasciato scappare alcune dichiarazioni clamorose: «Dobbiamo dire che il long Covid in un paziente vaccinato sicuramente ha una pertinenza maggiore». Ovvero? Il vaccino è un fattore scatenante? «No», ma «può essere uno strumento che complica sicuramente l’infezione dal long Covid». Nella testata regionale Rai si sarà scatenato il panico. E il video del colloquio è sparito dal sito Web. Come se, in una democrazia liberale, la televisione pubblica debba limitarsi a rilanciare dei dogmi, anziché ospitare opinioni fondate. Almeno, per dar conto dell’evoluzione degli studi sul Sars-Cov-2. Ci risiamo: non si può permettere che trapeli alcun elemento in grado di intaccare la narrazione salvifica sui vaccini. Il sistema dell’informazione sembra aver archiviato i principi del giornalismo; quello scientifico, il metodo; entrambi agiscono quasi dovessero rispondere a logiche di marketing. L’imperativo dei produttori è comprensibile: si deve collocare un prodotto sul mercato. L’inghippo non sta nella fame di profitto delle case farmaceutiche, quanto nella collaborazione che assicurano comunicatori e tecnici, terrorizzati dall’idea di scalfire il Verbo.
Naturalmente, l’autocensura Rai non ha impedito allo spezzone di galoppare sui social. Anzi, come spesso accade in circostanze simili, proprio l’ansia di oscurare tutto potrebbe averne favorito la circolazione. Una sorta di mini caso Vannacci. Nel frattempo, il dottor Lunedi ha sentito il bisogno di correre ai ripari. Ha sottolineato di essersi «convintamente vaccinato», ha ribadito che il vaccino è stato «determinante nel contrasto al Covid» e, infine, ha provato a sostenere che «il vaccino non peggiora in alcun modo il long Covid». Il punto è che la maggior parte degli italiani ha ricevuto le punture e, dunque, «va da sé che i pazienti afferiti al centro long Covid fossero in larghissima parte vaccinati». Già. Peccato che i luminari ci avessero raccomandato di porgere il braccio a ripetizione, proprio per metterci al riparo dai postumi della malattia. Quanto ai soggetti nei quali l’inoculazione «ha determinato un andamento più subdolo e cronicizzante della sindrome», Lunedi ha tagliato corto: «Sono casi largamente minoritari». Ah: su Rai 3 non aveva usato l’avverbio «sicuramente»? «Sicuramente» il vaccino complica il long Covid?
L’autodafé rievoca l’arte della «dissimulazione onesta» nella prima età moderna, allorché, per schivare l’Inquisizione, i filosofi atei riempivano le loro opere «empie» di professioni di fede. La differenza è che, all’epoca, non c’erano scorte di medicine da smaltire. Alla fine, il dilemma è questo qua: oggi, quando ci rivolgiamo agli esperti, chi stiamo ascoltando? Giornalisti e scienziati, oppure agenti di commercio di Pfizer?