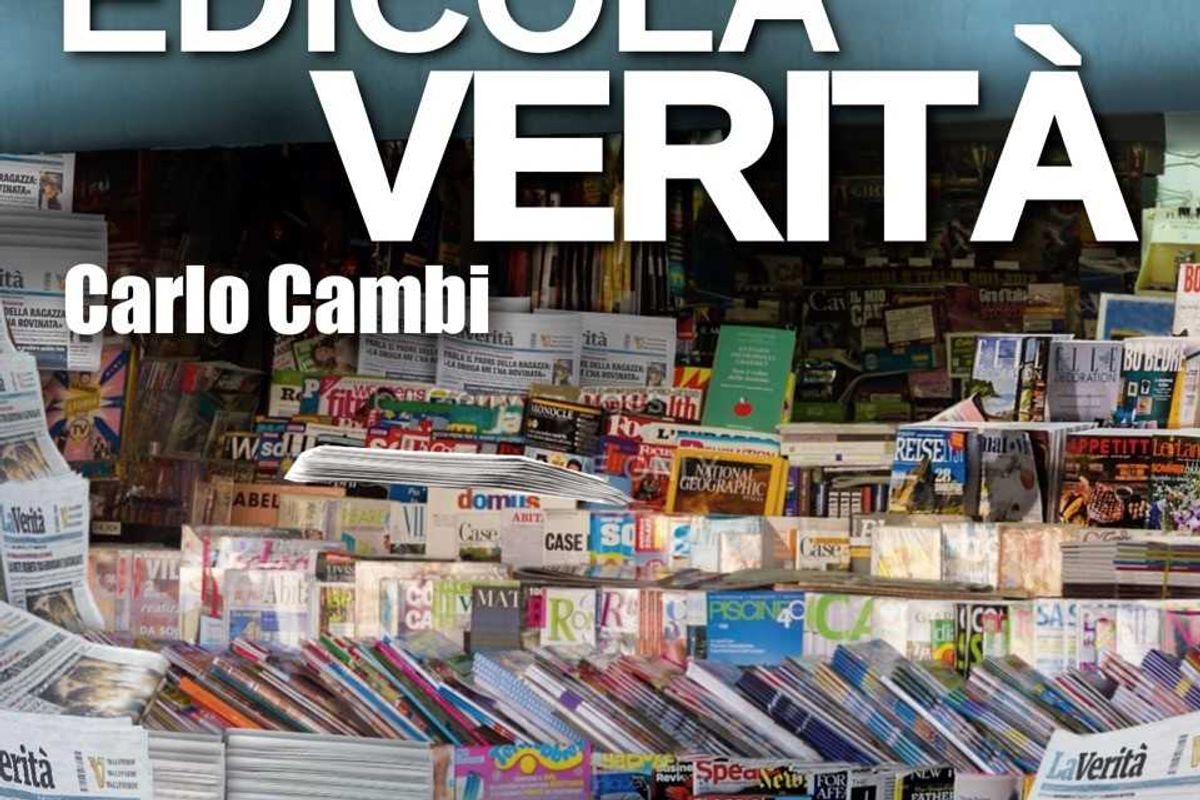L'equazione rilanciata di continuo, esplicitamente o implicitamente, è questa: Matteo Salvini è un nuovo Benito Mussolini. Anche Giorgia Meloni, a ben vedere, è un gerarca fascista in gonnella. Vediamo di analizzare storicamente questa equazione, non prima di aver ricordato che l'allarme, «Ecco il nuovo duce!», accompagna la storia italiana da troppi anni.
È Eugenio Scalfari con il suo quotidiano Repubblica ad accusare di ducismo, a partire dal 1976, prima Bettino Craxi, poi Silvio Berlusconi, ripetendo in tempi diversi e per personalità differenti, la medesima campagna denigratoria. Lo ha raccontato molto bene Giampaolo Pansa, per anni vicedirettore di Repubblica, nel suo La Repubblica di Barbapapà. Storia irriverente di un potere invisibile. Nel capitolo intitolato Il club dei giacobini Pansa riportava una riflessione di Angelo Panebianco, editorialista del Corriere della Sera: «Il gruppo che fa capo a Repubblica, salvo poche eccezioni, è portatore di uno stile polemico inconfondibile. Consiste nella sistematica criminalizzazione di chi non la pensa come loro. I repubblicani non conoscono avversari con cui è possibile polemizzare, ma rispettandoli. Conoscono solo nemici da abbattere». Indignarsi, accusare, demonizzare, serve infatti, tra le altre cose, a «serrare le fila di quella che loro chiamano la comunità dei lettori», a creare una comunità militante, e a potersi presentare come quelli che stanno dalla parte della ragione e del bene. Un metodo che il giornalista Benito Mussolini, prima a l'Avanti e poi a Il popolo d'Italia, conosceva e praticava bene!
Sempre Pansa, ricostruendo la fascistizzazione di Craxi, ricordava: «Per cominciare Bettino venne presentato ai lettori nei panni di un nuovo Mussolini. Non pericoloso come il defunto, ma con tutti i numeri per diventarlo. Era un pregiudizio, o un'opinione, che fece subito breccia nella satira politica. Persino Giorgio Forattini, di certo non amico dei comunisti, cominciò a ritrarre Craxi in divisa da gerarca fascista. Alfredo Chiappori lo presentava in panni mussoliniani. Emilio Giannelli lo raffigurava identico al capo del regime nero… Dall'accusa di fascismo si passò poi a quella di capeggiare una banda di malviventi».
Così insomma Repubblica: cioè un giornale fondato da un uomo, lo stesso Scalfari, che aveva esordito scrivendo sulle riviste universitarie fasciste, e dotato di collaboratori come Giorgio Bocca, che aveva applaudito le leggi razziali del 1938 e Corrado Augias, recentemente accusato di aver collaborare con i servizi segreti comunisti! Ma veniamo alla storia.
Nel 1922 Benito Mussolini progetta la marcia su Roma, soffiando l'idea allo squadrismo agrario: sa bene, infatti, che la via elettorale gli è preclusa. Il partito fascista, di per sé, ha pochi voti, e non può minimamente competere, sul piano elettorale, con il Partito popolare di don Luigi Sturzo e con il Partito socialista italiano. Per questo non mira alle elezioni, ma alla piazza. Oggi cosa succede? Salvini, Meloni, e il resto del centrodestra, non meditano una nuova marcia sulla capitale e non hanno paura del voto popolare, anzi, lo desiderano. A puntare sulla piazza, ripiena di sardine o altro, non sono i presunti «fascisti», ma gli esponenti del Partito democratico, guidato da un uomo, Nicola Zingaretti, che ha militato nel Partito comunista italiano all'epoca in cui esisteva ancora il muro di Berlino e il dittatore Nicolae Ceaușescu era considerato, dal suo partito, un amico degno di stima.
Oggi è dunque la sinistra a soffiare sul fuoco del movimentismo, sono i presunti antifascisti a temere la via democratica del voto. Il che, si badi bene, è anche ciò che accade, mutatis mutandis, nel 1922: i socialisti astensionisti di allora, così come i comunisti, predicano la rivoluzione violenta, al pari dei fascisti, e disprezzano profondamente la «democrazia borghese» e il Parlamento! È proprio questo atteggiamento violento e irriducibile, contrario ad ogni collaborazione con gli altri partiti antifascisti, a favorire il trionfo di un movimento minoritario come quello di Mussolini.
Ma analizziamo ora un secondo aspetto. Benito Mussolini può contare sulla forza delle squadre di camicie nere. Picchiatori di professione abituati a rispondere colpo su colpo, ripagando 3 per 1, alle violenze dei socialisti. Stime attendibili parlano, per gli scontri tra rossi e neri, di 3.000 morti tra i rossi e di 400 tra i neri, tra il 1919 e il 1922. Oggi non si vede all'orizzonte nulla di simile. L'aspetto più visibile e decisivo del fascismo, la sua forza paramilitare, è del tutto assente. Se proprio vogliamo cercare dei violenti, possiamo trovarli tra i «pacifisti» dei centri sociali tanto coccolati dalla sinistra.
Proseguiamo ora nella ricerca di qualcosa di fascista nell'attuale centrodestra italiano, evitando accuratamente di fare altrettanto, cioè di cercare qualcosa di comunista, nello schieramento avverso. Mussolini nel 1922 può contare sulla simpatia dell'esercito, sull'appoggio di molti giornali, sull'indulgenza, sino al 1924, di corazzate come il Corriere della Sera di Luigi Albertini, e di quanti temevano una rivoluzione bolscevica in Italia. Inoltre sa anche conquistare, se non l'amicizia, almeno una qualche benevolenza dell'uomo che lo nominerà presidente del Consiglio: il re Vittorio Emanuele.
Oggi nessuno teme un intervento dell'esercito al fianco di Salvini, Meloni e Berlusconi; i grandi giornali, compreso il Corriere, sono per lo più schierati a sinistra; quanto all'uomo che ha, al posto del re, il potere di eleggere il presidente del consiglio, si chiama Mattarella: è un uomo di sinistra, eletto dal Partito democratico.
A Salvini e Meloni mancano dunque la marcia su Roma, le squadre violente, i giornali, l'esercito e il placet del re: in altre parole, tutto ciò che rese possibile l'ascesa del fascismo. Anche idealmente le distanze sono assolute: come non percepire la lontananza tra un movimento, quello fascista, che nacque guerrafondaio, centralista e statalista e uno, la Lega, regionalista e avverso a qualsiasi avventura bellica (dalla guerra del Kosovo a quella di Libia)? Tra uno che auspicava la realizzazione dell'Impero, e uno che teme proprio l'imperialismo occulto, economico e politico, di Germania e Francia? Tra il fascismo che voleva l'Etiopia per fare della bella abissina una camicia nera, e uno che condanna l'immigrazione incontrollata non solo come un atto di irresponsabilità verso l'Italia, ma anche come una nuova forma di colonialismo occulto?
Se vogliamo brevemente toccare la questione religiosa, anche qui le differenze tra il fascismo e l'attuale centrodestra sono siderali. Mussolini, infatti, nel 1922 è un ateo anticlericale, circondato da laicisti violenti come Roberto Farinacci e Italo Balbo, che non rivendica mai una sua appartenenza religiosa tradizionale, ma che, per opportunismo, cerca il placet delle gerarchie per scalzare il Partito popolare, laddove oggi a ricercare e ad ottenere l'appoggio di quelle stesse gerarchie post Benedetto XVI e post Ruini, sono coloro che sino a ieri attaccavano ogni giorno la Chiesa e le sue presunte «ingerenze» (esattamente come il duce sino al 1921) e che però, nel contempo, lottano per aborto, utero in affitto, droga libera, cancellazione della tradizione religiosa popolare ecc… Per concludere, se proprio vogliamo trovare, nei tempi recenti, una qualche lontana somiglianza con i fatti del 1922, bisogna riandare ai governi Monti e Renzi.
Partiamo dal primo. Mussolini nel 1922 ricevette l'incarico dal re, pur essendo appena entrato in Parlamento e pur avendo solo una micropattuglia di 35 deputati: ciò avvenne soprattutto a causa della debolezza dei partiti e dei due governi Facta, incapaci di affrontare il momento difficile.
Con Monti le cose non sono andate tanto diversamente: un presidente della Repubblica comunista, con poteri quasi monarchici assunti grazie alla debolezza dei partiti e all'eccezionalità del momento, ha nominato senatore a vita e poi premier, dall'oggi al domani, un uomo che non aveva alle spalle né un partito né un'elezione! Con Monti, come con Mussolini, non abbiamo assistito ad un vero e proprio colpo di Stato, perché entrambi sono stati eletti dall'autorità competente a farlo, ma certamente abbiamo vissuto un vulnus alla democrazia, che prevede che il governo spetti a chi ha i voti nel Paese.
Quanto a Renzi, non è stato proprio lui, il segretario fiorentino del Pd, quello che recentemente ha cercato di diventare l'«uomo forte», il dominus del Paese, l'uomo solo al comando, attraverso una riforma costituzionale che anche molti giuristi e politici di sinistra hanno considerato eversiva per la sua volontà di rafforzare oltremodo i poteri dell'esecutivo? Hanno dunque diritto gli eredi del Pci, i seguaci di Renzi, le truppe di Beppe Grillo di ripetere accuse infondate e infamanti verso l'avversario politico al solo scopo di delegittimare qualsiasi opposizione?