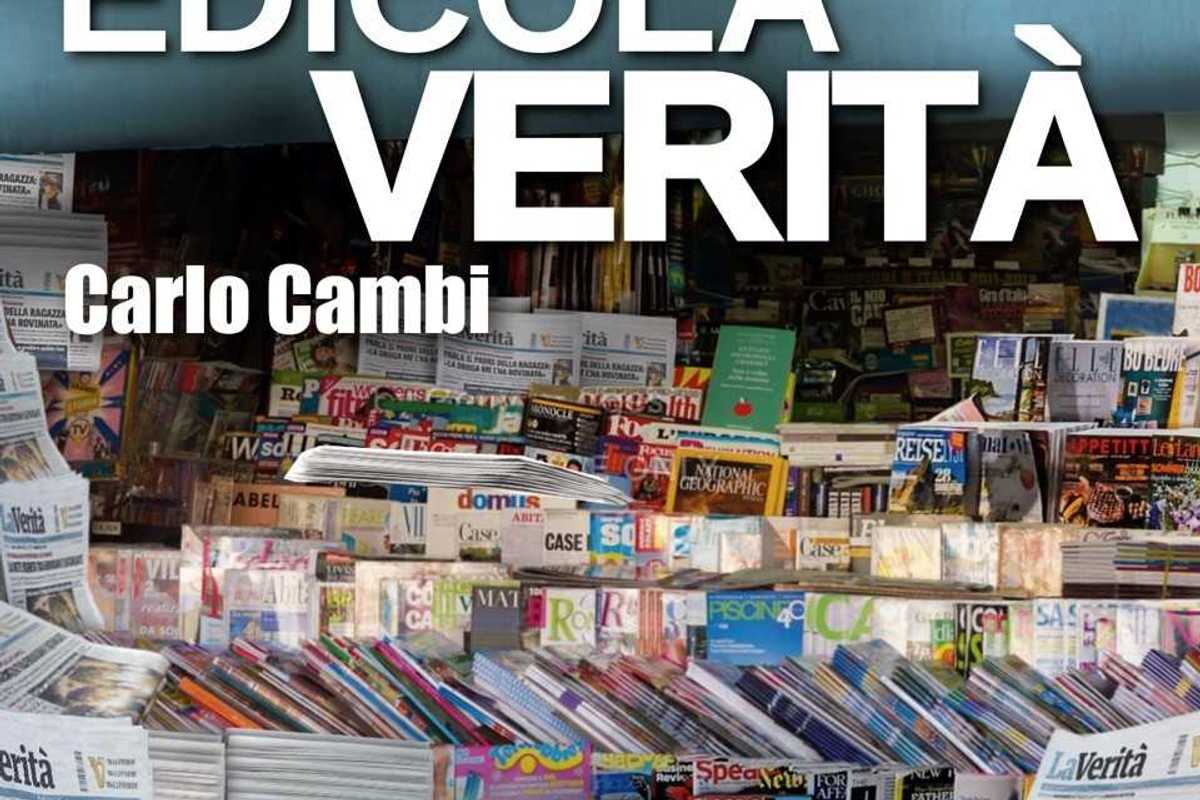Ciclicamente ritornano le grandi battaglie progressiste sui diritti fondamentali. Tra queste una di particolare efficacia e urgenza: la lotta per avere più vie con nomi di donne. Ieri Concita De Gregorio su Repubblica ha suonato la carica, spiegando che «la geografia dei luoghi costituisce la nostra identità. Il riconoscimento, l’importanza che si assegna a qualcuno che abbia fatto la storia entra nel nostro lessico quotidiano e determina immaginazione, possibilità, identificazione. Se togli le donne, dai nomi delle strade, le togli dalla scena pubblica. Non dai alle bambine la possibilità di pensare che potrebbero esserci loro, un giorno». Dunque basta con piazza Cavour, meglio piazza Tina Anselmi. Concita ha enunciato anche i criteri di selezione delle italiane illustri: «Madonne escluse. Niente Maria né sua madre Sant’Anna. No sante. No martiri. No regine madri di re. Anche di queste ne abbiamo. Donne che non siano morte vergini martoriate, giovanissime vittime santificate, madri sorelle figlie vedove di eroi. Che non siano attributo di un uomo più celebre di loro, muse vestali custodi di memoria offesa. Anche di queste, sia detto con il massimo rispetto, ne abbiamo. Donne eccellenti in proprio, ecco: diciamo così. Laiche, se fosse possibile, per cambiare. Eccezionali a fare una cosa, capaci di cambiare il corso delle cose».
Non ci risulta molto chiara la ragione alla base dell’esclusione delle sante, che furono donne effettivamente eccezionali persino a prescindere dalla fede. E ci viene pure il dubbio che la fede politica abbia qualche peso nella scelta delle celebrità. Ad esempio, Norma Cossetto, giovane italiana infoibata, forse non potrebbe rientrare nell’elenco...
Comunque sia non ci sarebbero problemi ad avere più strade al femminile, magari sfruttando l’occasione per rimpiazzare qualche via intitolata a guerriglieri o macellai comunisti sparsa qui e là per l’Italia. Per altro la proposta non è nemmeno nuova: già nel 2021 il settimanale Vanity Fair ha lanciato un progetto intitolato La strada giusta, che voleva farsi «promotore di intestazioni al femminile di strade, piazze, corti e giardini». Fra le testimonial della campagna c’erano Ilaria Capua, Donatella Versace, Chiara Ferragni, Elodie, Vittoria Puccini, Ginevra Elkann, Lucia Annibali, Samantha Cristoforetti, Emma Bonino, Cathy Latorre e persino Luciana Lamorgese.
Come vedete, insomma, questa buona causa è parecchio gettonata. Del resto, come tutte le grandi battaglie progressiste odierne, è a costo zero o quasi: cambiare una targa costa nulla, di sicuro meno che staccare un assegno a una giovane madre. Anche per questa ragione proliferano imprese simili, e talvolta anche molto più assurde, tipo la proposta di Dario Franceschini di dare ai figli soltanto il cognome della madre. «Dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, stabiliamo che prenderanno il solo cognome della madre», ha spiegato il geniaccio del Pd. «È una cosa semplice e anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere». Al di là dell’ignoranza dei fondamenti giuridici della questione, la ratio di Franceschini è sempre la stessa: proviamo a fare bella figura senza scucire una lira e senza fare troppa fatica.
Solo che, mentre a sinistra s’inventano queste idee memorabili e a destra in troppi perdono tempo a prenderle in considerazione, la realtà disegna situazioni che vengono stupidamente ignorate. Si progettano strepitosi risarcimenti per le donne tramite intitolazione di vie o eliminazione del cognome paterno, eppure fra la popolazione maschile di questa nazione serpeggia un disagio potente e inascoltato, che ha trovato drammatica rappresentazione nelle pagine del rapporto Eurispes uscito qualche giorno fa. I pochi che se ne sono occupati hanno scelto di concentrarsi sul dato più conforme alla narrazione prevalente, cioè sul fatto che il 35,2%, riferisce di avere avuto paura «almeno una volta o qualche volta» della propria aggressività e che «una minoranza non trascurabile mostra una relazione più complessa con il proprio controllo emotivo: l’11,5% degli intervistati afferma di aver avuto frequentemente paura della propria aggressività, mentre il 2,8% riporta di provarlo regolarmente». Insomma, ci si è fermati alla superficiale questione della mascolinità tossica.
Il punto, tuttavia, è che secondo Eurispes il «quadro emerso è piuttosto equilibrato nel mettere in luce una maschilità in difficoltà, in bilico tra il desiderio di mantenere alcuni tratti della tradizione e la necessità di adattarsi a nuove sensibilità sociali. Da un lato rimane forte l’influenza dei canoni tradizionali, dall’altro si percepisce una crescente attenzione verso la sfera emotiva e il benessere psicologico. L’elemento della «tensione» è presente ovunque: gli uomini sembrano oscillare «tra il desiderio di rispettare le aspettative sociali e l’esigenza di esplorare modelli più flessibili». Non solo. Fra i maschi esiste la «sensazione diffusa di essere “messi in secondo piano” rispetto alle istanze femminili. Questo, se non tenuto in considerazione, potrà generare difensività e conflitto invece di contribuire a un dialogo costruttivo. La ricerca, in definitiva, suggerisce che la maschilità non è un monolite e risulta necessario un discorso «in cui gli uomini abbiano la possibilità di esprimere paure e aspirazioni senza incorrere in giudizi basati su archetipi rigidi».
Secondo Eurispes, «un tema particolarmente sentito è la percezione che si parli troppo poco della violenza femminile sugli uomini: il 48% degli uomini concorda con questa affermazione; tuttavia, poco più della metà del campione (52%) non percepisce questo come un problema centrale. L’idea che si debba parlare di femminilità tossica con la stessa frequenza con cui si discute di mascolinità tossica trova ampio consenso (58,9%), segnalando un’esigenza di bilanciare il dibattito sulle problematiche di genere». Circa il 16% degli intervistati dice di aver vissute esperienze di stalking.
Oltre la metà dichiara di non approvare le rivendicazioni femministe oggi molto rilanciate dai media. Quanto alle relazioni con le donne, «il 33% degli individui incontra difficoltà a esprimere le proprie emozioni e questo è più vero per i giovanissimi tra i 18 e i 24 anni di età che nel 44,5% dei casi riferiscono un disagio in maniera molto più marcata rispetto a tutte le altre fasce d’età».
Certo, si dirà che si tratta delle lagne di uomini refrattari al cambiamento, di un disagio percepito e non reale. Ma se le percezioni valgono per le inchieste sulla popolazione femminile dovrebbero valere anche per i maschi. In ogni caso, che una consistente parte della popolazione maschile si senta poco ascoltata e molto demonizzata è un problema non da poco, che di certo non giova alla costruzione di sane «dinamiche di genere».
Idee geniali come quella di Franceschini sui cognomi o campagne concretizzabili ma risibili come quella sulla toponomastica hanno tutte le carte in regola per peggiorare il quadro anziché migliorarlo. Svilire e stigmatizzare gli uomini, ridurli superficialmente a una massa di violenti oppressori e proporre non ben precisati «risarcimenti» non migliora la condizione femminile, in compenso peggiora quella maschile. Tra un insulto e l’altro, magari i maschi - specie i più giovani - si potrebbe anche ascoltarli. Si rischia di scoprire che, oltre alla mascolinità tossica, hanno addirittura qualcosa da dare e pensieri da esprimere.