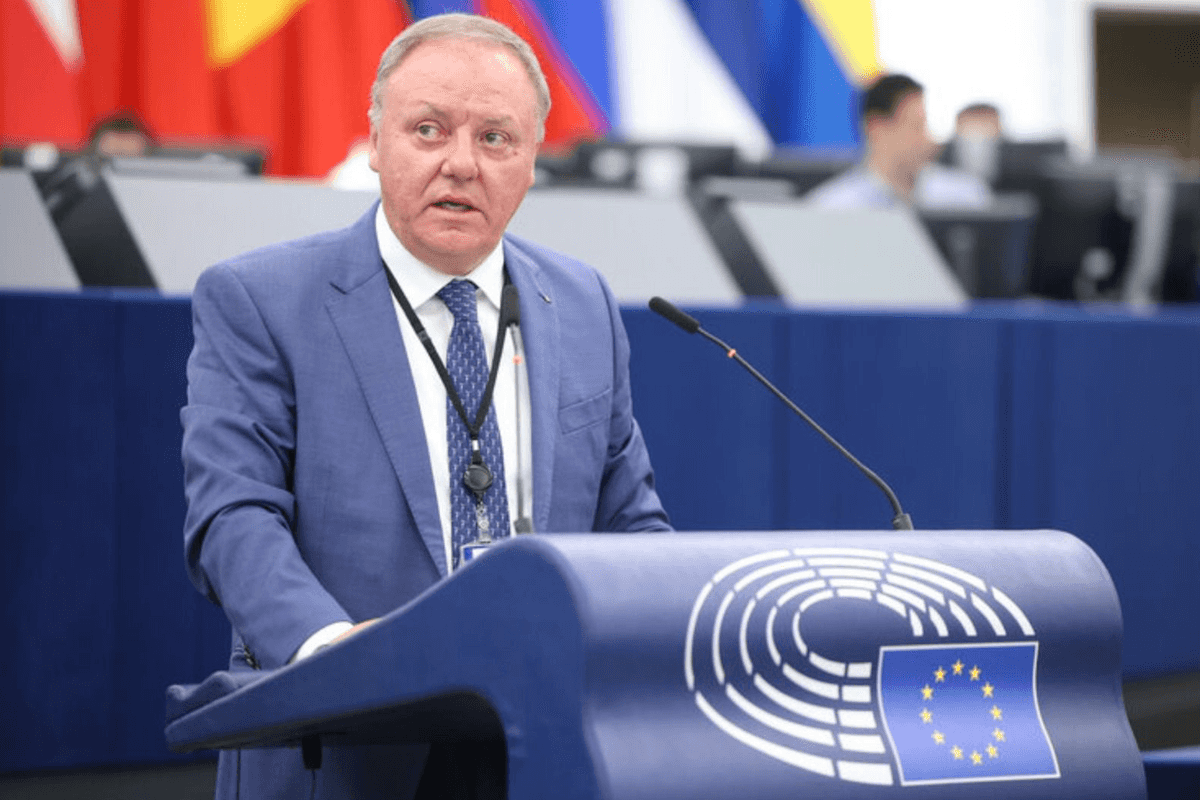L’esperienza della pandemia «ha lasciato ferite nella società e andrà metabolizzata col tempo. Ora è importante uscire da una comunicazione ansiogena, superare una politica sanitaria fondata sulle limitazioni e guardare avanti: la vita non può essere schiacciata sul problema del Covid». Il transumanesimo? «Più che un sogno, un incubo». A colloquio con il vescovo di Pavia, monsignor Corrado Sanguineti, che sull’ambientalismo imperante mostra «l’altra storia»: oggi presenta l’uomo come un problema, ma se egli usa bene la sua libertà e intelligenza, è una risorsa anche per l’ambiente.
«La pandemia ci ha messo tutti in crisi. E da una crisi non si può uscire uguali. O usciamo migliori, o usciamo peggiori», disse papa Francesco nel gennaio 2021. Ora possiamo fare un bilancio: come ne siamo venuti fuori?
«Aspetti positivi ma anche negativi hanno segnato il tempo della pandemia: tra i primi metterei le iniziative di soccorso e aiuto, e le tante esperienze di carità vissute. Ciononostante, il lascito è pesante: una società più sfilacciata e individualista; un disagio ancora diffuso, con forti ricadute a livello psicologico, tra i giovani; la sofferenza degli anziani, costretti a lunghi periodi di isolamento e solitudine. Anche le comunità cristiane escono segnate: sono mancati momenti di aggregazione e formazione e si è verificata una forte disaffezione alla vita liturgica. Come Chiesa non sempre abbiamo saputo dire parole nuove, diverse dal mainstream culturale, e forse abbiamo accettato troppo passivamente le restrizioni dei primi mesi sulla presenza alle celebrazioni. Soprattutto, non sempre abbiamo saputo toccare certi temi di fondo che proprio la pandemia ha rimesso in questione - il senso della vita e della morte, il significato della umana sofferenza, la domanda sul destino dell’uomo - e sui quali l’annuncio della fede porta una luce di speranza. Penso che adesso si debba uscire da una comunicazione ansiogena sul Covid e superare una politica sanitaria fondata sulle limitazioni e tarata solo sui vaccini, che ha creato attese esagerate e favorito divisioni e tensioni nelle famiglie, nelle relazioni sociali, negli ambienti di lavoro. È necessario anche riconsiderare certe posizioni, dando valore alle possibili forme di cura che ormai ci sono. Questa esperienza andrà metabolizzata col tempo; ora però è importante guardare avanti, nella consapevolezza che col virus dovremo ancora per un po’ convivere ma che la vita non può essere schiacciata sul problema del Covid».
Lei richiamava la necessità di parole nuove. Quali pronuncia la Chiesa sul rapporto tra l’uomo e il creato, oggi sovvertito in nome di un ambientalismo ideologico?
«Dal punto di vista culturale stiamo passando da un estremo all’altro: la modernità ha promosso una visione dell’uomo che si mette al centro del mondo e ne diventa artefice, e distorcendo il messaggio biblico ne ha fatto il padrone assoluto anziché colui che è chiamato a custodire responsabilmente il creato, come spiega il Papa nella Laudato si’. Da questo antropocentrismo sbagliato ora cadiamo nell’eccesso opposto: far diventare l’uomo un problema, laddove se usa bene la sua libertà e intelligenza egli è una risorsa anche per l’ambiente. Il bellissimo panorama delle colline toscane, ad esempio, è il frutto di una natura lavorata e antropizzata, dell’uomo che entra in un rapporto positivo con l’ambiente, cui si adatta e che adatta. Storicamente, una dimostrazione in tal senso viene anche dall’esperienza del monachesimo benedettino. Nell’affrontare il tema va però evitato il catastrofismo e una visione cupa del futuro, che stanno creando nei giovani ansia e sfiducia nella vita. E va promossa l’ecologia integrale, che include cura dell’ambiente, attenzione alla dimensione sociale e rispetto della natura umana, oggi troppo spesso violentata: penso alla manipolazione genetica o a certe pratiche che trasformano il generare in produrre».
A proposito: come proteggiamo l’uomo dall’ideache la società debba essere comandata da un uomo in camice bianco?
«Innanzitutto, riscoprendo quello che papa Benedetto chiama “l’orizzonte ampio della ragione”: la scienza è una forma di conoscenza molto preziosa ma non è l’unica né è in grado di esaurire il reale. Grazie alla tecnica può avere applicazioni assai positive ma non tutto ciò che è tecnicamente fattibile, ora o in futuro, deve essere fatto giacché alcune operazioni sulla realtà e sull’uomo alla fine si ritorcono contro l’uomo stesso. Uno sviluppo incontrollato e rapido, penso al digitale in continua evoluzione, che non si interroghi sul bene della persona e delle sue fondamentali esperienze - il nascere, l’amare, il vivere, il soffrire, il morire - rischia di generare un futuro sempre più disumanizzante. Ai camici bianchi dobbiamo molto, però la storia insegna che la medicina va pensata dentro a un quadro etico. La scienza è una risorsa ma non può diventare un idolo. Dare tutto in mano agli scienziati o ai medici senza porsi troppe domande di tipo morale, significa prepararsi a un domani espropriato della centralità dell’uomo».
Avanza invece un’ideologia che vorrebbe un uomo guidato e manipolato in vista di una sua «colonizzazione»: il transumanesimo. La prossima tappa vedrà la tecnica spogliare la persona della sua dignità?
«Certi romanzi e film di fantascienza che descrivono un mondo in cui l’uomo è robotizzato e controllato possono aiutarci a percepire la domanda fondamentale: che cosa vogliamo fare di noi stessi? Questo sogno del transumanesimo ha dentro di sé la pretesa dell’uomo di potersi reinventare da capo e di controllare il futuro; invece, va compreso che non c’è nulla di determinato, perché tutto passa attraverso la libertà dei soggetti, delle famiglie, dei popoli. Rispetto ad una prospettiva transumana, occorre allora incentivare luoghi di rinascita dove si possa sperimentare che essere una persona umana, con le sue risorse e i suoi limiti - l’invecchiamento, la malattia, la debolezza - non è un di meno ma la ricchezza che segna il nostro essere. Anzi, è proprio in quanto provocato dalla sua fragilità, che l’uomo ha affrontato certe sfide e le ha vinte. Chiunque resti fedele alla propria esperienza umana, al proprio cuore, non può non accorgersi che il sogno del transumanesimo, in realtà, è un incubo»