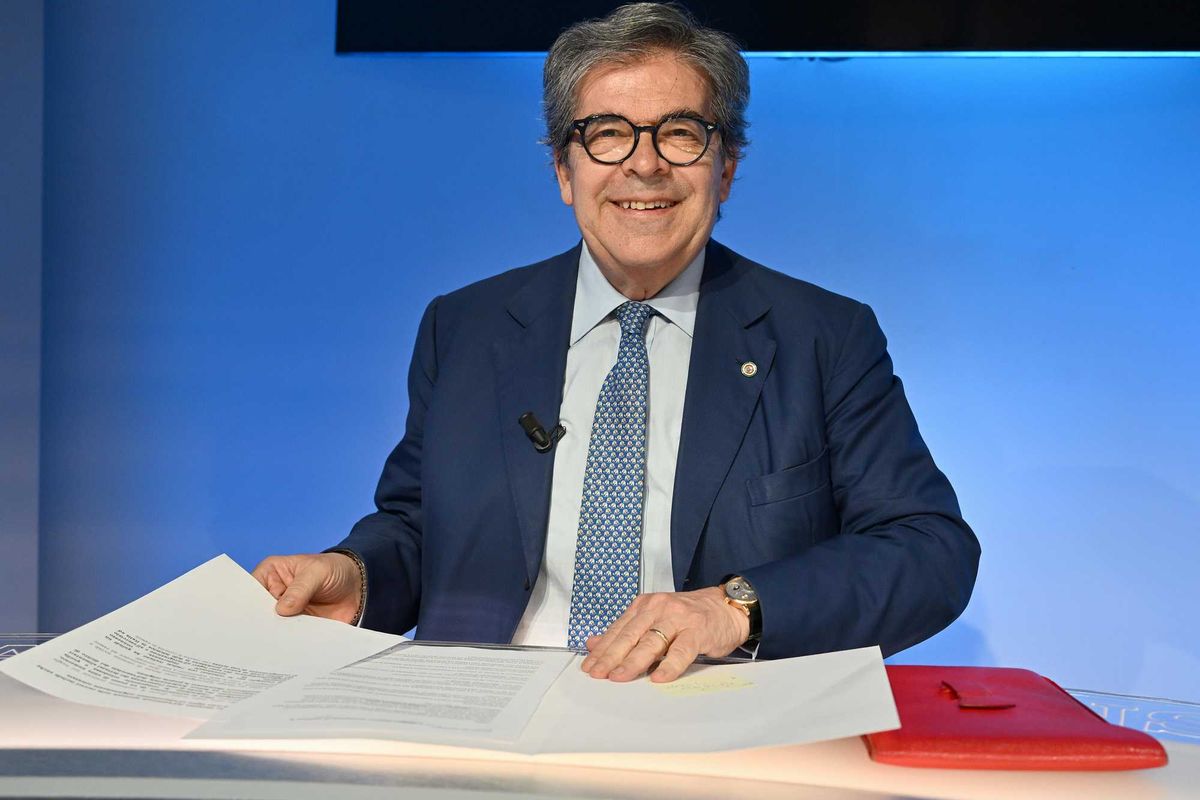Aveva invocato un nome super partes per il Quirinale. Eppure non si può dire che, proponendo Andrea Riccardi come suo candidato «ideale», Enrico Letta si sia rivelato il massimo della coerenza. Certo, c’è chi – soprattutto a sinistra – vorrebbe assimilare il fondatore della Comunità di Sant’Egidio a un tecnico o a un mero esponente della società civile. Ma la situazione è un tantino più complessa. Riccardi può infatti vantare alle sue spalle un network assai influente e certo non asettico dal punto di vista politico. Un network che, a prescindere dall’avanzamento o dal naufragio della candidatura dell’ex ministro del governo Monti, può ancora rivelarsi decisivo nella corsa al Colle, nei destini di Palazzo Chigi e forse nelle stesse stanze vaticane.
Iniziamo col rammentare che il primo a indicare il nome di Riccardi come papabile candidato al Quirinale sia stato il Richelieu piddino Goffredo Bettini, che – il 16 gennaio sul Corriere della sera – definì inoltre il fondatore della Comunità di Sant’Egidio di «enorme spessore umano, riconosciuto pure all’estero». È bene a tal proposito ricordare che, quando ad aprile scorso Bettini inaugurò la sua corrente, alla presentazione prese parte lo stesso Riccardi. Del resto non è forse un caso che, nel suggerirlo al Colle, Bettini abbia fatto riferimento anche al contesto internazionale. Eh sì, perché – a ben vedere – sia Bettini che Riccardi, in politica estera, sembrano accomunati da un sentimento di freddezza nei confronti di Washington. Era dicembre 2020 quando, durante un convegno online della Fondazione Italianieuropei, Bettini invocò una «terzietà» dell’Europa «per un equilibrio multipolare», sostenendo che il Vecchio continente avrebbe già pagato «ampiamente» il suo debito con gli Stati Uniti.
Ora, non è un mistero che, attorno alla Comunità di Sant’Egidio, si sia da tempo formato un blocco di politici e intellettuali favorevoli a una distensione tra l’Occidente e la Cina: un blocco non a caso assai bendisposto verso la controversa intesa tra Vaticano e Repubblica popolare, siglata nel 2018 e rinnovata nel 2020. Un’intesa che, nel settembre 2018, fu celebrata proprio da Riccardi sul Corriere: quello stesso Riccardi che, un anno dopo, presenziò alla presentazione de L’accordo fra la Santa Sede e la Cina. I cattolici cinesi tra passato e futuro. Un libro che, tra i curatori, annoverava la figura di Agostino Giovagnoli: esponente di spicco della Comunità di Sant’Egidio e membro del comitato scientifico dell’Istituto Confucio dell’Università Cattolica di Milano. A quella presentazione partecipò anche Romano Prodi che – piuttosto vicino a Riccardi e alla Comunità – non soltanto è un notorio sostenitore del dialogo tra Cina e Occidente, ma – a Bologna – ha di fatto dato la propria benedizione al movimento delle sardine insieme a un uomo legatissimo a Sant’Egidio, come il cardinale Matteo Zuppi.
L’apertura alla Cina è d’altronde stata fortemente auspicata anche nella conferenza Occidente e Cina: dialogo e collaborazione tra XX e XXI secolo: un simposio online, presieduto a settembre da Giovagnoli, che, tra gli ospiti, ha visto la ministra consigliera dell’ambasciata cinese, Zheng Xuan, e monsignor Claudio Maria Celli. Non solo: in apertura dei lavori, furono letti anche due messaggi di saluto, pervenuti dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Quel Parolin che è piuttosto vicino alla Comunità di Sant’Egidio e che, nell’ottobre 2020, difese a spada tratta l’accordo tra Santa sede e Cina dalle critiche dell’allora segretario di Stato americano, Mike Pompeo. Parolin è tra l’altro presidente dall’associazione Villa Nazareth. Realtà, questa, a cui è legato monsignor Celli, che fu stretto collaboratore del defunto cardinale Achille Silvestrini: presidente della Fondazione Sacra Famiglia di Nazareth, protagonista della Ostpolitik vaticana, freddo verso la Cei di Ruini e considerato il mentore di Giuseppe Conte (che a Villa Nazareth era a sua volta legato). Vale a tal proposito forse la pena ricordare che il grande fautore e tessitore dell’alleanza giallorossa fu Bettini. E che il governo Conte bis, retto da quell’alleanza, si è contraddistinto per una linea politica di forte avvicinamento alla Repubblica popolare: una sterzata filocinese, che si è raffreddata soltanto dopo l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il network di Sant’Egidio trova quindi i propri riferimenti coesivi su vari piani: l’alleanza giallorossa a livello politico; il terzomondismo a livello ideologico; la distensione con la Cina a livello internazionale. Non è forse un caso che la candidatura di Riccardi sia stata immediatamente respinta proprio da Matteo Renzi.
Nel centrosinistra, né il senatore fiorentino né probabilmente l’area più atlantista del Pd apprezzano troppo un nome così sbilanciato verso la Repubblica popolare. Un nome che a Washington verrebbe prevedibilmente guardato con preoccupazione.
La candidatura di Riccardi non è quindi affatto super partes, ma denota un’area politica ben precisa, oltre che una collocazione internazionale particolarmente problematica: una collocazione che rischierebbe seriamente di allontanare l’Italia dalla sfera atlantica. È bene quindi fare molta attenzione, perché – al di là della candidatura quirinalizia di Riccardi in sé stessa – il network che la sostiene è molto influente e potrebbe avere voce in capitolo su altri nomi e su altre partite. La sintonia tra Quirinale e Casa Bianca è essenziale per la nostra politica estera. E di questo i grandi elettori devono tenere conto.