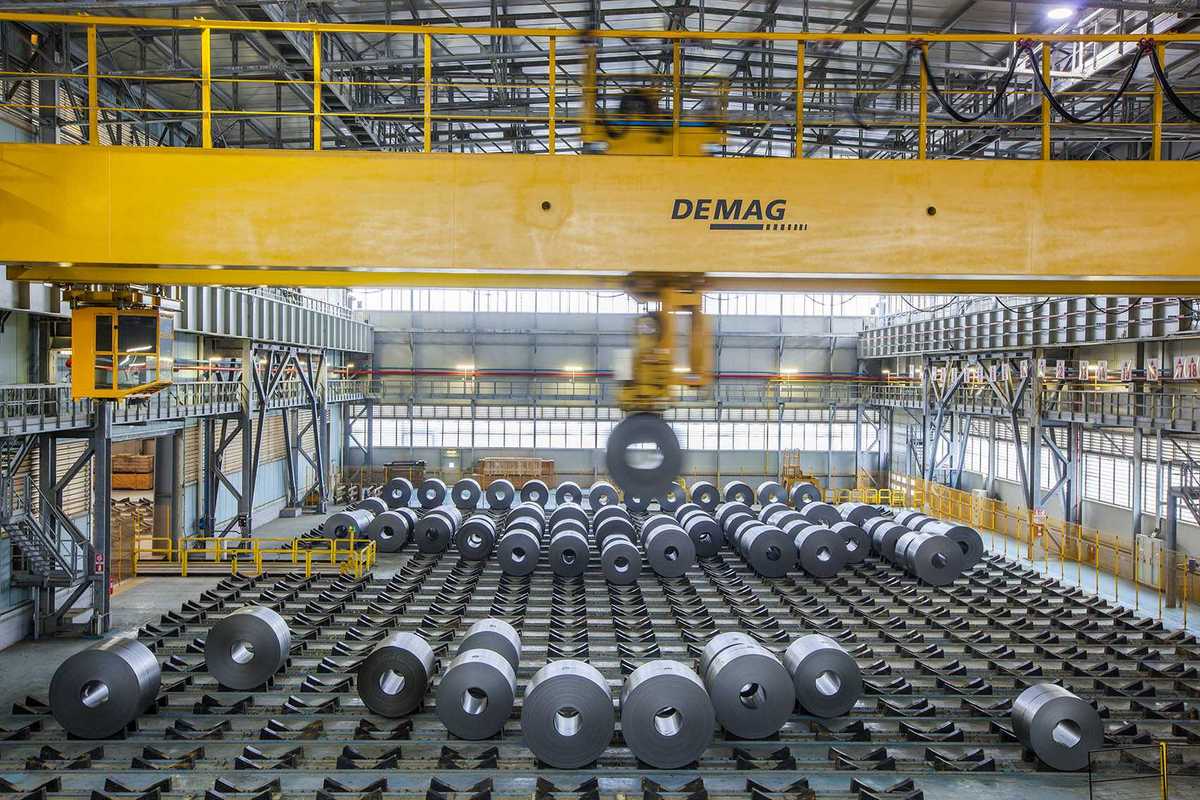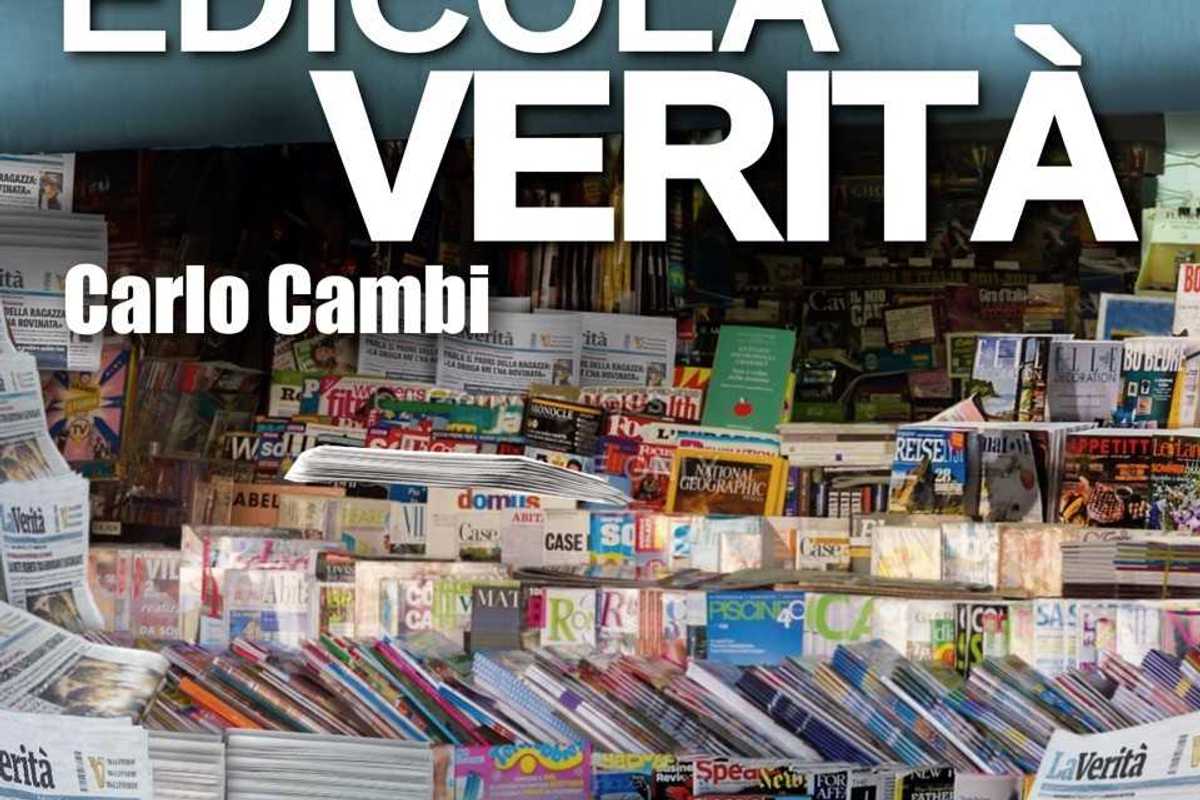«T’amo, o pio bove; e mite un sentimento/ di vigore e di pace al cor m’infondi,/ o che solenne come un monumento/ tu guardi i campi liberi e fecondi// o che al giogo inchinandoti contento/ l’agil opra de l’uom grave secondi», scriveva Giosuè Carducci nel famoso sonetto Il bove, celebrazione dell’animalesca forza dello statuario bovino, sodale dell’uomo che prima lo aiuta nella coltivazione del campo e poi lo sostiene con le sue nutrienti carni macellate e cucinate. In precedenti redazioni, l’incipit del componimento era «Amo, o solenne bue»: usava il sostantivo più diffuso, dopo «manzo», per identificare l’animale.
Con «carne di manzo» intendiamo genericamente la carne dei bovini allevati per uso alimentare, in particolar modo il bue domestico che poi sarebbe il toro, ma solo un certo tipo di toro. Insomma, dietro la parola «manzo» c’è un vero e proprio mondo. La specie è una, Bos taurus, e i differenti nomi dipendono da età, sesso e funzioni. Il toro è il maschio adulto e fertile utilizzato per l’accoppiamento con giovenche anche dette manze o scottone (femmine tra 1 e 3 anni che non hanno ancora mai partorito) e vacche (femmine adulte già riprodotte). Finché è cucciolo (sia maschio sia femmina) di età inferiore ai 10 mesi si chiama vitello, dopo, il maschio giovane - non ancora maturo sessualmente - e castrato si chiama vitellone. Vitello e vitellone hanno carni molto apprezzate e non giungono all’età adulta. Che è invece quella del manzo, ossia il maschio castrato di età tra 2 e 4 anni. C’è poi la freemartin, femmina sterile e androgina, frutto di parto gemellare con gemello che di contro è perfettamente fertile, dalla grande forza e perciò usata anch’essa per il lavoro nei campi laddove i buoi lo siano ancora.
Come nei versi di Carducci e come è sempre stato prima della meccanizzazione agricola, infatti, i buoi, forti tori resi mansueti dalla castrazione, erano anche una forza motrice. Col giogo fissato al collo o al garrese (la regione del tronco all’altezza delle prime vertebre dorsali), attaccato poi all’aratro, i buoi rivoltavano le zolle di terra e tracciavano i solchi nei quali il contadino avrebbe seminato. Quando il giogo veniva attaccato al carro invece che all’aratro, il bue diventava una forza motrice altrettanto utile per la dura vita del contadino-allevatore d’un tempo. Oggi che per noi i bovini sono quasi esclusivamente animali da allevamento e non più da soma, i gioghi e anche gli aratri vengono venduti su Internet come reperti antichi o addirittura storici, ma questa fine dell’era del toro lavoratore non ha intaccato l’altro suo ruolo, cioè la centralità dei buoi nell’alimentazione e nella produzione alimentare.
Anche le deiezioni bovine (dette letame o liquame) un tempo erano considerate semplice e prezioso concime, per via del contenuto di elementi utili al terreno come l’azoto (necessario alla crescita delle colture). Ma negli ultimi anni gli attivisti vegani hanno messo sul banco degli imputati anche il biochimismo digestivo dei bovini (e degli altri animali allevati per l’alimentazione): insieme con molti altri aspetti relativi agli allevamenti, questi ultimi vengono raccontati come mera causa di inquinamento e spreco di risorse ambientali. Gran parte del movimento ecologista vorrebbe sostituire tout court la normale carne coi burger di vegetali e insaporitori al gusto carne, un nuovo e redditizio mercato.
Nonostante questi continui attacchi, tuttavia, la norma onnivora continua a restare tale: carne rossa per eccellenza, la carne di manzo è la terza più mangiata al mondo dopo quella di maiale e quella di pollo, entrambe favorite, nel superare il consumo del manzo, dal costo inferiore.
In Italia acquistiamo mediamente 79 kg di carne l’anno. È una delle cifre più basse d’Europa (109,8 kg i danesi, 101 kg i portoghesi, 99,5 gli spagnoli, 85,8 i francesi, 86 i tedeschi e ben 222,2 gli statunitensi). Di quei 79 kg pro capite, circa 20 sono di carne bovina. Pensate che nel 1961 acquistavamo 27 kg totali di carne bovina, suina e pollame. Gli anni Sessanta e il boom economico, con l’aumento della popolazione e il miglioramento delle condizioni di vita, videro aumentare la produzione di carne, in particolar modo bovina, il cui consumo è direttamente proporzionale al benessere: più una nazione si arricchisce, più carne bovina mangia.
Però vale anche l’inverso: più una nazione si impoverisce, meno carne bovina mangia. E così, se nel 1981 l’acquisto di carne suina era di 25,17 kg pro capite e quello di bovina 25,88 kg, nel 2000 iniziavamo ad abbandonare la parità suino-bovina acquistando 37 kg di suino, 25 di bovino e 18 di pollo. Abbiamo mantenuto stabile il consumo di bovino perché lo amiamo, ma abbiamo aumentato il consumo di carne meno cara e così abbiamo continuato a fare negli anni successivi, tanto che ora la classifica dei consumi vede il manzo al terzo posto. La carne bovina, però, continua a essere uno status symbol alimentare. Non è un caso che, nell’epoca di globalizzazione che stiamo ancora vivendo, sul nostro suolo siano improvvisamente diventate «luxury food» carni di manzo prelibate e lontane come quelle giapponesi di Wagyu. La parola «Wa» vuol dire Giappone e «gyu» vuol dire bovino. Quindi «Wagyu» significa bovino giapponese ed è un termine generico che si riferisce alle principali quattro razze di bovini giapponesi: Japanese black, Japanese brown/red, Japanese shorthorn e Japanese polled. È Wagyu anche il famoso manzo Kobe (la regola che è anche un po’ un gioco di parole è: tutto il manzo Kobe è Wagyu, ma non tutto il Wagyu è Kobe).
dal Giappone a Rovigo
La carne di Kobe più diffusa è quella di manzo di razza nera giapponese della città di Kobe, capitale della regione di Hyogo dove l’animale deve essere nato. Tajima è il vecchio nome della provincia che è l’attuale prefettura di Hyogo e anche dicendo Tajimagyu, cioè manzo di Tajima, si identificano questi bovini che sono allevati anche intorno a Kobe e in altre regioni giapponesi. Per essere Kobe beef la carne deve corrispondere ai criteri di un severo disciplinare di pedigree, allevamento e macellazione. Il Kobe può costare anche 1.000 euro al chilo (persino il Kobe meno pregiato non scende mai al di sotto dei 100 euro, più o meno il triplo del costo del miglior taglio di manzo della Gdo da mangiare, per esempio, in tartare). Se la carne non è abbastanza marezzata, non sarà classificata come Kobe beef ma come Tajima beef.
Per accontentare chi cerca nel Kobe non soltanto la giapponesità, alcuni allevatori hanno effettuato un’operazione di italianizzazione della produzione di Kobe che neutralizza la concorrenza giapponese: il foodie italiano vuole il Kobe? Diamoglielo italiano! Ca’ Negra a Loreo (Rovigo) ha iniziato ad allevare, per primo in Italia nel 2009, il Domestic Wagyu (si chiamano così i bovini che sono geneticamente Wagyu ma sono allevati fuori dal Giappone), acquistando embrioni perché allora non si potevano ancora importare direttamente i capi già nati. In quest’ultimo modo si è procurato invece i suoi Dw Stefan Rottensteiner nel 2012, portando nel maso di famiglia Oberweidacherhof sul Renon (Alto Adige) i suoi primi esemplari di manzi Wagyu. La carne di Kobe è percepita come più rustica e selvatica, innanzitutto per via della marezzatura, una delle caratteristiche più evidenti delle fettine sottilissime (si usa bollirle nel piatto giapponese denominato shabu shabu) oppure belle spesse (che si scottano come una bistecca alla fiorentina) di Wyagu. La marezzatura è una abbondante distribuzione intramuscolare di grasso che si scioglie in cottura (anche a bassissima temperatura), offrendo una texture considerata molto più vera rispetto alle carni di allevamento industriale.
In realtà, fatta salva la nostra industria che non ha nulla da imparare, anzi forse può insegnare ad altre, non c’era bisogno del Giappone per ricordare o sapere che esiste anche l’allevamento old style: siamo allevatori magistrali e abbiamo razze leggendarie.
Emblema di qualità
Ci sono la vacca podolica calabrese e quella sardo-modicana al Sud, al Nord la grigio alpina, la piemontese o fassona, la romagnola, la modenese e la rossa reggiana (erano 140.000 negli anni Cinquanta e poi sono state sostituite con razze olandesi più adatte alla mungitura meccanica, ma ora se ne sta recuperando l’allevamento, fateci caso e vedrete anche nella Gdo il parmigiano reggiano con latte di vacche rosse), al centro la chianina, la maremmana e la marchigiana.
Il manzo è emblema di qualità e ciò deriva dalla qualità nutrizionale delle sue carni. La carne di manzo si suddivide in base ai quarti: dopo la macellazione, l’animale viene diviso in due quarti anteriori e due posteriori, che a loro volta vengono suddivisi in altri tagli per specifici consumi, mentre le frattaglie, che comprendono gli organi e altre parti come testa e zampe, costituiscono il cosiddetto «quinto quarto». In Corea si arriva fino a 120 tagli, noi italiani effettuiamo 19 tagli e poi ulteriori sottotagli. Facendo riferimento a 100 grammi di carne per esempio di filetto (dalla lombata, una delle 19 aree tagliate, si ottiene il filetto, il controfiletto o roastbeef, il carré cioè costolette e nodini), abbiamo 324 calorie, 25 g di grassi, 85 mg di colesterolo (quasi un quarto del massimo da assumere giornalmente dal cibo, pari a 300 mg, da diminuire in caso di patologie cardiovascolari o elevata predisposizione), 24 g di proteine, 0 carboidrati (e quindi 0 fibra e 0 zuccheri), poi 57 mg di sodio, 331 mg di potassio, 22 mg di magnesio, 9 mg di calcio e 3,1 mg di ferro. Proteine animali di cui non possiamo fare a meno, il manzo in quanto carne rossa ci offre anche tanto ferro.
Approfondiamo. Mentre i vegetali forniscono soltanto ferro non eme, la carne (compresa quella di pesce) fornisce ferro eme e ferro non eme e la carne rossa, di cui il manzo è il re, ne fornisce più delle altre. L’intestino può assorbire tra il 2 e il 10% del ferro contenuto nei vegetali e dal 10 al 35% di quello presente nelle carni. Perciò è importante mangiare carne ricca di ferro, per quel ferro eme che dipende dalla presenza di emoglobina (per questo la carne lo ha e una carota no). Il ferro eme è circa il 50% del totale ferroso della carne, il resto è ferro non eme, che a sua volta si sdoppia in ferro bivalente (Fe2+) e trivalente (Fe3+) e che troviamo anche nei vegetali. Nella carne, il bivalente è più facilmente assorbibile del trivalente rispetto a quanto lo sia nei vegetali. La sostituibilità della carne con le verdure è molto discutibile, come si vede, e ricordiamoci che l’abbinamento con alcune sostanze come l’acido ascorbico (la vitamina C) e l’acido citrico (che si trova anche nei tessuti animali, oltre che negli agrumi) aiuta l’assorbimento intestinale di ferro non eme: ecco spiegato il motivo scientifico ante litteram di tanti connubi tra carne (anche di pesce) e limone o arancia. Si dice che la carne rossa del manzo «faccia sangue» e in effetti è vero: l’assorbimento del ferro è direttamente proporzionale alle necessità di sintesi di nuovi globuli rossi. Se le persone sane assorbono il 10% del ferro alimentare, chi ne è carente, cioè è anemico, ne assorbe fino al 20-30%.
La vitamina B12
Una dieta con ridotto apporto di ferro come è quella povera o priva di carne e ricca di cereali e verdure è una delle cause dell’anemia, cioè la riduzione dei globuli rossi nel sangue e la conseguente diminuzione della capacità di distribuzione dell’ossigeno a organi e tessuti (a questo servono innanzitutto i globuli rossi), con conseguenti stanchezza, difficoltà di concentrazione e memoria, calo delle difese immunitarie, problemi di termoregolazione e disturbi gastrointestinali. Un altro apporto importantissimo della carne di manzo è la vitamina B12. Si tratta di una vitamina fondamentale, coinvolta nella produzione dei globuli rossi, nel corretto funzionamento del sistema nervoso nell’adulto (e dello sviluppo del sistema nervoso nel feto durante la gestazione), nella formazione del midollo osseo e nel metabolismo degli amminoacidi. Ed è questo il principale motivo per cui un vegetariano o vegano che non la assuma nemmeno in forma di integratori può incorrere in seri problemi di salute. Troviamo la B12 in uova, latticini, pesce e… carne. Ne sono ricche innanzitutto le interiora (il quinto quarto): 100 g di fegato di manzo forniscono addirittura il 990% della razione giornaliera raccomandata di vitamina B12. Una bistecca di manzo intorno ai 200 grammi ne fornisce il 200% e, in più, ci regala anche la stessa percentuale di dose giornaliera raccomandata delle vitamine B2, B3 e B6, oltre al 100% della dose giornaliera raccomandata di selenio e zinco.
Il dizionario online dei modi di dire del Corriere della Sera spiega che «popolo bue» fa riferimento a «la gente intesa come massa acritica, facilmente manipolabile o anche remissiva, sottomessa, che si piega senza ribellarsi così come fa il bue che si lascia aggiogare facilmente». Smettiamola di usare il bue come riferimento negativo e (re)impariamo a rispettarlo come faceva il Carducci.