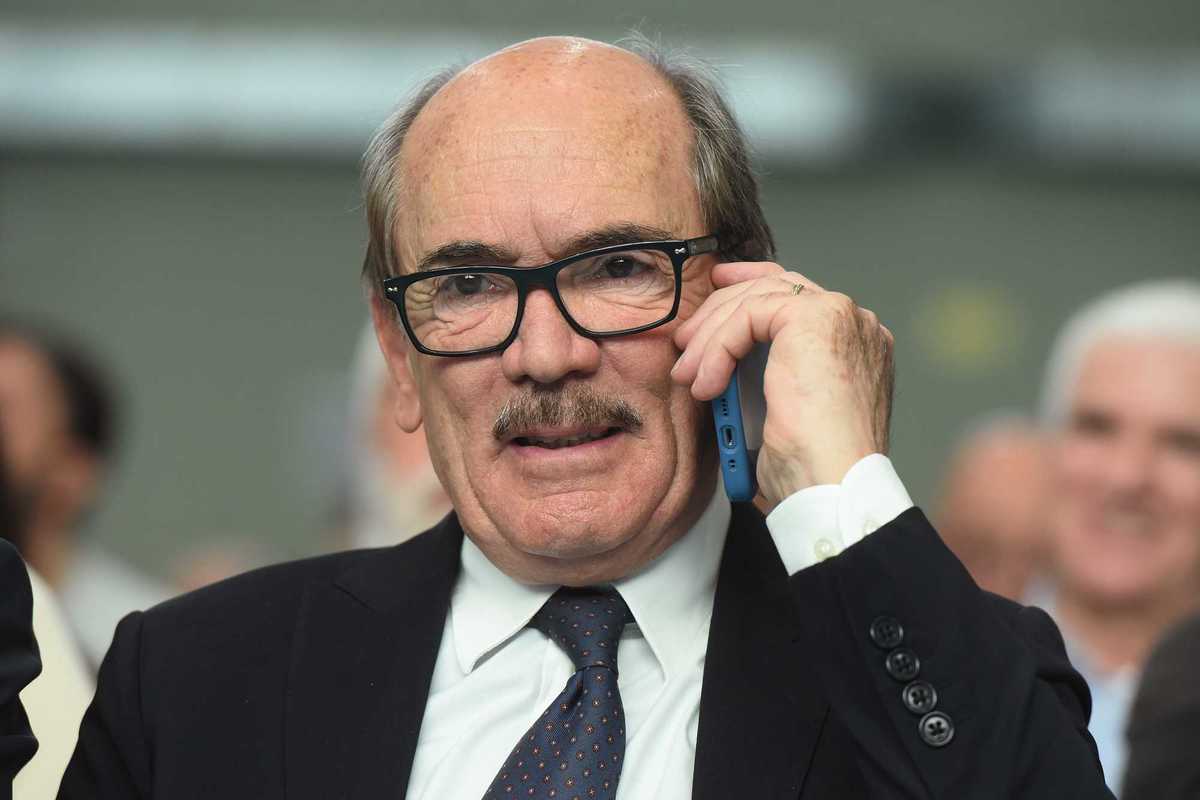In Italia i fiori compaiono a giugno e il frutto è maturo in agosto e settembre. Perfette per i mesi più caldi: aiutano a riparare la pelle danneggiata dall’esposizione ai raggi solari, grazie all’acido ellagico di cui sono ricche.
Vi siete mai chiesti se si dice «mora di gelso» perché oltre alle canoniche more esistono more di altra provenienza? La risposta è sì. Ciò che chiamiamo solitamente mora è il frutto del dell’arbusto del rovo. Poi, c’è il frutto dell’albero del gelso cioè la mora di gelso che a volte è chiamata semplicemente gelso. Può capitare anche di sentir chiamare mora la mora di gelso oppure di vedere specificata la mora canonica chiamandola «mora di rovo». Il frutto del gelso è un’infruttescenza sarebbe a dire un insieme di acheni, ognuno è un frutto che nasce da un fiore distinto. Il frutto del rovo è, invece, un frutto multiplo formato da piccole drupe, ognuna delle quali deriva da uno dei tanti pistilli di un solo fiore, una polidrupa. La mora di gelso, poi, appartiene al genere Morus, la mora di rovo al genere Rubus (genere al quale appartiene anche il lampone e una simpatica differenza tra mora e lampone è che quando si raccolgono le more il ricettacolo, cioè l’ultimo tratto del peduncolo dal quale originano le parti fiorali, resta attaccato al frutto, nel caso del lampone rimane sul ramo). Andiamo a conoscere meglio la nostra mora di rovo. Rubus L., 1753 è un genere di piante appartenenti alla famiglia delle Rosaceae, la specie è Rubus ulmifolius (sono sinonimi Rubus rusticanus, Rubus discolor e Rubus amoenus): rubus dal latino ruber, rosso, con probabile riferimento alla forma ancora acerba della mora o al colore definitivo del lampone, altra specie, come abbiamo visto, ma stesso genere). E ulmifolius dal latino ulmus, olmo e folia, foglia, perché le foglie del rovo rassomigliano a quelle dell’olmo.
cestino tra i rovi
Diciamolo. Raccogliere le more dal rovo con un bel cesto, passeggiando in estate in montagna, in collina, ma anche in pianura, è una bellissima esperienza, anche di shinrin-yoku, l’arte giapponese di immergersi nella natura. E incappare in rovi di more è molto più facile di quanto si pensi, essendo il rovo una pianta perenne, con sistema radicale perenne, a produzione biennale, quindi basta sapere dove sono i rovi e ci si può tornare tutta la vita, non solo in campagna, anche in città. Il rovo di more è una pianta decisamente «espansionista», pensate che quando i tralci di questa arbusto spinoso tanto prolifico toccano terra poi vi si radicano, trasformando appezzamenti anche ampi in veri e propri roveti, cioè macchie di rovi.
Nella nostra cultura occidentale (la religione cattolica vi appartiene e la sostanzia, potentemente, anche se non se ne è fedeli), il roveto ha una declinazione anche sacra: nel Libro dell’Esodo della Bibbia, un angelo si posa su un roveto, poi da quel roveto la voce del Signore si rivolge a Mosè incaricandolo di condurre gli Israeliti dall’Egitto verso la Cananea. Il roveto biblico è detto «roveto ardente» perché era in fiamme, ma non si consumava: una metafora perfetta per questo arbusto effettivamente indistruttibile.
La diffusione dei rovi in campagna è favorita anche dal fatto che tanti animali che brucano, per esempio i cervi, amano mangiare le foglioline dei rovi, ma tanti altri, come piccoli uccelli, volpi rosse e orsi bruni preferiscono mangiare le more e poi ne disperdono i semi attraverso le feci. Si chiama dispersione endozoica - cioè attraverso l’interno dell’animale - ed è un tipo di zoocoria che trasporta i semi anche molto lontano dall’ubicazione della pianta originaria. La capacità di attecchire del rovo è talmente alta che talvolta è considerata un’infestante, in virtù del fatto che si diffonde rapidamente e non si eradica facilmente, pensate che né il taglio, né l’incendio, né i diserbanti sono risolutivi. Né la siccità: la nostra è una pianta eliofila che non tollera molto l’ombra degli alberi e perciò sgomita per sottrarsi alla loro ombra e stare al sole senza riparo.
Ecco perché la troviamo spesso lungo sentieri e strade. Tuttavia, la mora di rovo non è più un’esclusiva spontanea. Si trovano facilmente confezioni di more fresche anche nel supermercato più ordinario e semplice della Gdo e ciò, in fondo, permette di apprezzarle anche se non si può andare a raccoglierle scarpinando in ameni siti naturali. Una caratteristica dei rovi di more selvatici sono le spine. Esse si iniziano a sviluppare tra il primo e il secondo anno di vita della pianta: nel primo anno la pianta sviluppa un fusto, detto primocane, che cresce fino a 9 metri, con tralcio che non fa fiori. Poi, nel secondo anno, il primocane muta in floricane, si espande solo per orizzontale con cacchi fiorenti e, appunto, le spine. Le specie coltivate non hanno spine e addirittura si è riuscito ad ottenere primicani che già fruttificano nel primo anno di vita, onde adeguare i tempi della produzione agricola a quelli della produzione contemporanea di stampo industriale, molto più fast.
varietà senza spine
Il miglioramento delle specie, però, non riguarda solo la contemporaneità: una varietà di more senza spine data al 1921. I roveti sono spesso usati come antagonisti di parassiti di altre colture, come le viticole, o per delimitare corridoi o recinti per animali, oltreché proprietà private, costituendo una specie di fitto muro spinoso impossibile da penetrare.
Con la mora si preparano tradizionalmente vini e cordiali, documentati addirittura dalla London Pharmacopoeia già nel 1696: il Brombeergeist, per esempio, è un liquore tedesco della Foresta Nera e in Italia si preparano liquori detti «morelli», sulla scia del nome del limoncello, ma anche ratafià di more. Il nostro piccolo frutto è anche protagonista indiscusso di torte, confetture, composte e gelatine. Della mora, un po’ come facciamo con la fragola, mangiamo anche i semini, che, oltre che di proteine e fibre, sono ricchi di omega 3, omega 6, carotenoidi, ellagitannini e acido ellagico. Per quanto riguarda la mora intera, questo frutto è verde appena spunta, rosso prima di maturare e nero a maturazione completa, caratteristica che ha dato luogo al proverbio «Le more sono rosse quando sono verdi». La mora ha 43 calorie ogni 100 grammi. Di questi 100 grammi, quasi 89 sono di acqua, poi abbiamo circa 10 grammi di carboidrati, 1,4 grammi di proteine e 0,5 grammi di grassi. Anticamente, popoli europei come quello greco o anche i nativi americani, che facevano corde coi tralci dei rovi e usavano d’abitudine i rovi per delimitare aree di allevamento anche grazie al già citato naturale effetto dissuasore delle spine, usavano altre parti della pianta a scopo precisamente terapeutico: le foglie per un tè utile a curare la pertosse, le radici per curare diarrea e dissenteria. Ciò che si fa anche oggi: grazie al tannino e all’acido gallico, un antibiotico naturale, l’infuso di foglie di more contrasta la diarrea, l’ulcera della bocca e il sanguinamento gengivale. Quanto al frutto, si usava come cura per lo scorbuto in virtù del suo contenuto di vitamina C e per le ulcere allo stomaco. Oggi, isolando 3 nuovi antroni alla parte aerea di Rubus ulmifolius, rubantrone A, B e C, si è scoperto che il rubantrone A esercita attività antimicrobica nei confronti dello Staphylococcus aureus.
da acido a dolce
In Italia i fiori di mora compaiono a giugno e il frutto è maturo in agosto e settembre: se vi capita davanti qualche rovo, ora vedrete le more ancora piccine e verdi. Il gusto delle more muta da acido a dolce man mano che esse maturano. La presenza delle more in estate rende questi deliziosi frutti di bosco complici perfetti per contrastare problematiche tipiche della stagione. Le more, infatti, aiutano a riparare la pelle danneggiata dall’esposizione ai raggi solari, grazie all’acido ellagico di cui sono appunto una fonte generosissima. Si tratta di un polifenolo antiossidante che oltre ad aiutare la pelle a riprendersi dal danno solare, ostacola la disgregazione del collagene, la struttura di sostegno della pelle la cui produzione diminuisce con l’età. L’acido ellagico ha dimostrato anche proprietà antitumorali perché blocca lo sviluppo delle cellule malate. Il colore blu-violaceo, quasi nero, delle more è determinato dagli antociani, antiossidanti che combattono i radicali liberi e sono anche efficaci contro ipertensione, diabete, abbassamento della vista e declino cognitivo. Le more, poi, aiutano l’intestino grazie al contenuto di fibre solubili e insolubili, che stimolando l’eliminazione delle tossine dall’intestino hanno un effetto disintossicante utile nei cambi di stagione come quello tra primavera e estate e estate e autunno e, in generale, nelle stagioni impegnative per l’organismo come l’estate, tutti periodi che vedono la mora presente. Grazie al contenuto di acido salicilico, simile all’acido acetilsalicilico dell’aspirina, le more proteggono anche il cuore e abbassano la pressione sanguigna. Quindi, non ne mangiate troppe se soffrite di ipotensione. Nel ventaglio della frutta che consumiamo d’abitudine, le more sono una rarità e a loro volta danno luogo ad altre prelibate rarità gastronomiche. Il miele di more di rovo, anche detto miele di rovo, è raro e prodotto in ogni regione italiana dove ci siano more: come pregiato monofloreale ha il colore dell’ambra scura, il sapore ricorda quello della mora matura e ha la caratteristica di scurire i mieli millefiori, quando vi è contenuto. Non perdete l’occasione per mangiare more questa estate, magari raccolte da voi!