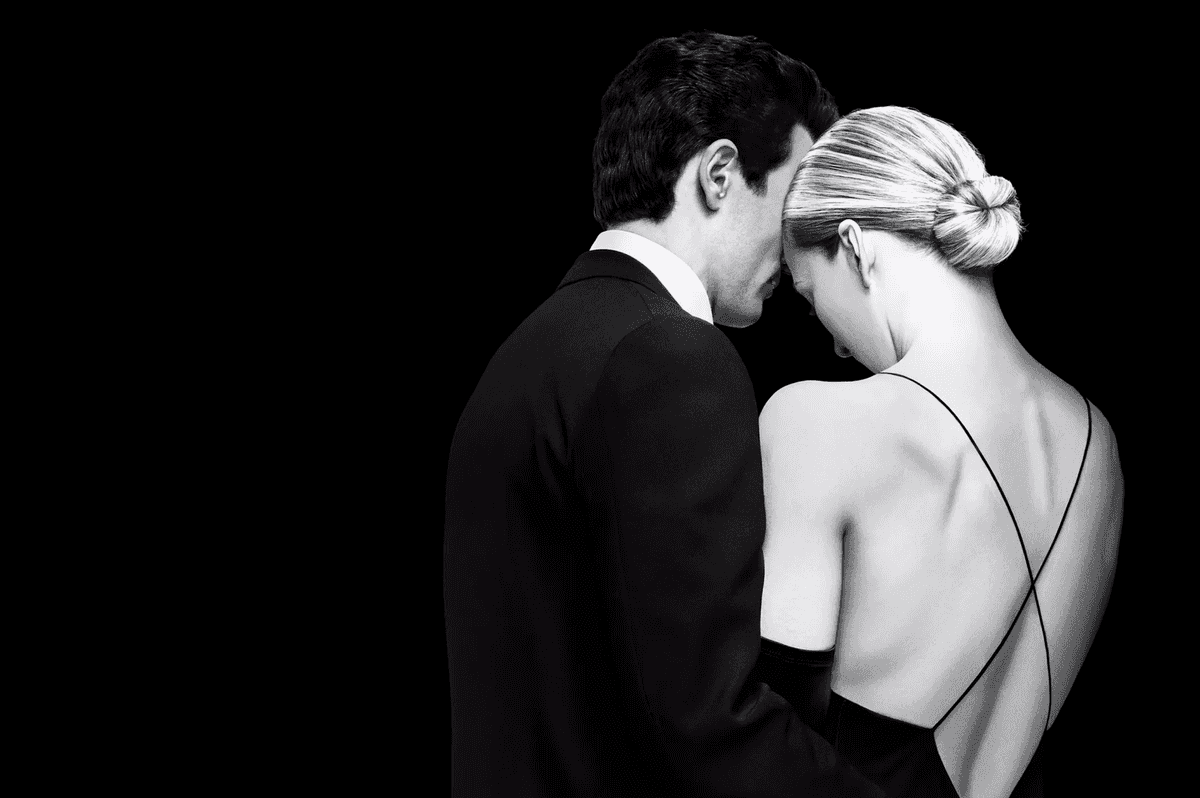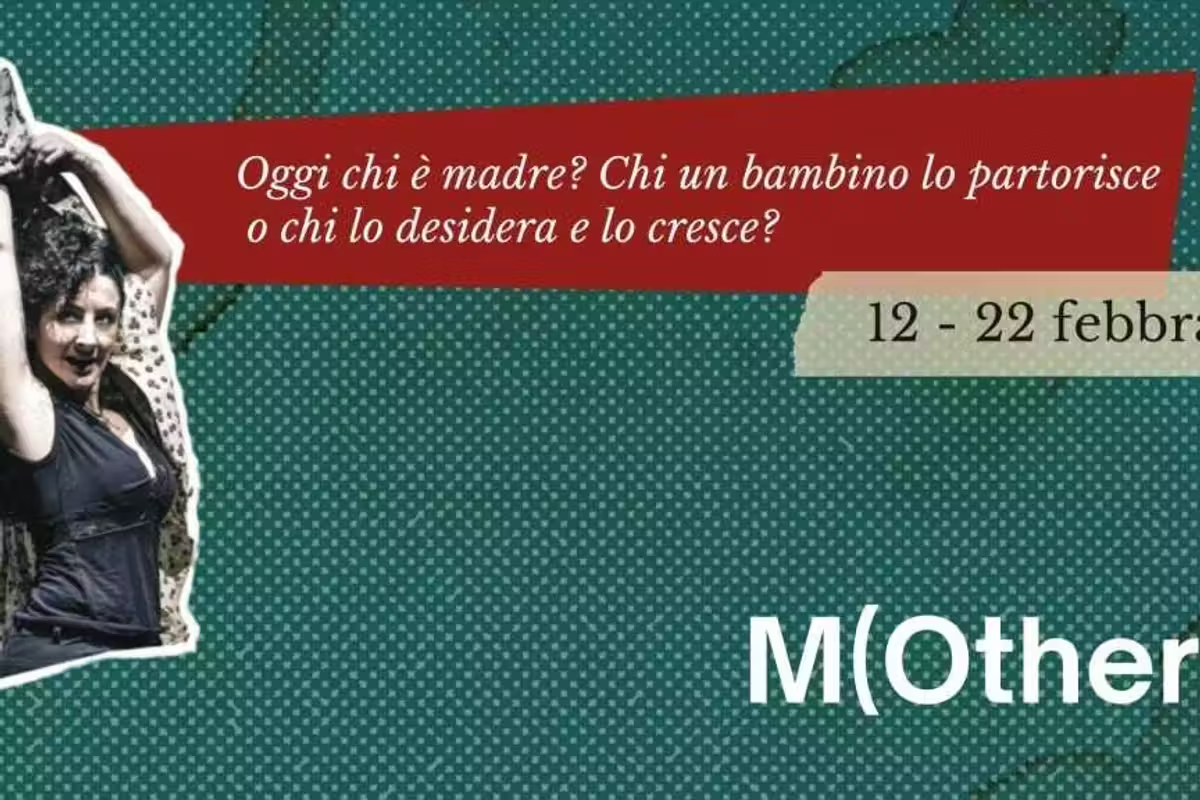Mentre i nostrani ultrà vaccinali non placano il loro tifo da stadio per i richiami infiniti dei miracolosi vaccini, emergono altre evidenze che minano la narrazione che nega con forza l’esistenza di effetti avversi gravi.
Dalla Svezia, per esempio, arrivano dei dati interessanti sui giovani colpiti da miocardi e pericarditi. Analizzando i registri della Socialstyrelsen (l’agenzia governativa svedese per il welfare e la sanità) salta all’occhio come le infiammazioni siano aumentate nei giovani tra i 10 e i 19 anni proprio nel secondo semestre del 2021 e siano rimaste più alte, rispetto al periodo pre Covid, per tutto il 2022. Ovvero, le patologie hanno avuto una crescita impetuosa proprio nei periodi successivi alla corsa all’hub a cui anche i ragazzi sono stati spinti, nonostante lo scarso rischio per la loro fascia d’età derivante dal contagio.
Nel dettaglio, il picco di eventi si è registrato nella seconda metà del 2021, con 216 ricoveri di under 20, poi scesi a 187 nel primo semestre del 2022 e a 157 in quello successivo.
Certo, non si conoscono le caratteristiche dei pazienti: se fossero all’epoca vaccinati o meno o se avessero contratto il Covid. Miocarditi e pericarditi potrebbero essere anche conseguenza dell’infezione.
E però, a tal proposito, risultano ancora più interessanti i numeri registrati prima della vaccinazione di massa degli adolescenti: come evidenzia la tabella in pagina, durante la fase acuta della pandemia, il 2020 e i primi mesi del 2021 (quando il virus aveva inoltre effetti più pesanti) le infiammazioni cardiache risultano inferiori agli anni pre Covid: 106 nel primo semestre del 2021, 104 e 114 nei due semestri del 2022, contro le 135 e 128 dei rispettivi semestri del 2019. Numeri che fanno risultare quanto meno sospetti i picchi registrati l’anno scorso e nella secondo metà del 2021.
Dalla Danimarca, invece, arriva un altro studio sulla presenza della proteina Spike - presente sia nel Sars-Cov-2, sia nei vaccini a mRna - più a lungo del previsto nel sangue dei vaccinati. La ricerca, pubblicata sul Journal of Pathology, Microbiology and Immunology, è stata condotta su 108 pazienti affetti da epatite C cronica. In dieci dei loro campioni di plasma, sequenziati da maggio 2021 alla fine di giugno 2021, i ricercatori hanno trovato frammenti di mRNA del vaccino anti Covid (sia Pfizer che Moderna) fino a 28 giorni dopo la vaccinazione. Gli studiosi descrivono la presenza di mRna come «sorprendente».
La questione della pericolosità per l’organismo della proteina Spike, bollata dagli autoproclamati fact checkers come una bufala antiscientifica, è già stata trattata in numerosi studi, come quello pubblicato sulla rivista Circulation condotto da Harvard medical school e Mit, su giovanissimi pazienti ricoverati in due ospedali di Boston, che individuava proprio nella Spike la causa delle miocarditi post iniezione nei bimbi e negli adolescenti. I ricercatori avevano infatti riscontrato, nei giovani analizzati colpiti da miocarditi, degli alti livelli di Spike libera, cioè non aggredita da anticorpi specifici.
«La proteina», spiegava il virologo Francesco Broccolo, dell’Università del Salento, alla Verità, «non è legata agli anticorpi neutralizzanti che circolano nel sangue, che nei bambini e nei giovani adulti non si sono formati dopo la prima dose. Negli adulti» sottoposti al secondo shot, «la risposta immunitaria è più forte e gli anticorpi riescono a legare la proteina S, mentre nei bambini che sviluppano la miocardite, la proteina Spike resta libera, senza legarsi agli anticorpi neutralizzanti». È così che essa attiva «l’infiammazione che sta alla base» del danno cardiaco.
Sul tema, aveva avuto importante rilevanza uno studio uscito su Cell nel marzo 2022, che aveva certificato che la proteina poteva restare in circolo due mesi dopo l’iniezione, mentre altri esami ne avevano trovato traccia nel sangue dei vaccinati fino a sei mesi dopo l’ultima dose.
La persistenza nell’organismo della Spike, e la sua potenziale tossicità, erano state oggetto anche dello studio, pubblicato sulla rivista Pathogens, dei tre ricercatori dell’Iss che evidenziavano la necessità di ricalcolare i rischi e i benefici dei vaccini. Gli studiosi sono poi stati richiamati all’ordine dall’Istituto, dissociatosi dai suoi stessi scienziati, rei di aver messo in discussione la religione vaccinale.