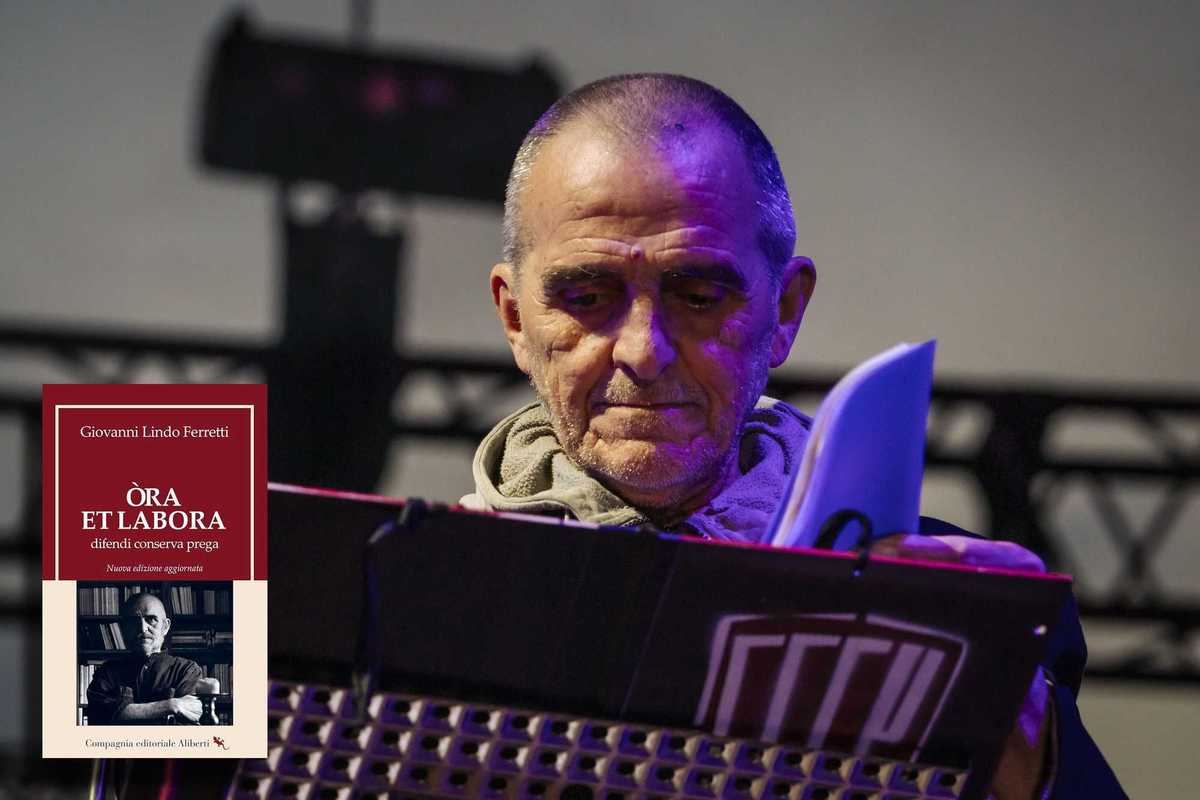Già a vedere il titolo, che parla dell'agnello e del suo mondo, i potenziali due lettori di questi almanacchi di gola possono trovarsi a separare le loro strade. L'uno a imboccarla vorace con la salivazione curiosa che esonda. L'altra che si ritira con pudico distacco, presa da materna compassione per l'innocente agnellino immolato da millenni alla resurrezione dei peccati di gola dopo la lunga espiazione delle settimane di quaresima. Ebbene, noi li invitiamo a continuare a tenersi per mano, perché la storia dell'agnello, e quindi della pecora che gli dà la luce, è ben più complessa e fa parte della storia dell'uomo.
Dopo il cane e assieme alla capra, il mondo ovino è il primo che ha affiancato la specie umana nel suo lungo percorso di affrancamento dalla fame delle caverne. Docile, duttile, la pecora ha trovato tra i suoi primi estimatori Columella che nel suo De re rustica volle riscattarla dal primato delle grandi stazze bovine «dovrebbero essere al primo posto per i benefici che se ne possono trarre. Con la loro lana sono la fonte più ricca di indumenti. Con l'abbondanza del latte e del cacio saziano la gente di campagna. Ornano di piacevoli vivande le mense dei ricchi». A dargli manforte, il secolo dopo, Giovenale, l'autore delle Satire, che tra una frecciata e l'altra del malcostume imperiale, lodò le piacevolezze delle carni ovine in bella mostra al mercato del foro romano che lo consolavano da tanta quotidiana indignazione.
Se poi andiamo ad indagare al di là del mito tramandatoci dai classici e ci basiamo sui dati della moderna scienza alimentare l'ennesima conferma. La carne ovina ha indubbie qualità. Più ricca di proteine di quella vaccina, porta in dote adeguata scorta di minerali e vitamine. Tra le meno allergizzanti e più digeribili. Ideale quindi nella dieta degli sportivi, come dei bambini o degli anziani. Non solo. Un recente studio della Washington University ha dimostrato come la carne d'agnello, nella fase dello svezzamento, aumenti significativamente il valore nutrizionale di omogeneizzati e liofilizzati. Ma c'è di più attorno a questo universo tutto da scoprire. Il mondo dei pastori ha dato ispirazione a tratturi di poesia. Pensiamo a Gabriele d'Annunzio o a Salvatore Quasimodo, per non parlare di Giacomo Leopardi con il suo Canto notturno di un Pastore errante dell'Asia. Su tutti il valtellinese Giovanni Bertacchi «salgono ai monti e tornano, le madri sospingono i bimbi, quasi ad un rito che li renda buoni». Siamo all'antropizzazione della docile pecorella con il suo agnellino.
Ma veniamo all'attualità. Nel panorama ovino l'Italia ha alcune caratteristiche che la differenziano da altri Paesi posto che, nel mondo, vi è una popolazione di un miliardo di esseri belanti. Da noi il consumo è prevalentemente di agnello giovane (quindi tra le quattro e sei settimane), ma la produzione nazionale è in grado di soddisfare a malapena la metà della domanda. Il resto proviene da mercati esteri, a prevalenza di area balcanica, ma con standard qualitativi mediamente inferiori. L'Italia, anche nel campo ovicolo, è dotata di una straordinaria varietà di razze, ognuna funzionale al suo territorio. Alcune a prevalente produzione di latte (il 70%), altre di carne, altre miste. A differenza di quello vaccino, l'allevamento ovino si presta poco alle forme intensive. Le pecore hanno bisogno del pascolo. Qui entrano in gioco due criticità importanti. Il terreno, cioè i pascoli. Chi governi le greggi, ovvero i pastori. Ecco aprirsi un mondo straordinario, sconosciuto sia ai voraci divoratori di costolette che alle rispettose astinenti d'abbacchio e dintorni.
Su questo universo della transumanza che percorre i tratturi hanno scritto storie molto coinvolgenti Marzia Verona, giornalista piemontese, e Anna Kauber, architetto toscano. Con indagini sul campo durate anni, hanno raccontato di questa realtà. Ad esempio che, in Lunigiana, l'agnello di Zeri è stato salvato dall'estinzione grazie ad un manipolo di allevatori, per tre quarti femmina. Guidate da Cinzia Angiolini che, nella sua vita precedente, era una pittrice. Dal raccontare il paesaggio con il pennello a viverlo accanto al suo gregge, il passo è stato breve. «La mission è trasformare la qualità in reddito. Non si tratta di moda o folklore, ma di qualcosa che cambia la vita». Naturalmente, quando nasce l'agnellino, tutte sperano sia femmina. Non a caso le chiamano «le signore degli agnelli». Pronte ad imbracciare il fucile contro le insidie del lupo che sta ripopolando i boschi, tanto che «è una presenza sovrannaturale, che galleggia nell'aria», come ne ha ben scritto Paolo Rumiz. E fa strage di agnellini innocenti. «Se li vai a cercare ti accorgi come i pastori esistano anche nella realtà e non solo nel Presepio» sostiene nelle sue Storie di pascolo vagante Marzia Verona, con pennellate che rimandano alle migliori tele di Giovanni Segantini, che di greggi e pastori ne ha raccontato per una vita.
Ad esempio, si sta cercando di semplificare una burocrazia penalizzante che, a volte, è peggio del lupo; predatrice di tempo ed energie di questi eroici artigiani del paesaggio. Perché questo è un altro punto di forza del pascolo. Lo ricorda bene l'abruzzese Nunzio Marcelli, un volto iconico che Ermanno Olmi se lo sarebbe scritturato al volo. Laureato in economia ha trovato nell'alpeggio la sua motivazione di vita. «Noi pastori serviamo non tanto per l'economia, ma per l'ambiente. Siamo un tassello importante per la salvaguardia del paesaggio. I boschi, i campi, vengono “ripuliti" dalle greggi, senza i costi e l'inquinamento dei mezzi meccanici. Questo serve a prevenire gli incendi, a limitare il rinselvatichimento delle aree montane, alla conservazione della biodiversità vegetale». Forse non è un caso che sia nata l'associazione pastori vaganti dell'arco alpino. Un centinaio di associati.
Dal dicembre 2019 i tratturi sono divenuti Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. L'iniziativa è partita da Amatrice, subito dopo il terremoto. Uno dei modi per risorgere, in questi centri minori, crocevia di passaggi delle greggi che hanno unito, nei secoli, le Murge con la Ciociaria, l'Abruzzo, la Calabria, perché la «transumanza è un'attività di addii e ritorni che si sviluppa lungo i tratturi, sentieri naturali e antropici». Non è un caso che, piccole capitali di questi micromondi, siano due centri quali Bidonì, riferimento dell'agnello sardo (139 abitanti) e Roaschia, sulle Alpi Marittime, 200 residenti, dove il sindaco ha voluto che l'unico negozio di alimentari «resistesse» dentro un locale del municipio. Un universo, quindi, con un'antologia di storie le più disparate. Come quella di Daniela Pasinetti e Davide Bortoluzzi. Sull'altopiano d'Alpago, nel bellunese. Lei, piemontese, corteggiata per una carriera da fotomodella. Lui che, a dodici anni, chiedeva ai suoi genitori una pecorella, dopo averle viste correre docili lungo «l'autostrada» del Piave. Ne ha raccolto la testimonianza Stefano Lorenzetto. «Mia mamma rilanciò con una playstation nuova di zecca. Rifiutai. Mi arrivarono Bettina e Diana. Mio nonno prese Cesira e Narcisa» e così Davide realizzò il suo sogno. Fare il pastore. Non è tutto facile. «Per poter attraversare i binari devi camminare con l'orario dei treni in tasca. Dalla lana non ricavi nulla. Arrivano i tosatori dalla Nuova Zelanda e passano il gregge a tappeto. Li ho cronometrati. 1'10» per una tosatura di tutto punto». Adesso Daniela e Davide percorrono meno i tratturi, ma quella esperienza li ha uniti, per sempre, assieme alle loro pecore. Siamo arrivati davanti alla vetrina con i tagli degli agnellini per scoprire come, lungo l'italico stivale, si possano declinare in mille tentazioni golose. Ma qui sappiamo che le «mamme lettrici» andranno altrove. Così facendo abbiamo raccontato anche a loro storie che, altrimenti, mai avrebbero potuto scoprire…


 Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania
Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania