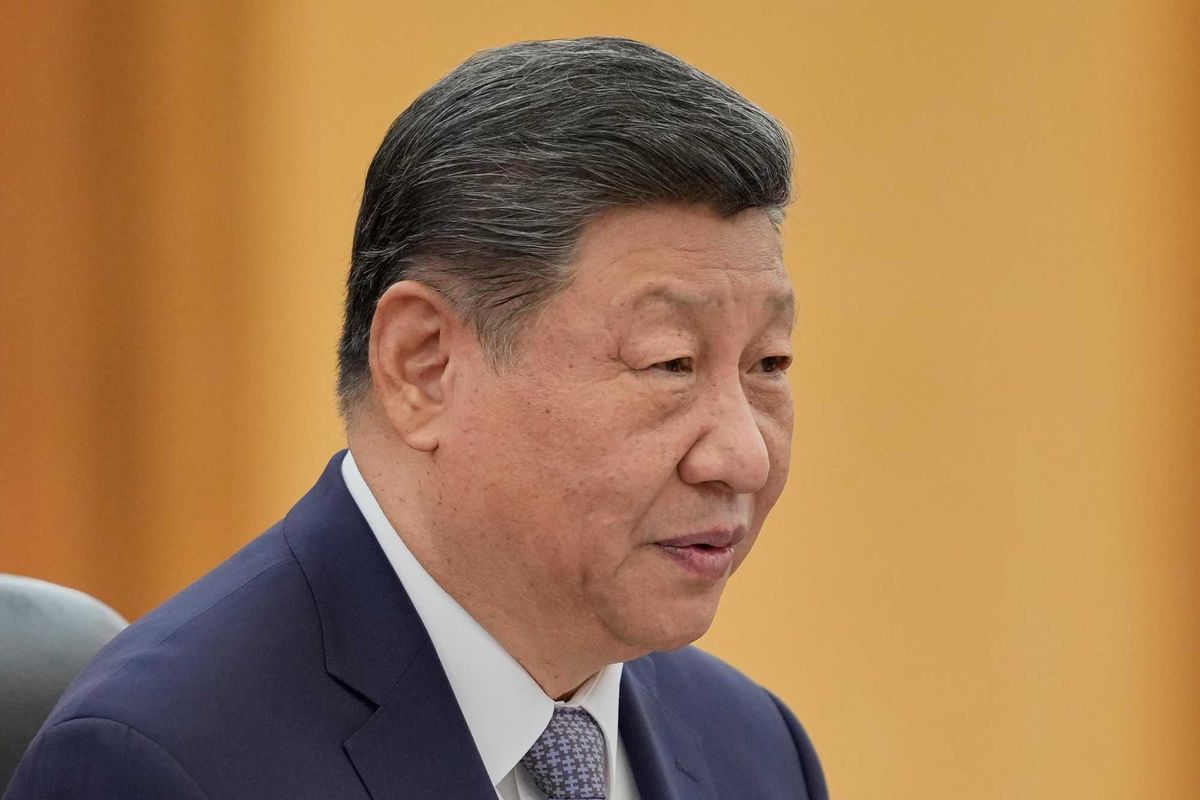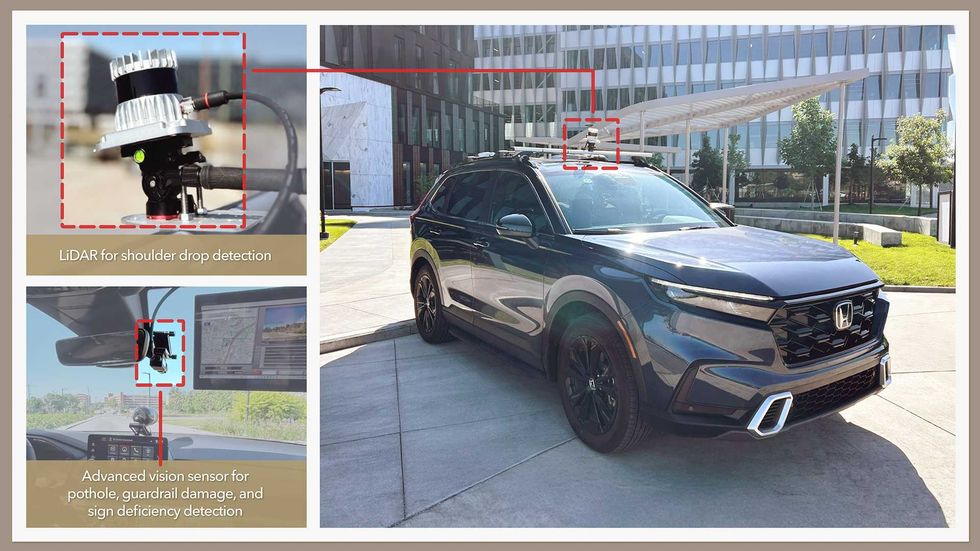Lo aveva già detto Napoleone Bonaparte: «È il cibo a fare il soldato. Un esercito marcia sul proprio stomaco». Fu lui a bandire un concorso per la migliore idea volta a conservare al meglio le razioni di cibo per i combattenti. Lo vinse Nicolas Appert, con l'introduzione di contenitori di vetro sigillati. Idea poi migliorata da Philippe de Girard con l'uso delle scatolette di metallo, pur se il brevetto lo depositò l'inglese Peter Durand.
Anche in Italia la produzione del cibo in scatola ben presto prese a diffondersi nel commercio al minuto. Fu l'esplosione del conflitto a far di necessità virtù, con le truppe attestate nelle trincee in una lunga ed estenuante guerra di logoramento. Spesso su scenari montani con tutte le difficoltà di confezionamento ma, soprattutto, di trasferimento verso i militari in prima linea. Inizialmente si puntò sul parco buoi, mandrie di bestiame a ridosso delle prime linee dove avveniva macellazione e confezionamento del tutto. Erano procedure complicate e la crescente necessità di carne da macello rischiava di privare i campi della forza lavoro necessaria. Iniziò così l'importazione di carne congelata dall'Argentina che arrivava in celle frigorifere, il che andò ad implementare la produzione di scatolame vario, tanto che ne vennero consegnate oltre 200 milioni di razioni. Ogni soldato aveva in dotazione due scatolette di carne e una di gallette, ma poteva consumarle solo dopo l'autorizzazione dell'ufficiale di riferimento, quando era impossibile procurarsi il cibo in altri modi.
Dalle cucine da campo delle retrovie colonne di muli e cavalli partivano la notte verso le prime linee. In Friuli vi fu un'ulteriore variante, grazie alle portatrici carniche. Donne allenate alla fatica. Potevano superare dislivelli impegnativi con carichi da quaranta chili. Una di loro, Maria Plozner Mentil, cadde eroicamente sul campo. È stata l'unica donna cui l'esercito italiano abbia dedicato una caserma, a Paluzza. Tuttavia il cibo che giungeva alle truppe era un'autentica sbobba. Se è pur vero che il trasporto avveniva tramite casse di cottura che mantenevano la temperatura per ore, è anche vero che spesso arrivava brodaglia che si divorava solo per fame. Il riso rimase per molti anni l'incubo dei soldati meridionali. Al fronte arrivava talmente scotto che veniva definito «sciacquapanza». Per ovviare a questi inconvenienti si usavano vari accorgimenti. Uno fu lo scaldarancio, un ingegnoso fornellino da campo alimentato da carta compressa impregnata di cera, alcool e grasso. Chiunque poteva confezionava queste pile vegetali che avevano il vantaggio di scaldare senza alzare fumo (quindi non viste dal nemico) e rendere accettabili sbobbe altrimenti al di là di ogni tentazione.
Anche sul pane la necessità stimolò l'ingegno. Non era facile rifornire le truppe con pagnotte regolari. Pane prezioso, tanto che Emilio Lussu, nel suo Un anno sull'altipiano, racconta come, di notte, le truppe sabaude lanciassero verso le armate asburgiche sacchi di pane, ricevendone in cambio tabacco, sigari e sigarette. Ecco allora che qualcuno si inventò le gallette. Una specie di biscotto non lievitato a lunga conservazione che conteneva i nutrienti del pane in volume minore, adatto al trasporto sulle lunghe distanze senza rompersi. Ma troppe volte le gallette restavano nei magazzini e, quando arrivavano in prima linea, erano ricoperte di muffa.
Comunque, bene o male, il problema del cibo non fu mai l'emergenza principale del soldato italiano. È celebre una famosa sequenza del film di Mario Monicelli, in La grande guerra, in cui un arcigno ufficiale chiede a un intimorito Alberto Sordi «Com'è il rancio?» »Ottimo e abbondante». «Invece è una schifezza». Al tempo le truppe erano di prevalente estrazione rurale e conciliare il pranzo con la cena non era cosa facile. Nella fornitura giornaliera al soldato si prevedevano circa 4.000 calorie giornaliere, con una dotazione quotidiana di carne. Cose impensabili nella vita civile. Il vero problema, invece, era l'acqua. Si riusciva a stento ad assicurare una fornitura di mezzo litro al giorno, quando le necessità erano ben superiori. Non sempre era possibile far sciogliere la neve, per compensarne la carenza. In certi battaglioni alpini gli ufficiali furono costretti a far aggiungere petrolio alle casse d'acqua che servivano, invece, per il circuito di refrigerazione delle mitragliatrici. Forse è anche su queste basi che si è costituita la leggenda della forte alleanza fra truppe alpine e vino. Un consolatore di molte mancanze, anche semplicemente liquide. Il mescolarsi di truppe provenienti da realtà spesso sconosciute tra loro portò a uno scambio di esperienze diverse. Il caffè, da prodotto elitario, divenne bene di largo consumo. È rimasto celebre un ricettario compilato con cura da Giuseppe Chioni e Giosuè Fiorentino. Raccolsero un numero di ricette ben superiori e più capillare rispetto alla celeberrima opera di Pellegrino Artusi dove, all'inizio, regioni come Piemonte e Liguria erano poco rappresentate. Si possono trovare piccole chicche, quali il riccio al forno (imbottito di funghi, prosciutto e formaggi) o la zuppa del soldato, un mix di patate olio acqua e farina che, se necessario, si poteva preparare anche dentro il casco militare.
Non sono mancati gli episodi grotteschi. Famoso quello delle arance dell'Adamello. All'arrivo di un carico di arance alcuni alpini abruzzesi le scambiarono per una variante delle mele e le affrontarono a morsi. Sul fronte interno si cercò di ottimizzare la cucina di guerra, con le risorse destinate in primis alle truppe e alla popolazione civile. Ecco ricette che, ancora oggi, possono suscitare curiosità, come ad esempio la minestra di chiare d'uovo o la frittata senza uova, come pure le cotolette ai carciofi o, ai dolci, la torta di polenta o il pan perduto, un modo per ridare vita al pane divenuto secco, rianimato con uova, latte, zucchero e poi fritto. Un cameo a parte lo meritano le scatolette che, in questi ultimi anni, hanno mobilitato legioni di nuovi recuperanti. Una bella raccolta si trova al Museo della guerra di Forte Tre Sassi, nei pressi di Cortina d'Ampezzo. Interessante la grafica dove, quasi a voler stimolare le truppe, vi sono figure di aquile e leoni, ma anche immagini femminili, nomi patriottici, quali le Alici Garibaldi o i Filetti Savoia, così come l'Antipasto Tripoli. Curiose le storie dietro ad alcuni tra i produttori. Cirio è un nome consolidato. Il fondatore fu Francesco, un piemontese che fondò la sua azienda nel 1856, inscatolando piselli, e solo dopo l'unità d'Italia cominciò a delocalizzarsi al Sud. Oppure quella di Pietro Sada, produttore del «manzo alla militare», divenuto famoso dopo aver fornito le sue scatolette a un dirigibile che attraversava le Alpi della famiglia Gondrand. Sada esiste tutt'oggi, con il marchio Simmenthal. Infine Giuseppe Lancia. Iniziò a produrre scatolame per le truppe mandate da Cavour in Crimea. Fece fortuna e acquisì grandi tenute in Argentina. Da lì le basi per cui poi, nel 1906, il figlio Vincenzo fondò la Lancia automobili.