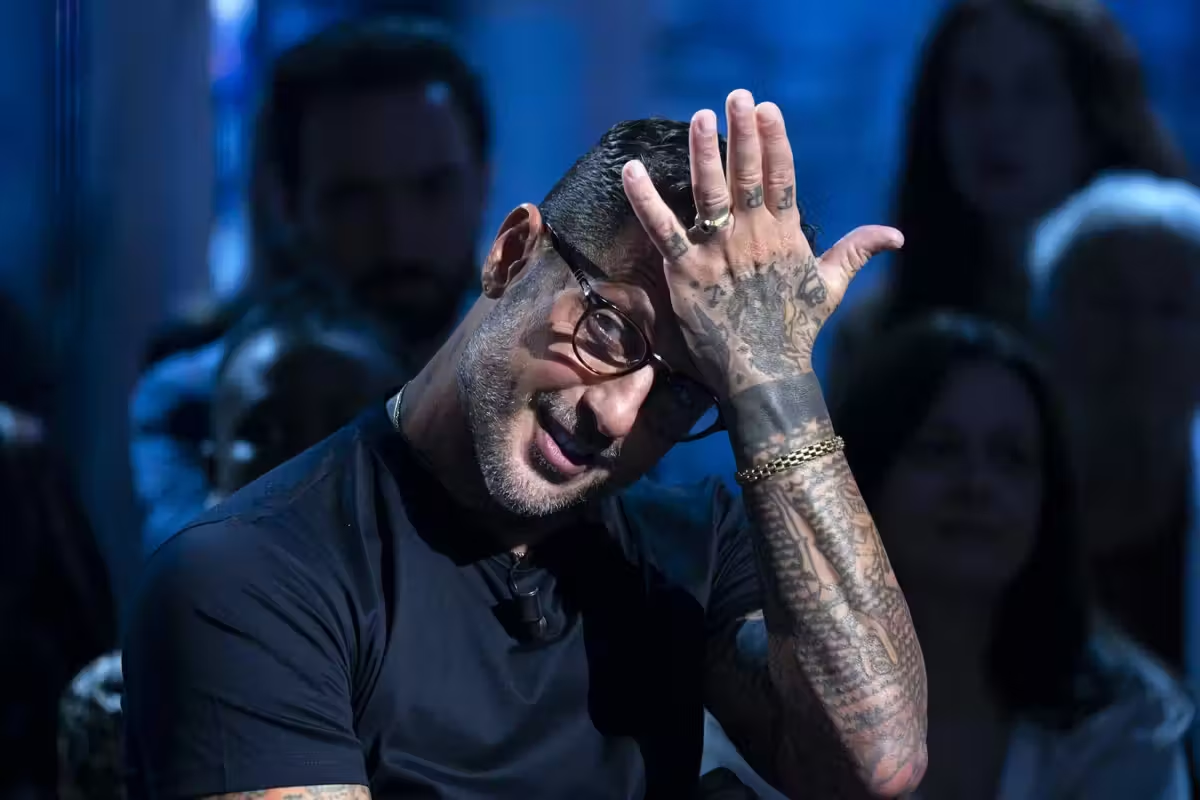True
2022-02-21
Multate chi ci fa le multe
Multe stradali: un pozzo di San Patrizio avvolto nel mistero più fitto. La legge 120 del 2010 impone che il 50% dei proventi derivanti da multe stradali e autovelox venga destinato «alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti» e obbliga a rendicontare ogni annuo in forma telematica l’ammontare degli importi incassati e gli interventi realizzati con tali risorse. Ma sono pochissimi gli enti locali che rispettano la legge, siano essi Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane e Amministrazioni provinciali. Nel 2020, secondo i dati ufficiali del Viminale, 1.556 Comuni non hanno inviato al ministero dell’Interno la rendicontazione, compresi i 347 che lo hanno fatto in maniera incompleta o contenente errori. A questi si aggiungono 317 Unioni di Comuni, 3 Città metropolitane su 14 (Catania, Messina, Reggio Calabria) e 15 Province.
Nel 2021 questi numeri sono addirittura aumentati. I Comuni inadempienti sono saliti a 2.258 su 7.904, tra i quali 187 hanno inviato una rendicontazione incompleta o scorretta. Il numero dei sindaci trasgressori è dunque cresciuto del 45%. Le Città metropolitane sono passate da 3 a 5 (Genova, Napoli, Catania, Messina e Palermo); crescita anche per le Unioni di Comuni disobbedienti: 361. Come si spiega questo menefreghismo rispetto agli obblighi di legge? Semplice: non esistono sanzioni per chi sgarra.
«Puntare sulla sicurezza stradale». Lo hanno sbandierato negli anni tanti ministri delle Infrastrutture, da Danilo Toninelli, che in più occasioni ha parlato dell’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per la manutenzione stradale, a Graziano Del Rio, che propose di dedicare sempre più risorse per la sicurezza. Peccato che nessuno abbia mai controllato né sanzionato gli enti locali inadempienti. Senza rendiconto, è impossibile sapere quanti soldi entrano nelle casse delle varie amministrazioni e come vengono spesi. Ma un interrogativo riguarda tutti i consuntivi inviati al governo: chi controlla se le autodichiarazioni sono veritiere? Non esiste infatti un monitoraggio né delle attività di manutenzione svolte né delle spese. E viene così tradito un dovere almeno morale di trasparenza verso gli automobilisti colpiti dalla raffica di sanzioni.
L’opacità sull’utilizzo delle multe stradali alimenta l’eterno sospetto: che quei soldi servano ai sindaci non a far rallentare i conducenti e migliorare la sicurezza stradale, ma semplicemente a fare cassa per coprire le spese della normale amministrazione. Questo vale soprattutto per i proventi degli autovelox. L’Italia il Paese europeo con il più alto numero di rivelatori di velocità: ben 8.000, due volte e mezzo in più della Germania (che ne possiede 3.813), il triplo della Francia (2.406), addirittura 25 volte più della Norvegia, dove se ne trovano appena 311.
Gli ultimi dati Openpolis attestano che l’eccesso di velocità, con 564.352 contravvenzioni all’anno, è l’illecito stradale più multato. Seguono quelli legati al mancato uso della cintura di sicurezza (74.996) e al mancato utilizzo dell’auricolare o del vivavoce durante le conversazioni telefoniche (39.323).
Tra i Comuni con più di 200.000 abitanti, Firenze è quello che nel 2020 ha incassato di più dalle multe: in media 138,33 per ogni cittadino. Seguono Bologna (106,54), Padova (92,95) e Milano (86,72). Tutto all’opposto Genova (43,08 euro pro capite), Bari (29,15) e Trieste (26). In proporzione, gli aumenti maggiori negli ultimi 4 anni si sono registrati a Verona (+44,8%), Firenze (+21,3%) e Bologna (20,1%). Chi certifica che metà dei proventi di multe e sanzioni siano davvero finiti nella messa in sicurezza delle strade, come prevede la legge? Nessuno. «Le buche, la segnaletica ammalorata, le radici, le piste ciclabili pericolose e inagibili di Roma sono sotto gli occhi di tutti e basta poco per capire che non tutti i soldi sono stati spesi come dovrebbero»: a denunciarlo è Fabrizio Premuti, presidente nazionale di Konsumer Italia, che si occupa da anni della sicurezza stradale della capitale.
Rischi sempre più alti per chi guida auto e moto
La cattiva manutenzione delle strade, che dovrebbe essere finanziata con il 50% dei soldi incassati dalle multe, ha ripercussioni dirette sul numero di incidenti stradali. Ecco che cosa ne pensa l’avvocato Piergiorgio Asumma, presidente dell’Osservatorio nazionale per la tutela delle vittime di omicidio stradale. «Purtroppo molti incidenti dipendono dalle cattive condizioni di marciapiedi, piste ciclabili, manto stradale», dice il legale. «I Comuni spesso sottovalutano le responsabilità civili o penali che possono derivare dalla mancata o carente manutenzione. La caduta di una moto su una buca può generare una responsabilità, sia per danni in sede civile, sia una responsabilità penale per lesioni gravi o gravissime o addirittura omicidio stradale, sempre che venga accertato il nesso causale tra l’evento e la mancata manutenzione».
La Cassazione, sottolinea Assumma richiamando l’articolo 14 del codice della strada, ha già confermato la responsabilità dell’ente locale se viene dimostrato che, con l’opportuna manutenzione, il sinistro non si sarebbe verificato. E non si tratta solo di chiudere le buche, ma anche di ridipingere le strisce pedonale sbiadite e sostituire i segnali deteriorati. I rischi per gli utenti della strada possono essere elevati: «Il manto stradale incidere innanzitutto sulla frenata», chiarisce Assumma. «Sulle strade con asfalto “a pelle di coccodrillo”», il coefficiente di frenata di una moto può essere reso più scarso, in quanto i saltellamenti della forcella ne possono allungare lo spazio. Ma non dimentichiamo la scarsa illuminazione sulle strade o la visibilità ridotta di strisce pedonali cancellate dal tempo e dalla percorrenza: anch’esse incidono sulla possibilità che si verifichi un sinistro». In Italia il numero di vittime della strada è stabile, almeno secondo gli ultimi dati disponibili che risalgono al 2020 perché il consuntivo del 2021 deve ancora essere elaborato. Assmma spiega così le statistiche: «Nel 2019 le vittime sono state 3.173 con 241.384 feriti, nel 2020 i morti 2.395 e i feriti 159.248. Si nota una diminuzione in termini assoluti, ma non dimentichiamo i lunghi mesi di lockdown totale e gli altri periodi caratterizzati da pesanti limiti alla libertà di circolazione». Nonostante questo calo, nel 2020 il costo sociale degli incidenti con danni alle persone su tutto il territorio nazionale è stato di circa 11,6 miliardi di euro. In media, circa 195,5 euro pro capite, oltre il 6% dei soldi in arrivo con il Pnrr.
Resta il fatto che i Comuni continuano a non rendicontare i proventi derivati da multe e autovelox e, quando lo fanno, nessuno controlla se ciò che hanno dichiarato (soldi spesi in sicurezza) equivale alla realtà. «Noi non siamo in possesso di questi dati», ammette Assumma, che comunque, per evitare equivoci, propone di cambiare l’ultimo capoverso del comma 12 bis dell’articolo 142 del codice della strada, attribuendo obblighi specifici agli enti locali dai quali non ci si possa esimere.
Continua a leggereRiduci
Metà degli incassi dalle sanzioni devono essere spesi per la sicurezza. Molti Comuni non se ne preoccupano. Ma continuano a farla franca.Rischi sempre più alti per chi guida auto e moto. Nel 2020 il costo dei sinistri con danni alle persone è stato di 11,6 miliardi di euro. Lo speciale comprende due articoli. Multe stradali: un pozzo di San Patrizio avvolto nel mistero più fitto. La legge 120 del 2010 impone che il 50% dei proventi derivanti da multe stradali e autovelox venga destinato «alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti» e obbliga a rendicontare ogni annuo in forma telematica l’ammontare degli importi incassati e gli interventi realizzati con tali risorse. Ma sono pochissimi gli enti locali che rispettano la legge, siano essi Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane e Amministrazioni provinciali. Nel 2020, secondo i dati ufficiali del Viminale, 1.556 Comuni non hanno inviato al ministero dell’Interno la rendicontazione, compresi i 347 che lo hanno fatto in maniera incompleta o contenente errori. A questi si aggiungono 317 Unioni di Comuni, 3 Città metropolitane su 14 (Catania, Messina, Reggio Calabria) e 15 Province. Nel 2021 questi numeri sono addirittura aumentati. I Comuni inadempienti sono saliti a 2.258 su 7.904, tra i quali 187 hanno inviato una rendicontazione incompleta o scorretta. Il numero dei sindaci trasgressori è dunque cresciuto del 45%. Le Città metropolitane sono passate da 3 a 5 (Genova, Napoli, Catania, Messina e Palermo); crescita anche per le Unioni di Comuni disobbedienti: 361. Come si spiega questo menefreghismo rispetto agli obblighi di legge? Semplice: non esistono sanzioni per chi sgarra.«Puntare sulla sicurezza stradale». Lo hanno sbandierato negli anni tanti ministri delle Infrastrutture, da Danilo Toninelli, che in più occasioni ha parlato dell’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per la manutenzione stradale, a Graziano Del Rio, che propose di dedicare sempre più risorse per la sicurezza. Peccato che nessuno abbia mai controllato né sanzionato gli enti locali inadempienti. Senza rendiconto, è impossibile sapere quanti soldi entrano nelle casse delle varie amministrazioni e come vengono spesi. Ma un interrogativo riguarda tutti i consuntivi inviati al governo: chi controlla se le autodichiarazioni sono veritiere? Non esiste infatti un monitoraggio né delle attività di manutenzione svolte né delle spese. E viene così tradito un dovere almeno morale di trasparenza verso gli automobilisti colpiti dalla raffica di sanzioni.L’opacità sull’utilizzo delle multe stradali alimenta l’eterno sospetto: che quei soldi servano ai sindaci non a far rallentare i conducenti e migliorare la sicurezza stradale, ma semplicemente a fare cassa per coprire le spese della normale amministrazione. Questo vale soprattutto per i proventi degli autovelox. L’Italia il Paese europeo con il più alto numero di rivelatori di velocità: ben 8.000, due volte e mezzo in più della Germania (che ne possiede 3.813), il triplo della Francia (2.406), addirittura 25 volte più della Norvegia, dove se ne trovano appena 311.Gli ultimi dati Openpolis attestano che l’eccesso di velocità, con 564.352 contravvenzioni all’anno, è l’illecito stradale più multato. Seguono quelli legati al mancato uso della cintura di sicurezza (74.996) e al mancato utilizzo dell’auricolare o del vivavoce durante le conversazioni telefoniche (39.323).Tra i Comuni con più di 200.000 abitanti, Firenze è quello che nel 2020 ha incassato di più dalle multe: in media 138,33 per ogni cittadino. Seguono Bologna (106,54), Padova (92,95) e Milano (86,72). Tutto all’opposto Genova (43,08 euro pro capite), Bari (29,15) e Trieste (26). In proporzione, gli aumenti maggiori negli ultimi 4 anni si sono registrati a Verona (+44,8%), Firenze (+21,3%) e Bologna (20,1%). Chi certifica che metà dei proventi di multe e sanzioni siano davvero finiti nella messa in sicurezza delle strade, come prevede la legge? Nessuno. «Le buche, la segnaletica ammalorata, le radici, le piste ciclabili pericolose e inagibili di Roma sono sotto gli occhi di tutti e basta poco per capire che non tutti i soldi sono stati spesi come dovrebbero»: a denunciarlo è Fabrizio Premuti, presidente nazionale di Konsumer Italia, che si occupa da anni della sicurezza stradale della capitale.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/multate-chi-ci-fa-le-multe-2656749278.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="rischi-sempre-piu-alti-per-chi-guida-auto-e-moto" data-post-id="2656749278" data-published-at="1645391407" data-use-pagination="False"> Rischi sempre più alti per chi guida auto e moto La cattiva manutenzione delle strade, che dovrebbe essere finanziata con il 50% dei soldi incassati dalle multe, ha ripercussioni dirette sul numero di incidenti stradali. Ecco che cosa ne pensa l’avvocato Piergiorgio Asumma, presidente dell’Osservatorio nazionale per la tutela delle vittime di omicidio stradale. «Purtroppo molti incidenti dipendono dalle cattive condizioni di marciapiedi, piste ciclabili, manto stradale», dice il legale. «I Comuni spesso sottovalutano le responsabilità civili o penali che possono derivare dalla mancata o carente manutenzione. La caduta di una moto su una buca può generare una responsabilità, sia per danni in sede civile, sia una responsabilità penale per lesioni gravi o gravissime o addirittura omicidio stradale, sempre che venga accertato il nesso causale tra l’evento e la mancata manutenzione». La Cassazione, sottolinea Assumma richiamando l’articolo 14 del codice della strada, ha già confermato la responsabilità dell’ente locale se viene dimostrato che, con l’opportuna manutenzione, il sinistro non si sarebbe verificato. E non si tratta solo di chiudere le buche, ma anche di ridipingere le strisce pedonale sbiadite e sostituire i segnali deteriorati. I rischi per gli utenti della strada possono essere elevati: «Il manto stradale incidere innanzitutto sulla frenata», chiarisce Assumma. «Sulle strade con asfalto “a pelle di coccodrillo”», il coefficiente di frenata di una moto può essere reso più scarso, in quanto i saltellamenti della forcella ne possono allungare lo spazio. Ma non dimentichiamo la scarsa illuminazione sulle strade o la visibilità ridotta di strisce pedonali cancellate dal tempo e dalla percorrenza: anch’esse incidono sulla possibilità che si verifichi un sinistro». In Italia il numero di vittime della strada è stabile, almeno secondo gli ultimi dati disponibili che risalgono al 2020 perché il consuntivo del 2021 deve ancora essere elaborato. Assmma spiega così le statistiche: «Nel 2019 le vittime sono state 3.173 con 241.384 feriti, nel 2020 i morti 2.395 e i feriti 159.248. Si nota una diminuzione in termini assoluti, ma non dimentichiamo i lunghi mesi di lockdown totale e gli altri periodi caratterizzati da pesanti limiti alla libertà di circolazione». Nonostante questo calo, nel 2020 il costo sociale degli incidenti con danni alle persone su tutto il territorio nazionale è stato di circa 11,6 miliardi di euro. In media, circa 195,5 euro pro capite, oltre il 6% dei soldi in arrivo con il Pnrr. Resta il fatto che i Comuni continuano a non rendicontare i proventi derivati da multe e autovelox e, quando lo fanno, nessuno controlla se ciò che hanno dichiarato (soldi spesi in sicurezza) equivale alla realtà. «Noi non siamo in possesso di questi dati», ammette Assumma, che comunque, per evitare equivoci, propone di cambiare l’ultimo capoverso del comma 12 bis dell’articolo 142 del codice della strada, attribuendo obblighi specifici agli enti locali dai quali non ci si possa esimere.
Il generale lascia la Lega e Salvini lo attacca: è come Fini. Ma per Mario Adinolfi ha ragione Vannacci. Secondo Francesco Giubilei il generale sta sbagliando, Emanuele Pozzolo è entrato nella sua truppa. Voi che ne pensate?
Jeffrey Epstein. Nel riquadro, Joanna Rubinstein (Ansa)
Ieri a finire impallinata dopo la declassificazione dei documenti, stabilita a seguito dell’approvazione dell’Epstein Files Transparency Act e resa possibile dal Dipartimento di Giustizia americano (DoJ), è stata la coppia presidenziale americana dei Clinton, da tempo molto chiacchierati per le loro relazioni con Jeffrey Epstein. L’ex presidente americano Bill Clinton e la moglie Hillary, ministro degli esteri Usa durante il primo mandato presidenziale di Barack Obama dal 2009 al 2013, si sono sempre rifiutati di testimoniare sui loro affari con il faccendiere. Convocati a ottobre, poi a dicembre e infine il 13 e il 14 gennaio, non si sono mai presentati definendo i mandati di comparizione «legalmente non validi», così avevano scritto in una lettera alla commissione di vigilanza presieduta dal repubblicano James Comer. La commissione ha dunque approvato una risoluzione per chiedere la loro incriminazione per oltraggio al Congresso, inviandola all’Aula per il voto finale che avrebbe dovuto aver luogo ieri. A fronte di quest’ultimatum, l’ex presidente e la ex first lady hanno dovuto accettare le condizioni imposte dal mandato: testimonianze pubbliche filmate, trascritte e senza limite di tempo. «Nessuno è al di sopra della legge», ha commentato Comer: la ex coppia presidenziale testimonierà il 26 (Hillary) e 27 febbraio (Bill).
Altra vittima illustre degli Epstein files è stata Joanna Rubinstein, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Svezia (Unhcr). Rubinstein si è dimessa ieri dopo che, da una mail tra lei e Epstein, è emerso che la donna nel 2012 ha soggiornato con i figli nell’isola caraibica privata del condannato per molestie sessuali. «Grazie mille. Ai bambini sono piaciute tantissimo le tue storie e, naturalmente, la tua isola. Grazie mille per il pranzo meraviglioso e il pomeriggio in paradiso. È stata una gioia in più per me incontrarvi finalmente di persona», aveva scritto Rubinstein a Epstein. Ironia della sorte, la donna che ha portato i suoi bambini nell’isola è stata tra il 2015 e il 2020 a capo della filiale americana della World Childhood Foundation, fondata dalla regina Silvia, moglie del re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Era, insomma, una figura di spicco nella filantropia internazionale, insospettabile e moralmente indiscussa fino al rilascio delle email segrete, rese pubbliche dalla implacabile giustizia americana. «Joanna ha scelto di lasciare il suo incarico dopo quanto apparso sui media nel fine settimana. L’organizzazione o il Consiglio di amministrazione non ne erano a conoscenza», ha dichiarato Daniel Axelsson, addetto stampa dell’Unhcr svedese.
Dicono tutti così: non ne sapevamo nulla. Eppure Rubinstein è andata in visita nell’isola degli orrori di Jeffrey Epstein nel 2012, tre anni dopo le accuse e l’incarcerazione del faccendiere per reati sessuali. Stesso discorso per Peter Mandelson: il Foreign Office l’altro ieri ha dichiarato che le mail hanno dimostrato una relazione «più ampia e profonda ai tempi della nomina» dell’ex ambasciatore inglese negli Stati Uniti, ma il premier laburista britannico Keir Starmer si è ampiamente speso per difenderlo, salvo poi sollecitare un’indagine penale a Scotland Yard, che ieri ha aperto un fascicolo per cattiva condotta nell’esercizio di funzioni pubbliche per i consigli di Mandelson a Epstein su come sabotare la supertassa sui bonus dei banchieri. Non solo: l’ex ambasciatore, dopo essersi ritirato dal partito Labour, ieri ha dovuto annunciare le sue dimissioni, con decorrenza da oggi, anche dalla Camera dei Lord, dove era entrato nel 2008 a seguito della nomina formale a life peer («pari a vita») della regina Elisabetta su raccomandazione dell’allora primo ministro Gordon Brown, laburista (ça va sans dire).
Altri italiani sono stati nominati dal finanziere nelle sue email. Uno è l’ex premier Mario Monti, indicato come «bureaucrat» in una mail inviata da Larry Summers, altra figura di spicco della sinistra americana ed ex segretario al tesoro Usa sotto Bill Clinton. «Monti depends on your purpose», scriveva Summers a Epstein.
C’è poi il capitolo Elkann. Epstein ricevette un invito a un evento a Londra organizzato da Edmondo di Robilant e Marco Voena per Lapo Elkann. «L’ho fotografato oggi», gli scrisse un mittente sconosciuto. «Digli che siamo amici», rispose il faccendiere. In un’altra email del 15 agosto 2010, Epstein scrive di aver parlato con il fratello John Elkann e Luca di Montezemolo e di avere ospite nel suo ranch Eduardo Teodorani, figlio della sorella di Gianni, Maria Sole Agnelli, recentemente scomparsa («Eduardo Teodorani and Annabel Nielson are here at ranch with me»). A proposito di John, un mittente coperto da segreto scrive a Epstein: «Marina ha sentito grandi cose su di lui da un amico. So che è fratello di Lapo. Cosa ne pensi?». «Great, great, great», risponde Epstein. «Penso che lui sia il nuovo obiettivo. Come facciamo a incontrarlo? Certo non attraverso Edu» (Teodorani?, ndr), replica il mittente.
Continua a leggereRiduci
Fabrizio Corona (Ansa)
La decisione era nell’aria, ma da ieri mattina sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata «rimossa». Pagina nella quale l’ex agente fotografico rilanciava i video pubblicati su un canale di YouTube del suo format on line Falsissimo con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Anche lunedì sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato una puntata. Un portavoce di Meta, la società controllata da Mark Zuckerberg che gestisce i social Facebook e Instagram, ha commentato così la cancellazione dei profili di Corona: «Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community di Meta». Resiste, almeno per il momento, il canale YouTube da oltre un milione di iscritti, dal quale però sono stati rimossi numerosi contenuti, compreso il video pubblicato lunedì sera dopo che Corona ha nuovamente rimandato sul suo canale la puntata in cui attaccava conduttori di trasmissioni Mediaset e la famiglia Berlusconi.
Cancellati anche quasi tutti i contenuti dell’account su TikTok. Anche se manca la conferma ufficiale, a pesare sulla decisione potrebbe essere stata un’azione dell’ufficio legale di Mediaset, come raramente accade, i colossi del Web ad agire in via preventiva contro il format Falsissimo.
Una serie di diffide aveva contestato infatti una lunga serie di violazioni da parte dell’ex agente fotografico, sia per quanto riguarda il copyright che per contenuti diffamatori e messaggi di odio. Mentre la Procura di Milano ha aperto nei giorni scorsi un’inchiesta per concorso in diffamazione con Corona e ricettazione di immagini e chat trasmesse a carico di manager di Google.
Secondo Ivano Chiesa, storico legale dell’ex re dei paparazzi, «la rimozione dei profili di Corona è una censura degna di un Paese come l’Italia, un’operazione di oscuramento antidemocratico. La gente ferma me e lui per strada, sono tutti dalla nostra parte». A sollevare dubbi sulla decisione dei colossi del Web è stato anche il Codacons, che in una nota ha sottolineato come la decisione «sembra dimostrare come le piattaforme che gestiscono i social network utilizzino due pesi e due misure per gestire presunte violazioni delle loro regole».
Va detto che la vicenda che ha portato alla diffida da parte di Mediaset ha pochi precedenti, se non addirittura nessuno, perfino nella turbolenta carriera di Corona. Dopo lo stop da parte dei giudici alla pubblicazione dei contenuti relativi alla vita privata del conduttore Mediaset Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi aveva reagito imbastendo una puntata di Falsissimo durante la quale aveva accusato Gerry Scotti di aver avuto rapporti intimi con tutte le «Letterine» ai tempi di Passaparola. «Per essere lì», aveva accusato Corona, «dovevano tutte andare a letto con lui. Tutte». Parole pesantissime, che indirettamente chiamano in causa anche la compagna di Piersilvio Berlusconi, Silvia Toffanin, che aveva esordito in tv proprio in quella trasmissione. E soprattutto, a differenza di quelle (che rimangono comunque tutte da dimostrare) contro Signorini, che si basavano sul racconto e sulle chat mostrate da un ex concorrente del Grande Fratello Vip, le accuse contro Scotti non erano supportate da nessuna testimonianza. Ma avevano comunque fatto velocemente il giro del Web, costringendo il conduttore a replicare: «Le presunte rivelazioni che riguardano un periodo di 25 anni fa della mia vita professionale sono semplicemente false. Sono amareggiato non solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine “Letterina”, come fosse uno stigma. Non se lo meritano. Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità». Ma soprattutto, molte delle ragazze che avevano partecipato alla trasmissione, si sono schierate a difesa del conduttore. E una in particolare, Ludmilla Radchenko, ha pubblicato sui social alcuni messaggi che avrebbe scambiato in chat con Corona che non sembrano lasciare molti dubbi sulle modalità con cui l’ex fotografo avrebbe tentato di puntellare il caso dopo essersi esposto pubblicamente. «Quando rientri? Ti volevo parlare di una cosa», le avrebbe chiesto Corona. Immediata la risposta della Radchenko: «Molto brutto che hai tirato in mezzo anche me sapendo che sono sempre stata “pulita”». «Non ti ho tirato in mezzo, solo Ilary e Silvia (verosimilmente Ilary Blasi e Silvia Toffanin, ndr). Ci sentiamo domani?», avrebbe quindi chiesto Corona. A quel punto, l’ex letterina è apparsa ancora più chiara: «Io sono stata la letterina, punto. Quindi il mio nome è in mezzo. E sai benissimo la gente come rende le notizie, tutte in un secchio».
Uno scenario che rende facile intuire perché i colossi del Web hanno deciso di tutelarsi, lasciando per la prima volta Corona solo contro tutti.
La Procura di Parigi convoca Musk
Gli uffici francesi della X di Elon Musk sono stati perquisiti dall’unità anticrimine informatico della Procura di Parigi e dell’Europol. L’indagine è quella avviata già nel gennaio di un anno fa sui contenuti consigliati dall’algoritmo della piattaforma di social media del miliardario sudafricano, prima che includesse il discusso chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Grok, assistente Ia su X. «Lo svolgimento di questa indagine rientra, in questa fase, in un approccio costruttivo, con l’obiettivo ultimo di garantire il rispetto da parte di X delle leggi francesi», ha affermato la Procura in una nota. I reati ipotizzati sono la complicità nel possesso o nella distribuzione organizzata di immagini di bambini di natura pornografica, la violazione dei diritti all’immagine delle persone con deepfake a sfondo sessuale e l’estrazione fraudolenta di dati da parte di un gruppo organizzato. Musk e l’ex ad del social, Linda Yaccarino, sono stati convocati dai pm per audizioni libere il prossimo 20 aprile. X non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma nel luglio 2025 aveva descritto l’ampliamento dell’indagine come «motivato politicamente» e aveva negato «categoricamente» le accuse di aver manipolato il suo algoritmo. Aggiungeva che «X rimane all’oscuro delle accuse specifiche mosse alla piattaforma.
Un mese fa, dopo pressioni internazionali, X ha implementato quelle che ha definito «misure tecnologiche» per impedire che lo strumento di intelligenza artificiale venisse utilizzato per manipolare foto di persone reali e ha limitato la creazione e la modifica delle immagini ai soli abbonati paganti. Musk ha annunciato che gli utenti che utilizzano Grok per generare contenuti illegali «subiranno le stesse conseguenze» di coloro che caricano materiale illegale.
Nel frattempo, l’Information commissioner’s office (Ofcom) del Regno Unito, l’ente che promuove la riservatezza dei dati per gli individui, ha affermato che sta continuando a indagare sulla piattaforma X e sulla sua società affiliata xAI. Si muove in collaborazione con l’Autorità di regolamentazione e di concorrenza per le industrie delle comunicazioni del Regno Unito, che sta raccogliendo prove per verificare se Grok venga utilizzato per creare immagini sessualizzate. Ofcom ha avviato a gennaio un’indagine su X, ma non ha ancora affrontato il problema xAI, perché l’Online safety act (che ha l’obiettivo di proteggere i bambini e gli adulti da contenuti online dannosi e illegali) non si applica ancora a tutti i chatbot Ia.
Sia X, sia xAI fanno già parte della stessa azienda, controllata da Musk. Il gruppo è destinato a entrare a far parte della società missilistica SpaceX, in base a un accordo annunciato lunedì e dal valore di 1.250 miliardi di dollari. Musk afferma che la domanda di elettricità per AI non può essere soddisfatta sul pianeta Terra e che i data center dovranno quindi trovare collocazione nello spazio ricorrendo all’energia solare, evitando così i gravi problemi ambientali che oggi si profilano con l’elaborazione dei dati.
Tornando all’indagine, non è la prima volta che la giustizia francese indaga sui proprietari di piattaforme social ritenendoli responsabili dei contenuti diffusi. Pavel Durov, il fondatore di Telegram di origine russa con cittadinanza francese e degli Emirati Arabi Uniti, venne arrestato nell’agosto del 2024 con l’accusa di non contrastare la criminalità, compresi i contenuti pedopornografici. Durov ha sempre negato qualsiasi illecito. Ieri su X ha postato: «La Francia è l’unico Paese al mondo che persegue penalmente tutti i social network che offrono alle persone un certo grado di libertà (Telegram, X, TikTok...). Non fraintendete: questo non è un Paese libero».
E c’è chi subito ne ha approfittato per infierire. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha lanciato martedì un pacchetto di misure in cinque punti volto «a contrastare gli abusi delle grandi piattaforme digitali». Intervenendo al Summit mondiale dei governi di Dubai, ha affermato: «Il mio governo collaborerà con la Procura della Repubblica per indagare e perseguire i crimini commessi da Grok, TikTok e Instagram».
Continua a leggereRiduci