Un caso di misoginia tollerata per antirazzismo: la cultura hip hop
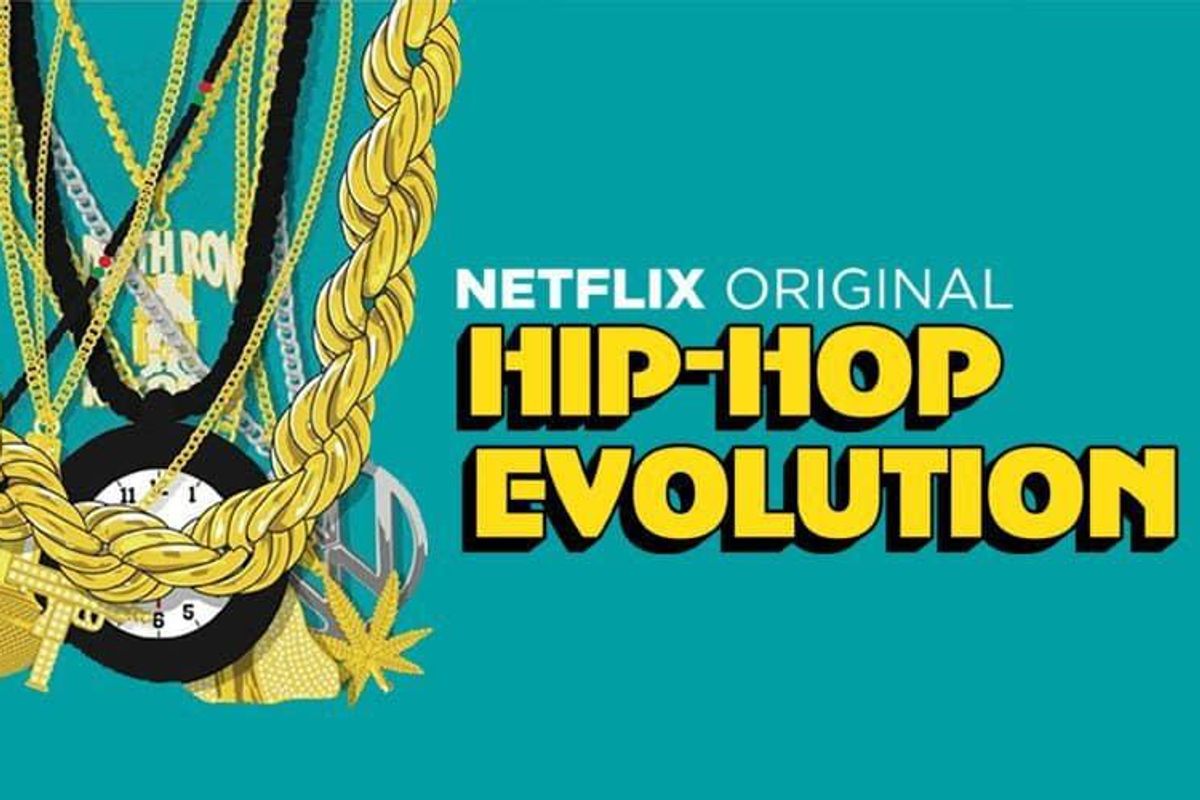
In un'epoca ossessionata dalla correttezza politica, dalle questioni di genere e dal femminismo, esiste un comparto dell'industria culturale che curiosamente pare restare immune da critiche pur essendo denso di contenuti offensivi verso donne e omosessuali: l'hip hop.
Basta vedere il video di un qualsiasi rapper americano per notare una sovrabbondanza di corpi femminili sculettanti. E anche i meno avvezzi con la lingue inglese, tendendo l'orecchio, potranno comunque notare nei testi un uso smodato di termini come «bitch», «slut», «whore», parole che vogliono tutte dire più o meno la stessa cosa e cioè, per esprimerlo con un eufemismo, «prostituta».
In realtà in America in certo dibattito sull'argomento c'è da tempo, anche se pare restato confinato nelle riserve indiane dei sociologi o degli addetti ai lavori, mentre si cercherebbe invano una campagna in stile Me too che investa la cultura hip hop come fatto ad esempio con Hollywood. Gli studiosi che se ne sono occupati hanno certificato che una percentuale tra il 22 e il 37% dei testi rap contiene una certa dose di misoginia. Recentemente, un giornalista ha contato nell'album di 21 Savage & Metro Boomin, composto da sole 15 canzoni, l'occorrenza della parola «pussy» per 83 volte, mentre «bitch» viene detto 33 volte e «hoe» (altra variazione sul tema) viene pronunciato 6 volte. Inoltre, tempo fa, quando oltre 6,7 milioni di fan hanno votato una classifica dei «più grandi rapper di tutti i tempi», solo tre artiste su 100 erano donne.
Lo scenario tipico descritto in video e canzoni è composto da uomini iper mascolini, interessati ai soldi e ai beni di consumo, laddove le donne sono solo oggetto di desiderio o, per il resto, scocciatrici infide da tenere a bada con le buone o con le cattive. La studiosa Melanie Marie Lindsay ha scritto che «i video presentano le donne afroamericane come avide, disoneste, meri oggetti sessuali senza alcun rispetto per se stesse o per gli altri, compresi i bambini a loro affidati. Le donne nei video sono disprezzate dagli uomini ed esistono per portare loro piacere».
Storicamente, uno dei primi gruppi rap ad avere problemi di questo tipo fu 2 Live Crew, autore di brani come «We Want Some Pussy» («Vogliamo un po' di f...»). In questo caso, le grane furono anche giudiziarie: nel 1987 un negozio di dischi in Florida fu denunciato dalle autorità per aver venduto un album del gruppo a una quattordicenne. Per evitare conseguenze, il gruppo decise di pubblicare due versioni, una con testi censurati e l'altra con versioni esplicite. E tuttavia, l'anno seguente un altro negozio di dischi in Alabama venne denunciato per aver venduto una copia non «pulita» del disco a un poliziotto in borghese. Nella seconda stagione del documentario Netflix Hip Hop Evolution, i protagonisti raccontano quell'episodio come una cruciale battaglia per la libertà di espressione, grazie alla quale si è evitato che l'intera cultura rap finisse sotto processo. Eppure, ha scritto il magazine di sinistra Jacobin, il caso «ha finito per rafforzare e giustificare una visione patriarcale del concetto di "libertà di espressione", una visione che risulta parziale anche nel documentario». La sensibilità contemporanea, così esacerbata su questo genere di questioni, si fa timidamente sentire. Recentemente, un gruppo storico come i Wu-Tang Clan ha proposto di riscrivere i propri vecchi testi per allinearli allo spirito del Me Too (dalla misoginia ostentata alla cancel culture, insomma, senza passare per alcuna reale elaborazione del tema).
Ma come si spiega questa persistenza di tematiche misogine nella cultura hip hop? Manco a dirlo, trattandosi di una cultura in larghissima parte nera, alla fine la colpa viene data al razzismo. Lo stereotipo del «selvaggio» ipersessualizzato e promiscuo è in effetti ricorrente sin dai primi resoconti delle spedizioni coloniali. Lo schiavismo, poi, ha separato crudelmente le famiglie degli schiavi e reso spesso le donne merce a disposizione del padrone. Trattandosi di un genere con forti radici di strada, inoltre, si tende spesso a scusare la scurrilità dei testi, rinviando ai gerghi suburbani e alla necessità di incarnare determinati schemi culturali per poter emergere in contesti che mal sopportano i linguaggi arcadici. Tutte tematiche reali, ma su cui poi si innesta il meccanismo della deresponsabilizzazione permanente, come se ogni nero destinato a nascere da qui all'eternità sia incapace di svincolarsi dall'ombra lunga di questi schemi relazionali.
Non è mancato chi ha fornito spiegazioni ancora più semplicistiche e colpevolizzanti per i bianchi. Secondo Margaret Hunter, per esempio, durante gli anni Novanta i dirigenti discografici iniziarono a sollecitare gli artisti hip hop affinché scrivessero testi più violenti e offensivi, dato che in quel momento l'hip hop cominciava a rivolgersi a un pubblico prevalentemente bianco. Insomma, poiché un bianco si aspetta questo tipo di contenuti da un prodotto culturale nero, l'industria discografica avrebbe intensificato lo stereotipo, creando una sorta di pregiudizio autoavverante. Di nuovo il «razzismo sistemico» come spiegazione a qualsiasi ingiustizia. L'impressione è che, dibattiti di nicchia a parte, la caccia alle streghe femminista che si sta affermando in molti altri settori della società per il momento intenda chiudere un occhio sugli eccessi dei «fratelli neri».





