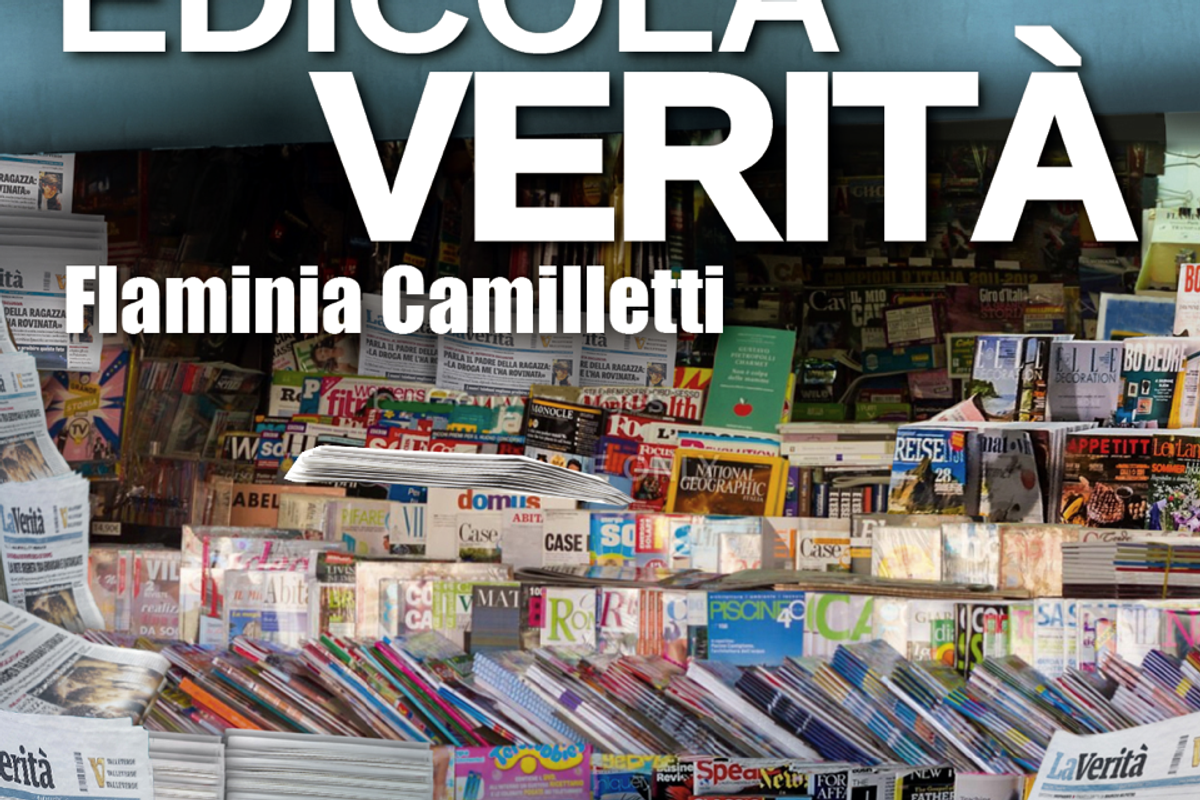Non di sola carne si nutre Frankenstein, ma anche di pesce e di latte, tutta roba prodotta in laboratorio. È stato questo il tema della prima giornata di Cibus-connetting Italia (si conclude oggi), la fiera dedicata ai soli operatori in cui si presentano le start-up e i prodotti innovativi dell’agroalimentare - ce ne sono esposti 500 tra cose che si mangiano, imballaggi e servizi - e che si tiene a Parma in alternanza con Cibus (la grande rassegna dell’agroalimentare).
Dopo il disegno di legge approvato martedì dal consiglio dei ministri su proposta del dicastero per la sovranità alimentare guidato dal ministro Francesco Lollobrigida che vieta in Italia la produzione e vendita di cibi sintetici ricavati da cellule animali imponendo pesanti sanzioni, il mondo dell’agroalimentare rilancia sul made in Italy anche all’indomani della richiesta di inserire la cucina italiana – la più imitata, richiesta e consumata al mondo – nella lista Unesco del patrimonio mondiale dell’umanità. La Coldiretti, che contro la bistecca sintetica ha raccolto cinquecentomila firme, ha presentato ieri a Parma, dove ha dato luogo a un sit in di protesta-proposta per la difesa del cibo «naturale», un sondaggio realizzato col Censis secondo cui l’84% degli italiani si dichiara contrario all’idea di cibi prodotti in laboratorio, dalla carne al latte, dai formaggi al pesce, da sostituire a quelli coltivati in agricoltura».
La Coldiretti ha anche fatto il punto sull’offensiva dei cosiddetti cibi Frankenstein – oggi in fiera esporrà i prodotti contraffatti che arrivano dalla Russia – e ha reso esplicito che non solo la Food & Drug administration americana ha sdoganato i polli sintetici e che l’Efsa – l’ente europeo che sorveglia la salubrità dei cibi e che per ironia geografica ha sede a Parma – probabilmente autorizzerà entro l’anno in Europa i cibi prodotti dalla clonazione di cellule staminali, ma ha aggiunto che mentre in Danimarca si sta producendo il latte sintetico, in Germania sono già pronti con i pesci e il sushi costruiti in laboratorio. Ci sono i bastoncini di sostanza ittica coltivati in vitro senza aver mai neppure visto il mare. La società tedesca Bluu Seafood, impegnata nel progetto, promette di ricreare in laboratorio la carne di salmone atlantico, trota iridea e carpa, partendo da cellule coltivate e arricchite di proteine vegetali.
Si tratta di un enorme mercato potenziale visto che gli italiani mangiano circa 28 chili di pesce a testa, sopra la media europea che è di 25. L’offensiva dei cibi sintetici rischia di avere conseguenze sul sistema economico dell’agroalimentare che proprio a Cibus-connecting ha sancito il record di export per 60,7 miliardi di euro. È un sistema che muove complessivamente 580 miliardi di euro di valore della filiera agroalimentare nazionale. Secondo Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, «il Made in Italy a tavola messo a rischio dalla diffusione del cibo sintetico vale quasi un quarto del Pil nazionale e, dal campo alla tavola, vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori in 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie alimentari, oltre 330.000 realtà della ristorazione e 230.000 punti vendita al dettaglio e 10.000 agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica. Ringraziamo perciò il governo per aver accolto il nostro appello a fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell’intera filiera del cibo Made in Italy e la stessa democrazia economica».
Così appare strano che ci sia qualcuno come Giordano Masini di +Europa che a fronte del provvedimento preso dal governo contro i cibi sintetici afferma: «Invece di salutare una nuova potenziale opportunità di sviluppo, che magari potrebbe far nascere nuove imprese e nuovi posti di lavoro, il governo si affretta a vietarla preventivamente, immaginando rischi per la salute che nessuno ha mai dimostrato». Peraltro è un parere abbastanza diffuso tra i difensori della tecnologia senza se e senza ma. Certo non condiviso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha annunciato di volere portare in Italia una discussione su questi temi tra i leader europei e martedì a margine del consiglio dei ministri, scendendo tra i ragazzi della Coldiretti che avevano organizzato un flash mob sotto palazzo Chigi, ha commentato: «Non potevamo che festeggiare con i nostri agricoltori un provvedimento che pone l’Italia all’avanguardia, sul tema non solo della difesa dell’eccellenza, materia per noi particolarmente importante, ma anche sul tema della difesa dei consumatori».
Da Parma arriva anche un’altra spinta al sostegno del primo comparto economico nazionale. Cibus-connetting è la prova generale dell’accordo tra Fiere di Parma e Fiera di Milano che si mettono insieme per fondere Cibus (la rassegna dell’industria del cibo) e Tuttofood (la fiera del buono d’Italia) e creare un’alternativa all’Anuga che si tiene a Colonia in Germania e che è considerata la più importante rassegna al mondo per l’agroalimentare. La partnership si è realizzata con l’ingresso di Fiera Milano nel capitale di Fiere di Parma come secondo azionista privato con il 18,5% del capitale dopo Credit Agricole, che è primo azionista con il 26,44% del capitale. Restano nel capitale di Fiere di Parma tutti gli alti soggetti pubblici e privati.
L’intento è quello di mettere in sinergia le due manifestazioni rivolte all’agroalimentare per trasformarle in una vetrina di livello mondiale dove la produzione italiana possa vedere sancita la propria leadership.