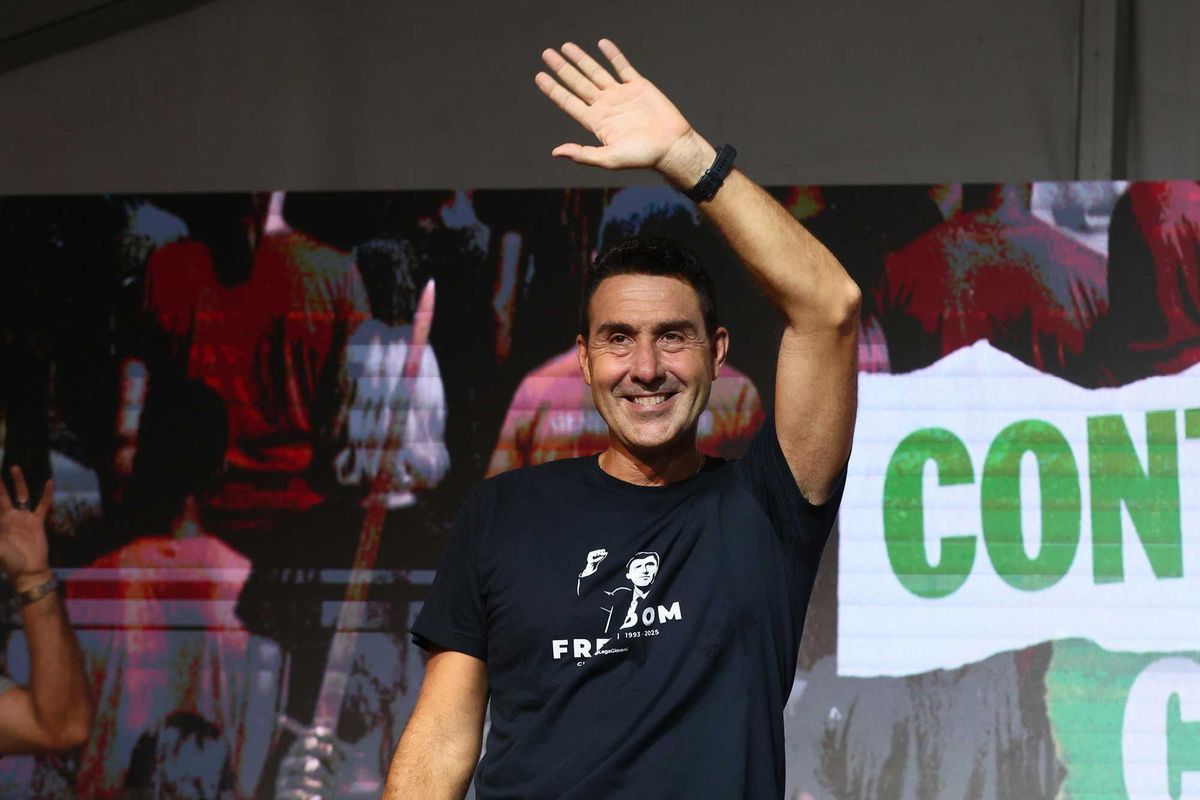Cresce la tensione tra Mali e Costa d’Avorio: un elemento che potrebbe inasprire la rivalità tra Francia e Russia nel continente africano.
Lo scorso luglio, Bamako ha posto in stato di detenzione 49 soldati ivoriani, accusandoli di essere dei mercenari. In particolare, secondo le autorità giudiziarie maliane, i prigionieri si sarebbero macchiati di “associazione a delinquere, attacco e cospirazione contro il governo, minaccia alla sicurezza esterna dello Stato, possesso e trasporto di armi da guerra e complicità in questi crimini”. Secondo Voice of America, i soldati ivoriani erano stati inviati in Mali per mettere in sicurezza un edificio di una compagnia aerea che stava eseguendo un contratto con il contingente tedesco di forze di pace nel contesto della missione delle Nazioni Unite in loco, Minusma.
A inizio settembre, tre donne presenti nel contingente sono state liberate: gli altri 46 individui restano invece per il momento bloccati in Mali. Nel frattempo, le tensioni tra i due Paesi africani stanno aumentando. “È una presa di ostaggi che non rimarrà senza conseguenze”, ha recentemente riferito ad Africa News una fonte vicina alla presidenza ivoriana. “Quando la Costa d'Avorio chiede il rilascio dei suoi soldati, (essa) continua a fungere da asilo politico per alcune personalità del Mali soggette a mandati di cattura internazionali”, ha detto dal canto suo il presidente maliano, Assimi Goita. Il governo ivoriano ha frattanto parlato di “ricatto”, chiedendo l’intervento diplomatico della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale.
Sbaglierebbe chi cercasse di inquadrare questa crisi esclusivamente in un quadro di carattere regionale. Le implicazioni di tali tensioni possono avere infatti dei risvolti internazionali piuttosto preoccupanti. Ricordiamo che l’attuale presidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, è molto vicino politicamente a Emmanuel Macron: una situazione quindi antitetica a quella in cui si trova Bamako che, negli scorsi mesi, ha irrigidito notevolmente i propri rapporti con Parigi, avvicinandosi sempre più a Mosca. Il Paese sta d’altronde ospitando i temibili mercenari del Wagner Group, mentre il Cremlino spera di usare a sua volta il Mali per estendere la propria influenza sul Sahel e, chissà, forse anche sul Golfo di Guinea. Non si può quindi affatto escludere che la crisi in corso tra Bamako e Yamoussoukro vada ricompresa nel più ampio contesto della rivalità africana tra Francia e Russia. Una rivalità che si sta facendo sempre più accesa e di cui sta progressivamente approfittando nel Sahel anche la Turchia.
Tutto questo, senza ovviamente trascurare le connessioni con la crisi ucraina. A inizio settembre, si è infatti recato in Costa d’Avorio il presidente polacco, Andrzej Duda, incontrando Ouattara, per parlare di Ucraina e commercio internazionale. “Siamo preoccupati per l'impatto della guerra in Ucraina sul commercio internazionale e sulla crescita dell'economia globale, che rischia di entrare in recessione, e in particolare per i cattivi impatti sui Paesi africani”, ha detto Ouattara nell'occasione. Insomma, l’Africa si conferma sempre più centrale nello scacchiere geopolitico globale. E le sue connessioni con le sorti europee si stanno rafforzando.