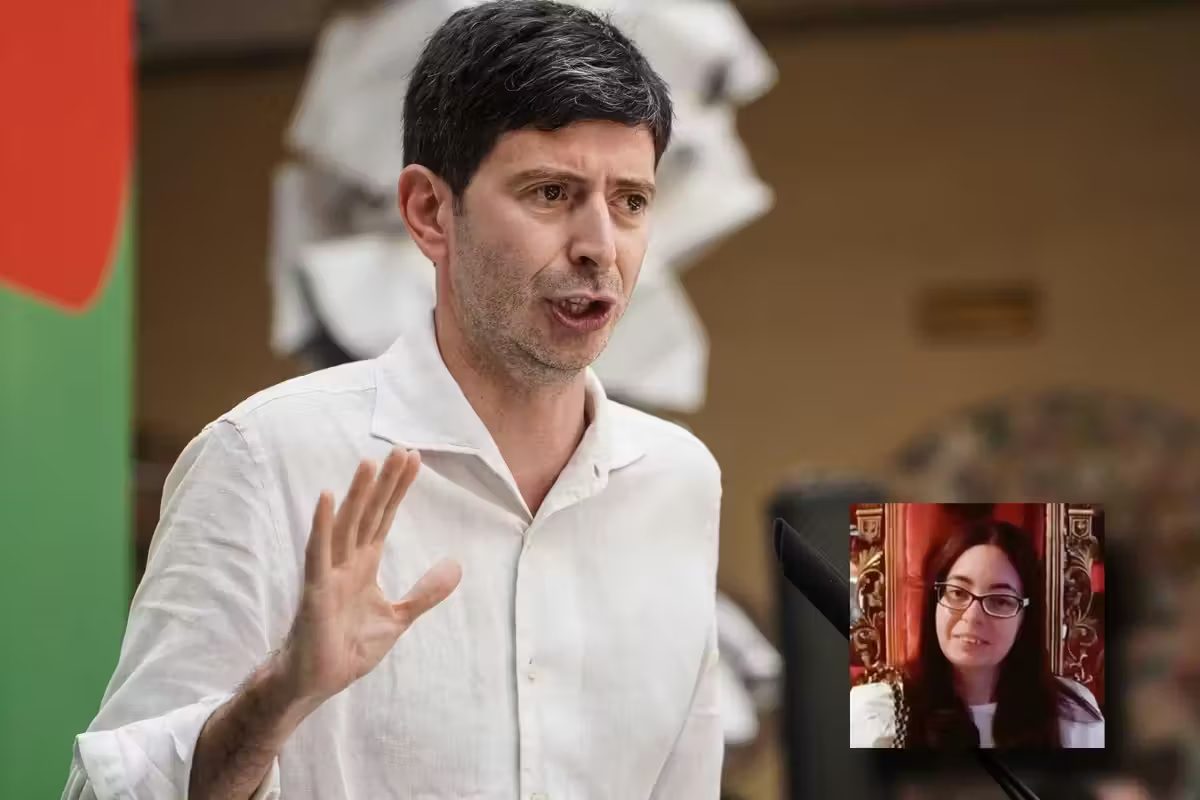La lezione dei Magi: c’è una luce più forte del piccolo lume della ragione umana

«Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Il Vangelo di Matteo è l'unico a parlare dei Magi venuti da Oriente. Li cita abbastanza brevemente, senza specificare quanti siano né come si chiamino. Sono venuti da lontano, seguendo una stella. Si sono rivolti a Erode, convinti che sappia dove si trova il re appena nato, e che si appresti ad adorarlo. Ma Erode ha altre mire: invia i Magi a Betlemme, e ordina che tornino a riferirgli dove si trova il bambino. Che cosa abbia in mente lo sappiamo: vuole ucciderlo, e quando i Magi - avvertiti da un sogno - decidono di non riferirgli niente, egli s'infuria e comincia a sterminare tutti gli infanti innocenti nel territorio di Betlemme.
Il ruolo dei Magi nel Vangelo è tutto qui. Giungono da Oriente, trovano il Bambino grazie alla stella, e quando finalmente ne vedono la luce dentro la «casa» di Betlemme, si prostrano per sottomettersi alla sua potenza. Poi gli porgono i doni: oro, incenso e mirra, a significare la regalità del neonato.
Eppure le poche righe di Matteo hanno alimentato una quantità straordinaria di testi e una riflessione teologica che, dai padri della Chiesa, arriva fino ai giorni nostri. Il mistero dei Magi è estremamente difficile da svelare. Chi erano? Sovrani d'Oriente? Astrologi e filosofi? Esperti di arti magiche? Sacerdoti pagani? Zoroastriani? La loro presenza, in ogni caso, è decisamente legata ai segni che arrivano dal cielo. Secondo la tradizione siriaca essi erano 12, come le costellazioni che coronano il Cristo Sole. A fissarne in tre il numero fu probabilmente Origene, e col passare del tempo vari commentatori ne definirono i nomi e i caratteri. Per lo più, oggi nel presepe posizioniamo Gasparre, Melchiorre e Baldassarre, arrivati alla presenza della Sacra Famiglia il 6 gennaio, 13 giorni dopo la nascita di Gesù.
Ma non ci interessa, qui, addentrarci nell'evoluzione storica dei Magi. Per questo rimandiamo a un bellissimo libro di Franco Cardini uscito nel 2019 (I Re Magi, Marsilio). Quel che ci importa è capire che cosa possano dirci, oggi, tali figure. E per questo conviene far riferimento a Benedetto XVI, che dei Magi scrisse più volte e in tempi diversi, arrivando a proporli come patroni d'Europa.
Ne L'infanzia di Gesù, Ratzinger spiega che «gli uomini di cui parla Matteo non erano soltanto astronomi. Erano “sapienti"; rappresentavano la dinamica dell'andare al di là di sé, intrinseca alle religioni - una dinamica che è ricerca della verità, ricerca del vero Dio e quindi anche filosofia nel senso originario della parola. Così la sapienza risana anche il messaggio della “scienza": la razionalità di questo messaggio non si fermava al solo sapere, ma cercava la comprensione del tutto, portando così la ragione alle sue possibilità più elevate».
Ecco, questo è il punto. I Magi erano sapienti, studiosi. Ma non si sono fermati ai libri, non si sono fatti bloccare dalla rigidità delle loro teorie o dei loro esami degli astri. Di fronte a un Bambino dentro una grotta si sono inchinati, senza restare prigionieri delle loro certezze. Nel testo evangelico viene marcata una profonda differenza tra questi sapienti orientali e la casta intellettuale del regno di Erode. In Matteo, i «capi dei sacerdoti e gli scribi» si riuniscono, considerano le affermazioni dei Magi ma poi restano fermi. Non si avviano verso il Bambino: la loro sapienza resta sulla carta, non porta a un risultato concreto.
La storia dei sapienti orientali, dunque, oggi ci parla del rapporto fra la fede e la scienza ma anche, più in generale, di quello tra la scienza e lo spirito: la Scienza (con la maiuscola) e la profondità della vita.
In questi mesi di emergenza sanitari siamo stati abituati alla contrapposizione tra la parola «scientifica» e tutte le altre esigenze umane. Abbiamo avuto l'ennesima prova del fatto che la nostra saggezza è limitata alla conoscenza dei testi, alla freddezza del numero. Gli antichi avevano una concezione completamente diversa della sapienza, come ha dimostrato il filosofo Pierre Hadot. Parlando dei filosofi greci (che si interessavano a tutti gli aspetti della natura, e pure alla medicina), il discorso filosofico era un modo di vivere.
«La scelta di vita del filosofo ne determina il discorso», scrive Hadot. Le concezioni del mondo dei vari sapienti non erano costruzioni «sistematiche e astratte». Esse prevedevano una «conversione di tutto l'essere; insomma un certo desiderio di essere e di vivere in un certo modo». La sapienza era un'opzione esistenziale e, in qualche maniera, un «esercizio spirituale».
Oggi, invece, la scienza è del tutto separata dallo spirito. È specialistica, troppo spesso chiusa nel suo recinto. Dall'alto del suo trono guarda tutti con sufficienza.
Il grande genetista Giuseppe Sermonti spiegava che la modernità ha prodotto una «scienza senz'anima», che per rendersi veramente utile dovrebbe imparare a occuparsi «di un discorso in cui collocare le sue conoscenze, in altre parole del loro “significato"».
Questa è la lezione dei Magi per il nostro tempo. Essi non sono «competenti» o «esperti», ma uomini di cultura che ricercano la sapienza vera e non si fermano all'accumulo di dati. Cercano la risposta alle domande essenziali, e non trascurano lo spirito. Anzi, arrivano al punto di mettere al servizio dello spirito le loro elevate conoscenze allo scopo di trovare un significato, un senso.
Oggi, invece, avviene il contrario. «La Scienza» cancella lo spirito, e assume essa stessa l'atteggiamento di una nuova religione. La completezza della vita passa così in secondo piano: l'uomo non è più l'unione di corpo e spirito, ma solo un corpo che, come una macchina, deve funzionare o essere rottamato. Lo scienziato, il presunto sapiente, detta legge. Non si sognerebbe mai di inchinarsi di fronte a un bambino in una grotta. I Magi insegnano però che il lume della ragione non può offuscare una luce più grande e potente. E la convinzioni che possa riuscirvi non è «scienza», ma solo una nuova forma di superstizione.