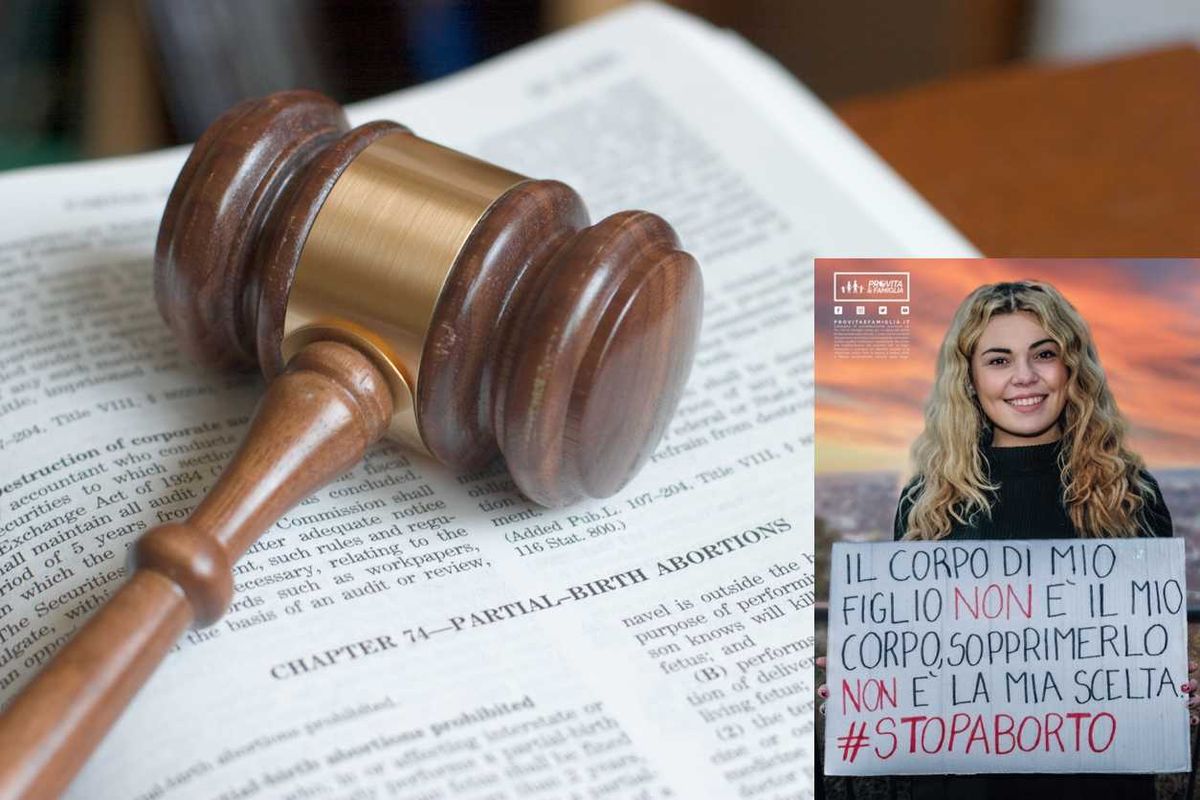Due dicembre 1973, prima domenica di austerity. Da quel giorno entrarono in vigore le misure straordinarie decise dal governo di allora (un quadripartito con Mariano Rumor alla presidenza del Consiglio) per fronteggiare l’emergenza energetica indotta dalla crisi del petrolio in Medio Oriente. Riduzione dell’illuminazione pubblica, chiusura dei negozi alle 19, spegnimento delle insegne luminose, chiusura alle 24 di ristoranti e bar (teatri e cinema alle 23), divieto di circolazione di mezzi privati alla domenica, anticipo del notiziario della sera alle 20 e chiusura delle trasmissioni televisive alle ore 23: queste alcune delle disposizioni governative.
Nella pratica l’austerity servì a poco, ma le misure di contenimento della domanda, come si dice oggi, provocarono una forte impressione nell’opinione pubblica. La crescita economica, per quanto disordinata e ineguale (e nonostante qualche brusca frenata), sembrava allora inarrestabile, quasi dovuta. La scoperta della fragilità del sistema occidentale fu uno shock che impiegò decenni per essere superato, se mai lo è stato.
Cinquant’anni dopo, ci risiamo. All’origine della turbativa oggi non è il Medio Oriente bensì la Russia, e certamente la situazione economica, politica e sociale è molto diversa. Tuttavia, il risultato è lo stesso: sacrifici per i cittadini, preoccupazione per il futuro e la sensazione che un mondo stia per finire.
Ieri, con l’usuale aplomb d’ordinanza, elegante quanto vuoto, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, il commissario per l’energia Kadri Simson e il commissario per il mercato interno Thierry Breton hanno speso alate parole per illustrare il nuovo provvedimento (Save gas for a safe winter, cioè risparmiare gas per un inverno sicuro) che, in applicazione dell’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), chiede agli Stati membri riduzioni volontarie dei consumi di gas in nome della solidarietà. Con l’avvertenza che, qualora la Commissione stessa dovesse giudicare non sufficienti gli esiti di questi sforzi volontari, le riduzioni diverrebbero obbligatorie. L’idea alla base di queste misure è che occorre risparmiare adesso per potersi garantire un inverno più sereno, nella quasi certezza che il gas dalla Russia non arriverà più.
«Putin ci sta ricattando», ha detto senza mezzi termini von der Leyen «dobbiamo essere pronti nel caso di un improvviso azzeramento dei flussi». Ieri Vladimir Putin, in effetti, ha affermato che la Russia onorerà gli impegni sul gas, ma i flussi verso l’Europa potrebbero scendere fino al 20% della capacità.
L’obiettivo della Commissione è dunque una diminuzione dei consumi del 15% a livello nazionale rispetto alla media dello stesso periodo degli ultimi 5 anni, da conseguirsi tra il mese di agosto e il marzo 2023, secondo il principio del «best effort», ovvero i maggiori sforzi possibili.
Il risparmio corrisponderebbe a 45 miliardi di metri cubi di gas, che grossomodo rappresenta il volume necessario a superare il prossimo inverno senza troppi scossoni. Durante la presentazione, peraltro, i commissari hanno lasciato intendere che le preoccupazioni riguardano anche il successivo anno termico 2023-2024, e giustamente: finire con gli stoccaggi vuoti nella primavera 2023 significa doverli riempire ancora in un momento in cui la sostituzione della Russia come fornitore non sarà ancora completa.
Ma come può la Commissione rendere obbligatoria la riduzione dei consumi nei singoli Paesi? Con l’introduzione di un nuovo regolamento, che integrerà quello già in vigore di cui abbiamo parlato qui ieri (2017/1938) e che nasce dall’invocazione dell’art. 122 del Tfue. Il nuovo regolamento introduce una fattispecie intermedia di allerta, grazie alla quale la Commissione può, appunto, avocare a sé le attività di riduzione dei consumi di gas nel caso in cui non reputi «sufficienti» quelle volontarie avviate dai singoli Stati.
L’Italia ha già un piano di emergenza che non prevede particolari riduzioni dei consumi e, una volta aumentate le forniture dall’Algeria, il ministro Cingolani si è detto in passato abbastanza tranquillo sulla tenuta del sistema. Qui però subentra il secondo pilastro della nuova regolazione europea: la solidarietà. In base a questo principio, ogni Paese è tenuto ai risparmi, per aiutare chi si trova ad essere più esposto alla carenza di gas.
Da Roma filtra una certa irritazione del governo italiano per i contenuti del provvedimento, ritenuto sbilanciato e punitivo per l’Italia, che per una volta avrebbe già fatto i celeberrimi «compiti a casa». Ieri sera, il governo spagnolo ha sonoramente bocciato l’iniziativa della Commissione sui risparmi obbligatori. Sul tema anche il commissario europeo Paolo Gentiloni avrebbe espresso forti dubbi, che però evidentemente sono serviti a poco se la Commissione di cui fa parte non ne ha tenuto conto. In sede di Consiglio europeo ci sarà da discutere.
Come già rilevato qui ieri, non vi è dubbio che il nuovo regolamento sia cucito su misura per la Germania, che si trova oggettivamente su un crinale difficile e sull’orlo di una crisi di nervi. Vladimir Putin, del resto, continua a pungolare il governo tedesco, non perdendo occasione per ribadire che la soluzione immediata alla crisi del gas sarebbe nelle mani del cancelliere Olaf Scholz, che può sbloccare il Nord Stream 2, pronto a partire. Cosa che però lo metterebbe nello scomodo ruolo di traditore del fronte occidentale. La Germania resta il ventre molle dell’Occidente e nessuno lo sa meglio di Putin.