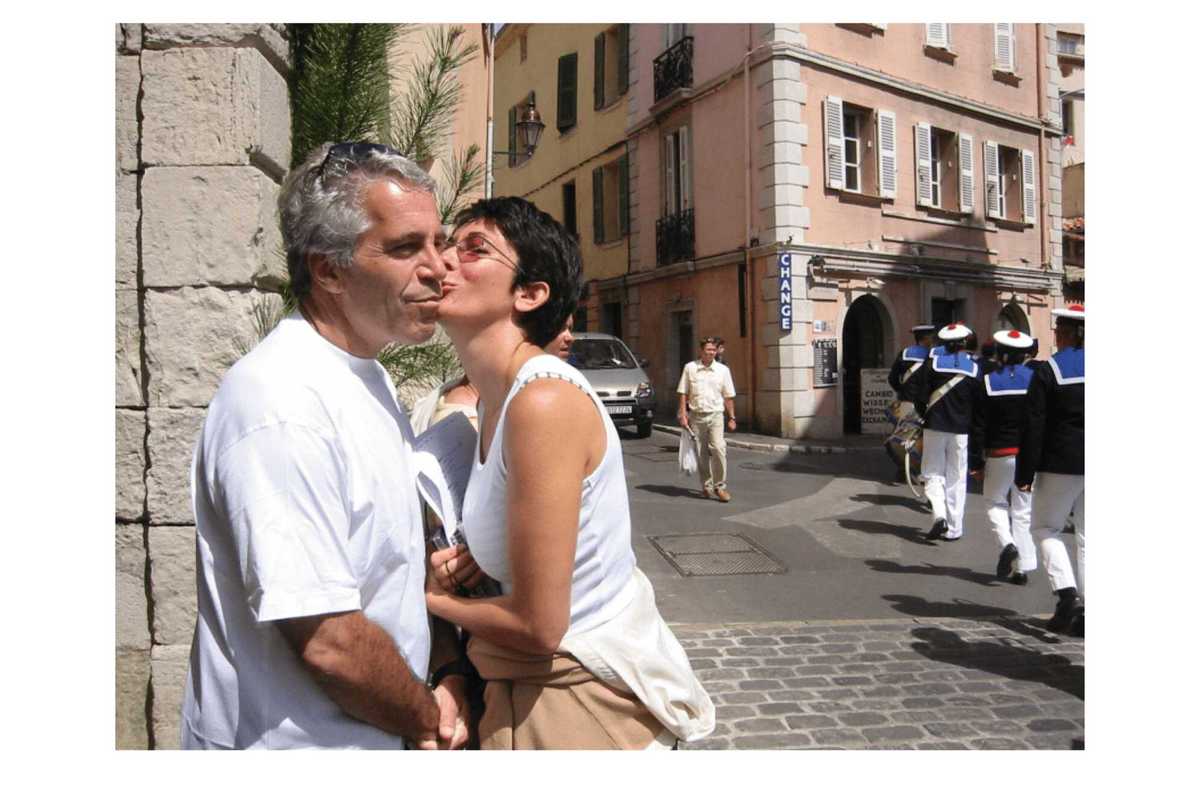«L'indecifrabilità della vita umana, dei destini dell'uomo, non potrà mai essere racchiusa in una formula»: così Erwin Chargaff, uno dei padri della moderna biologia molecolare, nel suo capolavoro intitolato Mistero impenetrabile, nel quale lo sguardo del grande scienziato lo porta a concludere che «ci sono misteri (la vita, l'anima, Dio… ndr) per riconoscere i quali è necessaria molta saggezza».
Mi è venuta in mente questa proposizione acquistando l'ultimo numero della rivista Le Scienze, dedicato agli «Essere umani», e così sottotitolato: «Dal linguaggio alla coscienza, dalla tecnologia alla guerra, come un solo animale è riuscito a plasmare il pianeta».
La rivista in questione è, nel campo scientifico, l'analogo di Repubblica nel campo politico: la voce del politicamente corretto, l'espressione ufficiale dell'ortodossia progressista. E allora, dirà il lettore, perché comperarla? Perché è sempre interessante vedere quanto si possa conoscere tanto, e capire pochissimo. O, in altre parole, quanto sia grande la distanza tra la scienza e la Sapienza, tra l'aver compreso alcuni frammenti della realtà e il rimanere del tutto esclusi da uno sguardo di insieme capace di riconoscere il fatto che la scienza sperimentale è un meccanismo magnifico di produzione non tanto di risposte, quanto di sempre nuove e più calibrate domande.
Ebbene, l'ortodossia scientista vuole da circa due secoli che l'uomo sia un animale qualunque, sperduto in un piccolissimo e insignificante pianeta, la Terra, e che solo la religione e tutt'al più la filosofia abbiano potuto immaginare una particolare dignità per l'animale-uomo e per il pianeta che lo ospita.
Mentre questo è l'assunto a priori, tutto però va in direzione contraria, dal momento che sono proprio le scoperte scientifiche a rendere sempre più ragionevole la visione non solo della Bibbia (l'uomo come vertice del creato, a «immagine e somiglianza di Dio», perché creatura capace di pensiero e volontà), ma anche dell'uomo comune, che senza particolari competenze, percepisce di essere qualcosa di diverso da una semplice scimmia evoluta o da un «numero uscito alla roulette».
Vederlo scritto, tra le righe, obtorto collo, sulla rivista Le Scienze, fa dunque immenso piacere, e spinge a sperare che prima o poi anche l'ideologia scientista possa definitivamente tramontare.
Il numero speciale di cui si è detto è introdotto dal direttore, Marco Cattaneo, il quale, per un riflesso condizionato più degno del cane di Ivan Pavlov che di uno scienziato, definisce l'uomo «un predatore di vertice, un mammifero di dimensioni vistose», salvo poi domandarsi: «che diavolo abbiamo di diverso dagli altri animali?».
Gli articoli seguenti lo spiegano, per quanto in modo sibillino e infastidito.
Kevin Laland, professore americano di biologia comportamentale ed evolutiva, comincia così il suo lungo pezzo: «Gran parte delle persone su questo pianeta crede allegramente, per lo più senza alcuna base scientifica, che gli esseri umani siano speciali, diversi dagli altri animali. È curioso notare come gli scienziati meglio qualificati per valutare questa affermazione sembrino spesso restii a riconoscere l'unicità di homo sapiens, forse per paura di rinforzare l'idea dell'eccezionalità dell'essere umano portata avanti nelle dottrine religiose».
Fermiamoci un attimo, prima della frase decisiva: tutto sembra andare in una direzione, la solita! E invece anche il più ideologico dei preamboli può riservare la sorpresa. Infatti Laland prosegue riconoscendo, suo malgrado, la giustezza, dati scientifici alla mano, della visione «allegra» dell'uomo comune e delle religioni: «Eppure sono state raccolte grandi quantità di dati scientifici rigorosi, in campi che vanno dall'ecologia alla psicologia cognitiva, che affermano che quella umana è davvero una specie particolare».
Ohibò! E non è finita: «l'essere umano si distingue davvero come un animale molto diverso dagli altri. Sembra che la nostra cultura ci separi dal resto della natura...».
Siamo dinnanzi ad un vero commiato dal naturalismo, cioè dall'idea secondo cui l'uomo sarebbe il puro prodotto di un evoluzionismo assoluto.
Questa la conclusione dell'articolo: «Il posto degli esseri umani nell'albero genealogico dell'evoluzione è fuori discussione, ma la nostra capacità di pensare, apprendere, comunicare e controllare il nostro ambiente fa di noi una specie davvero diversa da tutti gli altri animali».
A seguire un articolo di Thomas Sudendorf, professore di psicologia in Australia. Anche qui la vecchia idea darwinista dell'uomo come differente, per quantità e non per qualità, dagli altri animali, non trova albergo. Così nelle prime righe: «È ovvio che il nostro predominio non nasce da doti fisiche: altri animali sono più forti, più veloci, hanno sensi più acuti. Dipende invece dalle nostre facoltà mentali», che ci rendono «così speciali… i soli, sul pianeta, ad avere queste capacità».
Proseguendo nella lettura ci imbattiamo nel saggio di Susan Blackmore, psicologa inglese, intitolato: «L'enigma della coscienza umana». Già la parola «enigma» riporta al concetto di «mistero» da cui siamo partiti; quanto all'articolo, una lunga disquisizione serve solo a concludere quello che Eraclito aveva compreso molti secoli orsono, quando scriveva: «I confini dell'anima non li potrai mai trovare, per quanto tu percorra le sue vie, così profondo è il suo logos».
Lo stesso dicasi per il linguaggio: lo spiega Christine Kenneally nell'articolo intitolato «Che cosa c'è di unico nel linguaggio umano?» Sì, il lettore ormai ha capito, siamo dinnanzi all'ennesima ammissione: esiste in noi un'altra «cosa straordinaria», il linguaggio umano, ben diverso da quello di tutti gli altri animali, per potenzialità e ricchezza; ed esiste, ancora una volta, la nostra ignoranza: «nessuno ha trovato il Santo Graal: un evento che definisca e spieghi il linguaggio», un evento che riporti il linguaggio umano all'interno di un meccanismo evolutivo automatico, che dal meno (i linguaggi statici e bloccati degli animali), generi il più (il linguaggio, capace di discorsi potenzialmente infiniti, dell'uomo).
Con un balzo arriviamo alla conclusione: l'articolo di un astrofisico e astronomo americano, in cui si cerca di argomentare «perché siamo probabilmente l'unica vita intelligente della galassia» e perché il nostro pianeta, udite udite, pur assomigliando per certi aspetti a molti altri, è «speciale», ospita una «vita speciale» e una «specie speciale».
Non rimane che concludere rimandando il lettore appassionato a due saggi: Penso dunque sono, del linguista e neuroscienziato italiano Andrea Moro (Adelphi, Milano, 2013), e Il cammino dell'uomo. Perché siamo diversi dagli altri animali (Garzanti, Milano, 2004), del più famoso antropologo vivente, Ian Tattersaal. Il lettore vi scoprirà, alla luce della moderna paleontologia, delle neuroscienze, della linguistica ecc., quanto possano essere più attuali e interessanti - per comprendere «un essere del tutto nuovo» come homo sapiens -, Socrate, Platone, Agostino e Tommaso, dei tanti che nel corso degli ultimi dei secoli hanno voluto ridurci a bestie selvagge, «predatori di vertice», refusi della natura, ordinari figli del caso o simili amenità.