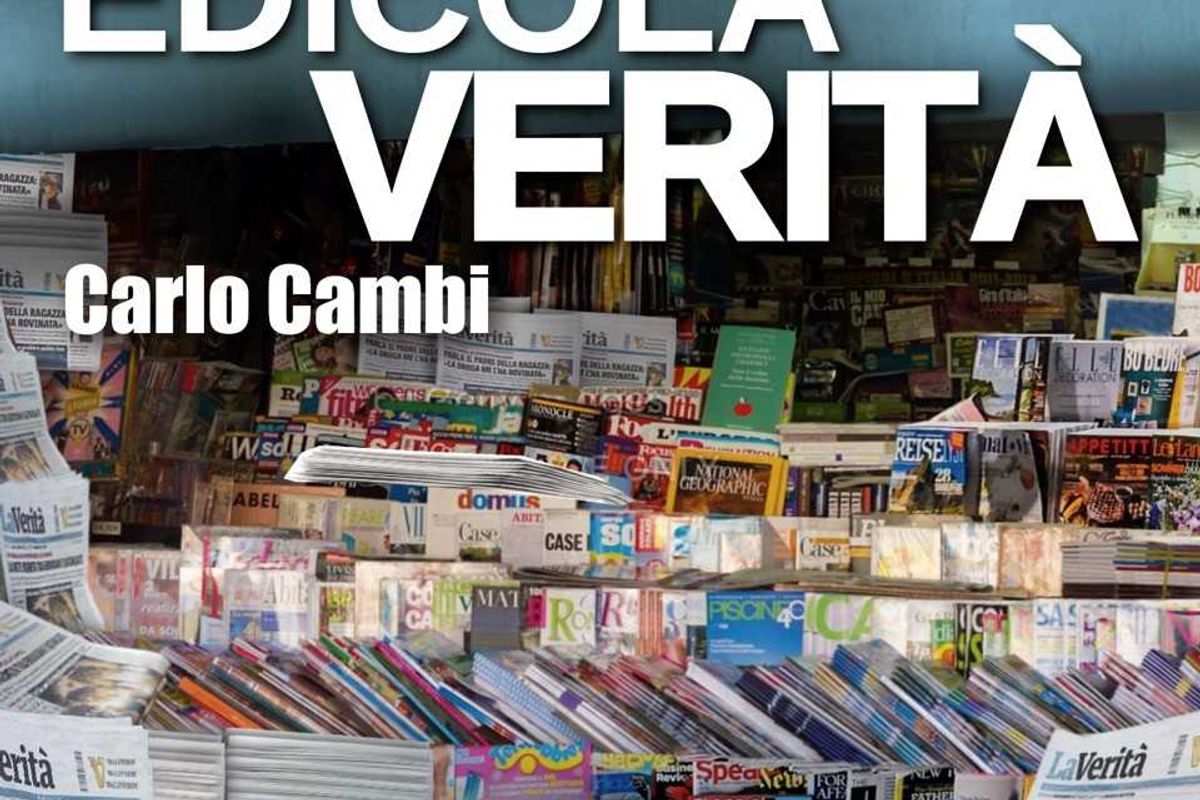L’astuzia di Ulisse, non il logos scientista, è il mito fondatore della nostra identità
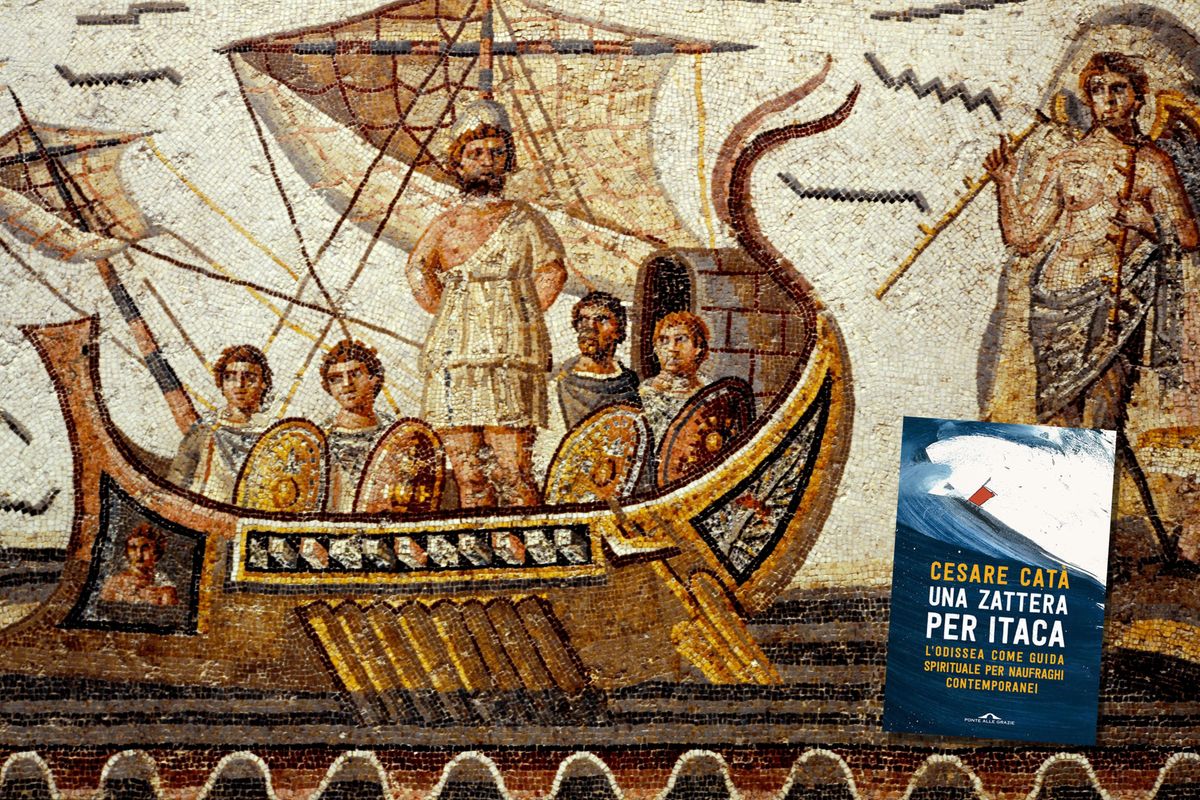
Il 30 giugno 1945, un aereo sovietico partito da Berlino sorvola le rovine fumanti di quel che resta dell’Europa e atterra all’aeroporto Vnukovo di Mosca. Dal velivolo vengono scaricate tre casse, contrassegnate con le sigle Mvf1, Mvf2 e Mvf3. Giacciono per qualche giorno nello scalo, poi, il 9 luglio, vengono trasportate sulla collinetta dove sorge il museo Puskin.
È stata la Commissione trofei di guerra a volere fortemente quel trasporto. All’inizio di giugno, un funzionario sovietico mandato dal maresciallo Georgij Konstantinovic Zukov in persona era andato dal direttore del museo di Pre e Protostoria, Wilhelm Unvergsagt, per reclamare il contenuto di quelle casse, che tuttavia, già dal 1939, era stato messo al sicuro presso il bunker di Tiergarten, uno degli ultimi presidi del Terzo Reich ad arrendersi a Berlino.
Quando i responsabili del museo Puskin aprirono le casse, restarono abbagliati, come John Travolta di fronte alla valigetta aperta di Marcellus Wallace in Pulp Fiction: l’Unione sovietica aveva appena portato in patria, come bottino della guerra condotta in Europa, il tesoro di Priamo, scoperto sulle rovine dell’antica città di Troia da Heinrich Schliemann, l’archeologo dilettante che aveva sfidato l’ipercritica specialistica, mosso dalla sua incrollabile fides nella veridicità della leggenda omerica.
non è solo letteratura
Questo destino postumo dei reperti troiani, la loro crucialità simbolica, le circostanze stesse - a loro volta particolarmente omeriche - del loro trafugamento dicono meglio di tanti discorsi cosa significhi, ancora nella modernità, il lascito ideale e materiale dell’Iliade e dell’Odissea.
Non si tratta solo di letteratura. Come scriveva Dominique Venner nel suo Un samurai d’Occidente: «Questi poemi sacri ci dicono quello che eravamo nella nostra aurora, uguali a nessun altro. Sotto gli artifici della leggenda epica, si radicano in una storia reale e in personaggi che, per la maggior parte, sono realmente esistiti. Rendono conto della storia lontana e dimenticata da tutti gli altri europei, celti, slavi, germani o scandinavi, le cui grande leggende offrono analogie costanti con la rappresentazione del mondo rivelata dall’Iliade e l’Odissea.
I due poemi traducono l’originalità del nostro stare nel mondo, il nostro modo di essere uomini e donne, davanti alla vita, la morte, la nascita, la città, il destino, insomma, il contenuto e il senso della nostra esistenza. Pongono davanti a noi un ideale di vita che ha modellato la nostra parte migliore».
Pur scrivendo con intenti molto meno politici e rivolgendosi a un pubblico decisamente diverso da quello di Venner, lo studioso Cesare Catà inizia in un modo molto simile il suo recentissimo Una zattera per Itaca. L’Odissea come guida spirituale per naufraghi contemporanei (Ponte alle grazie): «Con devozione, con rispetto, con fortissima passione, per questo lavoro mi sono immerso nelle pagine dell’Odissea come un pellegrino cristiano farebbe con la Bibbia che si porta in tasca durante il cammino: non per motivi e con intenti accademici - quanto intimi, diretti, urgenti, edificanti. Il mio è un tentativo di chiarificare alcuni problemi degli uomini e delle donne del XXI secolo alla luce di questa storia all’origine della civiltà occidentale e, reciprocamente, di comprendere meglio e da prospettive nuove le pagine omeriche alla luce di tali problemi».
il migliore di tutti
Per Catà, che alterna riferimenti eruditi a citazioni pop, Odisseo è «il Goat», termine che in inglese significa «capra», ma che come acronimo viene spesso usato per indicare il greatest of all time cioè «il più grande di tutti i tempi». Ai nostri tempi, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono contesi negli anni la palma per chi potesse essere il Goat del calcio. Ebbene, Odisseo - o Olisseo, secondo una variante dialettale da cui i romani trarranno il nome Ulisse - è il Goat in un altro campo. A renderlo speciale, idealtipico, è l’intelligenza. I greci avevano un nome per l’intelligenza e la razionalità: logos. L’intelligenza di Ulisse, tuttavia, è di un altro tipo. Non logos, ma metis. Più di ottanta volte, nei due poemi, Ulisse viene definito polymetis, cioè «colui nel quale vi è molta metis». Scrive Catà, «metis sembra indicare quella particolare facoltà intellettuale per cui un soggetto è in grado di trovare una soluzione nuova a una difficoltà vecchia. È l’intuizione che ti porta a un risultato efficace, pratico; a evitare quello che alla maggior parte della gente potrebbe sembrare uno scacco matto perché non coglie la mossa liberante; a trovare una via d’uscita dal labirinto laddove gli altri vedono solo vicoli ciechi; a scorgere una possibilità di salvezza quando il fallimento sembra inevitabile. È l’invenzione, l’impensata strategia vincente, la “trovata”, la fantasia risolutiva».
Alla metis ellenica, Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant dedicheranno un intero saggio (Les ruses de l’intelligence: La mètis des Grecs). Scrivono i due insigni grecisti: «Perché la metis appare così multipla (pantoie), variegata (poikile), ondeggiante (aiole)? Perché il suo campo di applicazione è il mondo del movimento, del molteplice, dell’ambiguo. Essa poggia su realtà fluide, che non smettono mai di mutare e che uniscono in sé, in ogni momento, aspetti contrari, forze opposte. Per impadronirsi dei fugaci kairos, la metis doveva essere più veloce di loro. Per dominare una situazione mutevole e contrastante, deve diventare più flessibile, più ondeggiante, più polimorfa del passare del tempo: deve adattarsi costantemente al susseguirsi degli eventi, piegarsi agli imprevisti per realizzare al meglio il progetto che ha ideato; così il timoniere inganna il vento per portare la nave in porto nonostante ciò».
perché ci piacciono
Se i poemi omerici ci appaiono così identitari, non è solo per l’ambientazione mediterranea (che peraltro un interprete originale e controverso come Felice Vinci, nel suo Omero nel Baltico, volle trasportare in Scandinavia), ma per la loro celebrazione di questo tipo di intelligenza che non è superstizione, ma non è neanche razionalità meccanica, universale, ideologica, un algido esprit de géométrie. È, invece, quella forma di intuizione generale e creativa del mondo che resta aperta al nuovo, al dissonante, all’imprevisto, che fa la storia senza «chiuderla», che mette in forma il mondo senza uniformarlo. Ha scritto il filosofo Peter Sloterdijk: «L’uomo che Omero definisce come polymetis è un combattente che ha imparato a trasformare ogni necessità in un compito. Dalla sua nudità sa trarre un argomento e dalla mancanza di mezzi un progetto. È letteralmente colui che non è mai in imbarazzo» (Che cosa è successo nel XX secolo?).
Ecco scoperto il motivo del perché i poemi omerici sanno parlarci ancora: perché colgono una scintilla dell’uomo universale, ma allo stesso tempo fissano in un’istantanea un modo d’essere che è tipicamente europeo.
A questa perdurante e sorprendente attualità del poeta non vedente, lo scrittore e viaggiatore francese Sylvain Tesson ha dato, nel suo Un’estate con Omero, due sole risposte possibili: «O gli dei sono veramente esistiti e hanno insufflato in lui una sorta di prescienza, ispirandogli le proprie agiografie. I suoi versi premonitori sarebbero stati dunque destinati ad arrivare fino a noi. Oppure i temi che attraversano i poemi omerici - la guerra e la gloria, la grandezza e la dolcezza, la paura e la bellezza, la memoria e la morte - sono il combustibile del braciere dell’eterno ritorno».