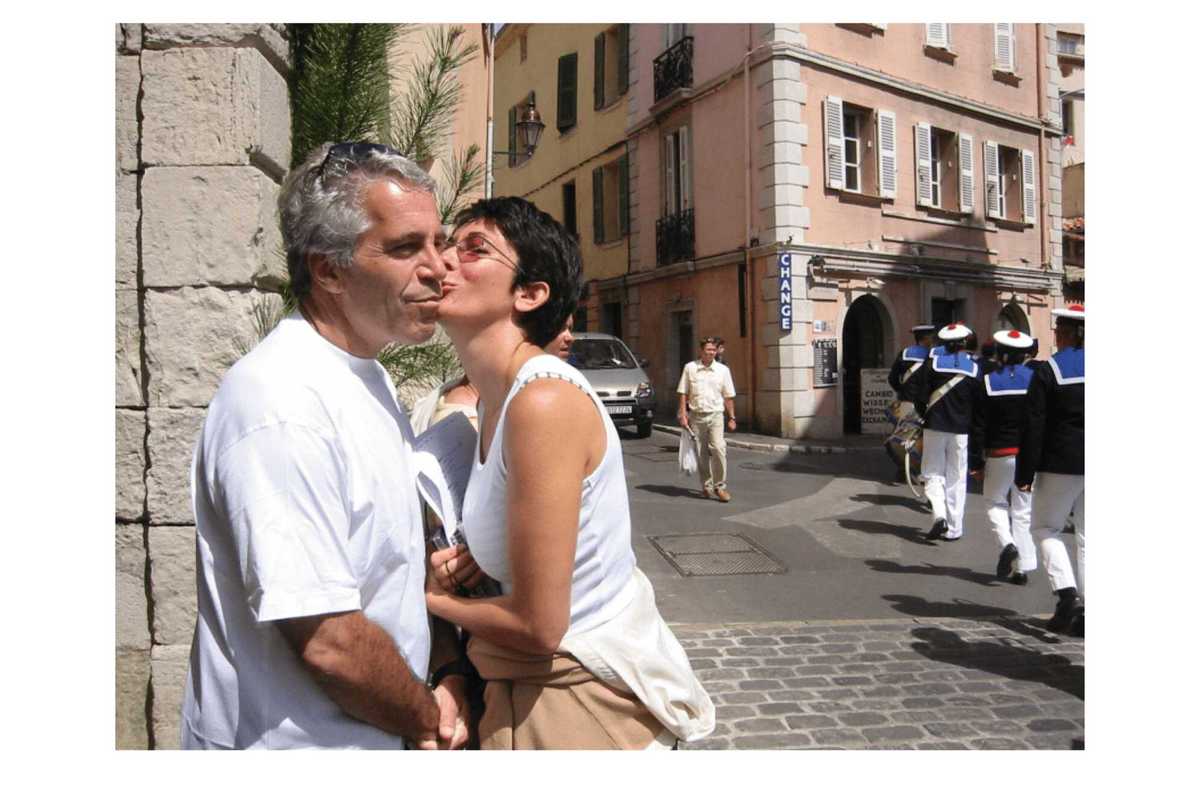A inizio 2020 Gratteri andò a un appuntamento con Giggino Di Maio, all’epoca ministro degli Esteri, portandosi dietro un ospite non invitato: lo 007 Marco Mancini, immortalato con Matteo Renzi in un’area di servizio in autostrada.
Un agente segreto di lungo corso, con cui il magistrato ha un consolidato rapporto personale, tanto da averlo consigliato ai cinque stelle, come certificato dal Fatto Quotidiano, in periodo di nomine pubbliche.
Gratteri minimizzò: «Mi aveva chiamato per salutarmi, gli ho risposto che stavo andando da Di Maio, mi ha chiesto se poteva accompagnarmi. Tra lui e il ministro c’è stato uno scambio di saluti veloce, sarà durato un minuto» (così Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian su Domani del 17 maggio 2021).
Certo, il Franti che è in me si chiede: ma se tale episodio fosse capitato a un altro, l’inquisitore Gratteri l’avrebbe valutato con altrettanta indulgenza?
Il bello è che a una certa sinistra Gratteri risulta indigesto.
Leggere per credere i complimenti che gli rivolge, in un’intercettazione, Emilio Sirianni, «giudice della corte di appello di Catanzaro, leader di Magistratura Democratica, paladino della sinistra giudiziaria, amico e consulente dell’icona dell’accoglienza che tanto piace alla gente che piace», cioè il sindaco di Riace Mimmo Lucano (così Luca Palamara, radiato dall’ordine giudiziario nel 2020, e Alessandro Sallusti nel libro-intervista Lobby & Logge, Rizzoli 2022, secondo capitolo della trilogia iniziata con Il Sistema, 2021, e conclusasi con Il Sistema colpisce ancora, 2026).
Lucano è preoccupato dalla laconica risposta data da Gratteri a Giovanni Floris su La7, che avanzava dubbi sulla fondatezza dell’inchiesta su Lucano medesimo: «Sarei cauto, bisogna leggere bene le carte».
Sirianni lo rassicura: «Lascialo stare, è un fascista di me..., ma soprattutto un mediocre e ignorante».
Nel 2014 Renzi lo voleva nel suo governo. Come ministro di Giustizia.
Non possumus, lo stoppò il capo dello Stato Giorgio Napolitano.
Come mai?
«Quando era ancora in vita il presidente emerito, a chi mi domandava cosa fosse successo, replicavo: andate a chiedere a lui, non perché non mi ha voluto ministro, ma su chi è stato a consigliarlo in tal senso», così Gratteri il 12 aprile 2025 Su La7.
L’identikit dei suggeritori lo forniscono Palamara e Sallusti: «Roma è grande ma certe notizie girano veloci come in un borgo, il Quirinale è preso d’assalto dai procuratori più importanti - lo stesso Giuseppe Pignatone (30 anni nel Palazzo di Giustizia di Palermo, quindi capo della procura di Reggio Calabria dal 2008 al 2012, infine di quella di Roma fino al 2019, nda) confiderà di aver avuto in quelle ore “contatti” - e dai capicorrente dell’Anm».
Capita l’aria che tira, «Napolitano prende atto che la cosa non si poteva fare».
Altro che rispetto tra istituzioni autonome: qui ce n’è una che condiziona le altre con i suoi suggerimenti, veti e diktat, ma tiremm innanz.
Gratteri è affetto da una certa qual incontinenza mediatica.
«Un protagonista che si ammanta di protagonismo per far parlare di sé» lo ha fotografato un esperto del ramo, Antonio Di Pietro.
Che al Foglio - dopo aver premesso: «È persona che stimo sul piano professionale pur non condividendone l’operato» - ha riassunto così il gratterismo: «Gratteri non ha vergogna di quel che dice, anche se dice il falso, perché sa che verrà creduto a prescindere. Non si prova vergogna quando s’è raggiunto, come lui, uno stato di grazia, lo stesso che toccò a me ai tempi di Mani pulite».
Male che vada, potrà sempre sostenere che le sue frasi sono state «fraintese», «estrapolate dal contesto», «strumentalizzate».
Come quando citò un’intervista a Giovanni Falcone del 25 gennaio 1992, in cui quest’ultimo si sarebbe espresso in maniera inequivocabile contro la separazione delle carriere.
Peccato che di essa «non ce n’è traccia, non esiste, è solo una dichiarazione falsa periodicamente utilizzata soprattutto sui social», così il Post del 12 novembre scorso.
Perché Falcone, quello vero, il 3 ottobre 1991 si era espresso a favore della riforma con Mario Pirani di Repubblica: «Chi, come me, richiede che siano invece due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il pm sotto il controllo dell’Esecutivo».
Va detto che il 17 novembre Gratteri riconoscerà il «mentone»: «Ho letto la finta intervista a Falcone da Giovanni Floris perché me l’hanno mandata persone serie e autorevoli dell’informazione», e amen.
Peggio è andata con l’intervista video al Corriere della Calabria: al referendum sulla Giustizia «per il No voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente».
Dichiarazione surreale, tanto più per il sottoscritto, figlio di un calabrese pluridecorato della Guardia di Finanza: come se Gratteri escludesse la possibilità che possa essere onesto anche chi opterà per il Sì.
Pure sul sorteggio, quale metodo di composizione eccellente per il Csm, previsto dalla riforma, sarebbe stato «mistificato».
Sul palco della festa del Fatto Quotidiano, nel 2021, aveva sentenziato: «Il sistema migliore è il sorteggio puro, anche a costo di cambiare - se è necessario - la Costituzione».
C’è in giro «gente in malafede che chiama sorteggio un elenco di prescelti della politica», l’ha grattuggiata Gratteri: «Il testo proposto sul sorteggio, temperato per i politici e secco per i magistrati, è molto lontano da quella che era la mia idea» ha puntualizzato il 20 gennaio.
Di Pietro: «È un uomo che ha fatto molto per stanare il crimine. Ma la sua è stata una pesca a strascico che ha tirato dentro tanti innocenti».
Gennaio 2018, operazione Stige contro la ’ndrangheta, 169 arresti.
«È solo l’inizio della guerra» tuona Gratteri in modalità generale Patton, «la più grande operazione fatta negli ultimi 23 anni», «un’indagine da portare nelle scuole della magistratura».
Speriamo di no, visto che è finita, sette anni dopo, con meno della metà degli arrestati condannati: «Secondo i calcoli dell’avvocato Francesco Verri, legale di diversi imputati, «tra rito abbreviato e rito ordinario ci sono state circa 100 assoluzioni su 169 arresti», così il Foglio del 27 novembre scorso.
Dopo l’ambiziosa Stige, ecco nel dicembre 2019 la leggendaria Rinascita-Scott.
334 arresti, 416 indagati, 13.500 pagine di ordinanze di custodia cautelare, «la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo», aridanga, e questo perché dal giorno del suo insediamento Gratteri aveva pensato di «smontare la Calabria come un treno Lego, per poi rimontarla piano piano» (e io, ingenuo, che credevo che i magistrati dovessero applicare le leggi, non guidare una palingenesi antropologica).
Il giorno dopo Gratteri, sfogliati i giornali, scriverà un tweet da ego ferito: «La maxi-operazione scompare dalle prime pagine dei grandi giornali: niente su Stampa e Repubblica, un box sul Corriere». Delusione ribadita da ospite di Maria Latella a SkyTg24: «I giornali nazionali hanno boicottato la notizia, il Corriere l’ha data in ventesima pagina, Repubblica e Stampa verso la 15-16esima».
Bilancio a consuntivo? «69 scarcerati già in fase di Riesame, in primo grado 131 assoluzioni contro 207 condanne, in appello altre 50 assoluzioni e 11 prescrizioni».
Risultati che fanno della Calabria la regione che «assorbe più di un terzo dei risarcimenti per errori giudiziari», così Gaetano Mineo sul Tempo del 15 febbraio 2026: «Dal 2018 al 2024, 78 milioni, il 35% di quanto pagato complessivamente dallo Stato per ingiuste detenzioni, 220 milioni», con un tasso di innocenti detenuti quattro volte superiore alla media nazionale, in una regione che ha una popolazione che è il 3% di quella totale.
I maxi-blitz sono figli della madre di tutte le retate, quella contro la camorra nel 1983 che stroncò la carriera, e poi la vita, di Enzo Tortora: 856 ordini di cattura, 640 rinvii a giudizio.
E i 216 in più? Prosciolti in istruttoria, anche per via di oltre 90 casi di omonimia, «in un paese dell’hinterland ne hanno arrestati 10 per prenderne uno, e tra i 10 quell’uno non c’era», così Lino Jannuzzi su Reporter del 23 settembre 1985.
La Procura di Napoli filosofeggiò: «È come quando si taglia una forma di parmigiano: nel conto bisogna mettere anche lo sfrido», le briciole (così Paolo Gambescia sul Messaggero del 2 luglio 1983).
Il fine giustifica i mezzi, insomma.
Il che va benissimo.
Se lo «sfrido» non sei tu.