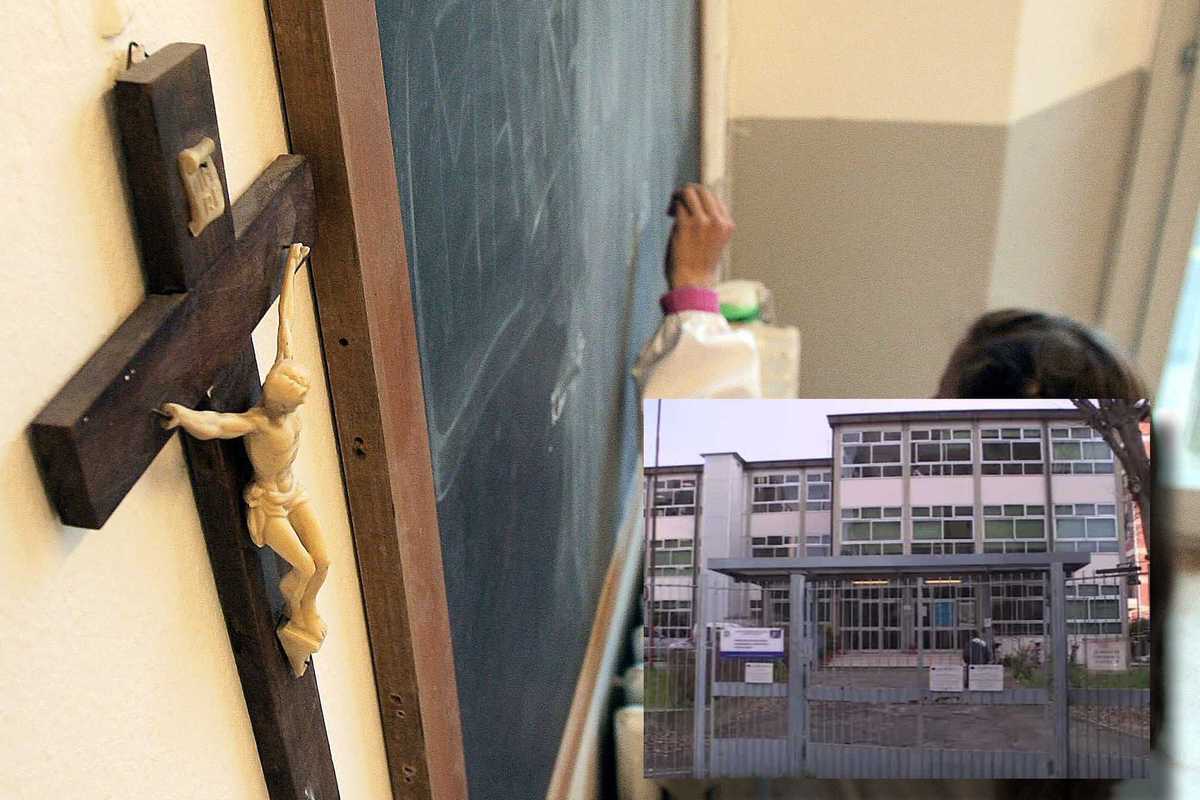Nel cimitero parigino di Père-Lachaise tra le tombe di Gioachino Rossini, Fryderyk Chopin, Honorè de Balzac, Oscar Wilde, Amedeo Modigliani, Moliere, la Fontaine e di altri celeberrimi personaggi, c’è un antico e curioso sepolcro circondato da piante di patate. Bellissima la fioritura, un trionfo di petali bianchi e capolini gialli. Sull’architrave ci sono più patate che in un negozio di fruttivendolo, le bucce incise di merci, grazie. «Merci pour le purèe» «Merci pour les frites» «Merci per les pommes de terre». È il popolo parigino che esprime così la sua riconoscenza ad Antoine Augustin Parmentier che riposa in quell’urna da oltre due secoli. Fu Parmentier (1737-1813), farmacista, agronomo e nutrizionista, a «scoprire» la patata. Non fu lui a inventare il purè, ma Joël Robuchon definito il «miglior cuoco del Novecento», e sulla paternità delle patate fritte c’è una disputa infinita tra valloni e francesi. Ma fu Parmentier a capire e promuovere il valore alimentare e la bontà del Solanum tuberosum sbarcato in Europa due secoli e mezzo prima, ma considerato per tutto questo tempo più cibo per maiali che per cristiani. Qualche re ne proibì perfino il consumo.
La batata, tanto apprezzata dagli Inca, nel Cinquecento, nel Seicento e all’inizio del Settecento, fu considerata soprattutto una pianta ornamentale, bella per i fiori, ma infida come cibo. Era un ortaggio arcano, inaffidabile, criptico. Sorta di bitcoin del sottosuolo, è stata ritenuta a lungo pericolosa. Nascere sottoterra aggravava la sua posizione. Per molti era uno sgorbio sulfureo da imparentare col diavolo. I no-patata tirarono in ballo la Bibbia: in nessun passo, dicevano, il libro sacro nomina questo aborto di natura. Ergo, non si deve mangiare. Chi ribattè che la Bibbia non nominava nemmeno l’America, ma questo non impediva di depredarla dell’oro, dell’argento e delle pietre preziose di cui era ricca, non fu ascoltato.
La povera patata, rigoletto degli ortaggi, fu oggetto di altre infamanti falsità. Fu accusata di essere velenosa e di avere infettato parecchi cristiani. Si scoprirà più tardi che gli avvelenamenti non erano dovuti al tubero, ma alle parti della pianta cariche di tossica solanina. L’ortaggio fu perfino incolpato di provocare la lebbra e la peste in quanto, destinata ai maiali considerati animali infernali, trasformava i suini in portatori delle terribili malattie.
Gli studi di Parmentier ribaltarono queste farlocche idee rivoluzionando la cucina francese e quella europea, valorizzando il tubero stortignaccolo e sporco di terra. La patata lo aveva salvato dall’inedia quando era prigioniero in Prussia, dove il popolo già ne faceva uso. Lui contraccambiò facendola apprezzare dai diffidenti ghiottoni parigini e da tutti quelli che arricciavano il naso di fronte ad un piatto di patate. Italiani compresi.
Alla fine, più della pessima fama, fu la potente fame dell’accresciuta popolazione europea ad accettare la patata come cibo e sdoganandola nell’alimentazione quotidiana. Anche i governi del Vecchio Continente fecero finalmente la loro parte, finanziando le ricerche su nuovi vegetali che potessero sostituire i cereali nei periodi di carestia ed evitare così che i popoli affamati si ribellassero (vedi la Francia). Olandesi, tedeschi, irlandesi, inglesi e italiani impararono, chi prima e chi dopo, dalla seconda metà del Settecento, ad apprezzare il Solanum tuberosum. E non poterono più farne a meno.
L’umile e utile ortaggio francescano dimenticò i torti subiti salvando cristiani e sottraendo masse di persone alla fame, alla malattia e alla morte. Quando la patata veniva a mancare a causa di qualche malattia della pianta, la gente moriva in massa. In Irlanda, nel 1845, nella terribile carestia di patate provocata dalla peronospora, un milione di figli di San Patrizio morì di fame, di tifo e scorbuto. Un milione e mezzo dovette emigrare in America. L’isola si svuotò. Prima della carestia contava otto milioni di abitanti, alla fine del 1846 ne aveva meno di sei.
Convinto della bontà della ricerca di Parmentier, re Luigi XVI appoggiò il progetto di coltivazione in largo stile concedendogli parecchi campi a Neully-sur-Seine, alla periferia di Parigi. Parmentier mise in atto ogni astuzia per convincere i suoi concittadini a consumare i pommes de terre. Inventò golose ricette, come la Potage Parmentier una crema fatta con patate, porri, brodo vegetale e panna liquida, dimostrando che i cuori e le menti si conquistano passando per il palato. Ricorse anche a un trucco: recintò i campi di patata reali, mise soldati di ronda e fece circolare la voce che in quel posto nascevano i pomi del sottosuolo di cui Luigi era ghiotto. Guai a toccarli. Era un invito a rubare. E il popolo, già propenso a togliere a Luigi tutto quello che possedeva (alla fine gli toglierà anche la testa), diventò ladro. Soddisfatto del successo del progetto il sovrano si presentò a un ballo di corte nel 1775 con un fiore biancoroseo di patata sul bavero e ne sistemò uno sulla parrucca di Maria Antonietta. «Monsieur Parmentier», disse, «la Francia un giorno vi ringrazierà per aver trovato il pane dei poveri».
Se la patata non ci fosse bisognerebbe inventarla. Si trova bene sulla mensa del re e sul tavolaccio del casolare contadino. S’adegua alla caserma dove c’è sempre qualche recluta messa a pelare montagne di patate e al lager dove molti sono sopravvissuti grazie alle bucce di patata. Si conforma alla mensa borghese e a quella operaia, all’alta cucina e all’osteria. La patata si esalta nella kartoffelsuppe altoatesina e nel padellone arrosto delle rostkartoffel; nella zuppa siciliana di patate e porri; nella minestra di pane pratese e nel minestrone calabrese; nella zuppa della Val Camonica e nella schiscionera sarda. È ottima vellutata, bollita, in insalata, al forno. Fantastico il purè, le polpette e le crocchette. Con la patata si preparano frittate, gateau, soufflè, torte salate e perfino pizze con le patatine fritte. Ma questa è un’americanata. Vogliamo mettere la marinara e la margherita.
In Italia la patata mise radici verso la metà del Settecento. Uno dei pionieri fu l’avvocato piemontese Giovanni Vincenzo Virginio che dilapidò il patrimonio familiare per coltivare e organizzare manifestazioni in piazza offrendo patate gratis e stampando opuscoli di divulgazione convinto delle caratteristiche nutritive della patata. Morì senza avere le soddisfazioni di Parmentier. Ma alla fine la patata convinse e vinse. E il mondo contadino trasformò questa vittoria in proverbio: «Con patate e cipolle dell’orto nessuno è mai morto».
Trasformata in gnocchi nell’Ottocento conquista la cucina povera italiana. È il cuoco scrittore napoletano Vincenzo Corrado a pubblicare nel Cuoco Galante (1801) la prima ricetta italiana degli gnocchi di patata. Gli gnocchi rimangono poveri fino alla fine del XIX secolo. Poi entra in scena Pellegrino Artusi che con La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene li fa approdare alla cucina borghese suggerendo anche il modo per vestirli di sugo: scavarli col pollice sul rovescio di una grattugia. Ma il miglior modo di far morire la patata è friggerla nell’olio. Le patatine fritte piacciono a tutti: ai bambini, alle loro mamme, a top model, attori, giornalisti, critici gastronomici, cuochi tristellati. Piacciono a Kit Carson e Tex Willer che finalmente, dopo tanti «frugali pasti» consumati nella prateria, si concedono una bistecca alta una spanna sepolta sotto una montagna di patatine fritte.
Tozza, sporca di terra eppure umana e poetica. Per Pablo Neruda la patata è una sorella. Figli della stessa terra, le dedica un’ode. La chiama col suo nome andino: papa. «Papa/ ti chiami,/ papa/ e non patata,/ non sei nata con la barba,/ tu non sei castigliana,/ sei scura/ come/ la nostra pelle,/ siamo americani/ papa, siamo indios».