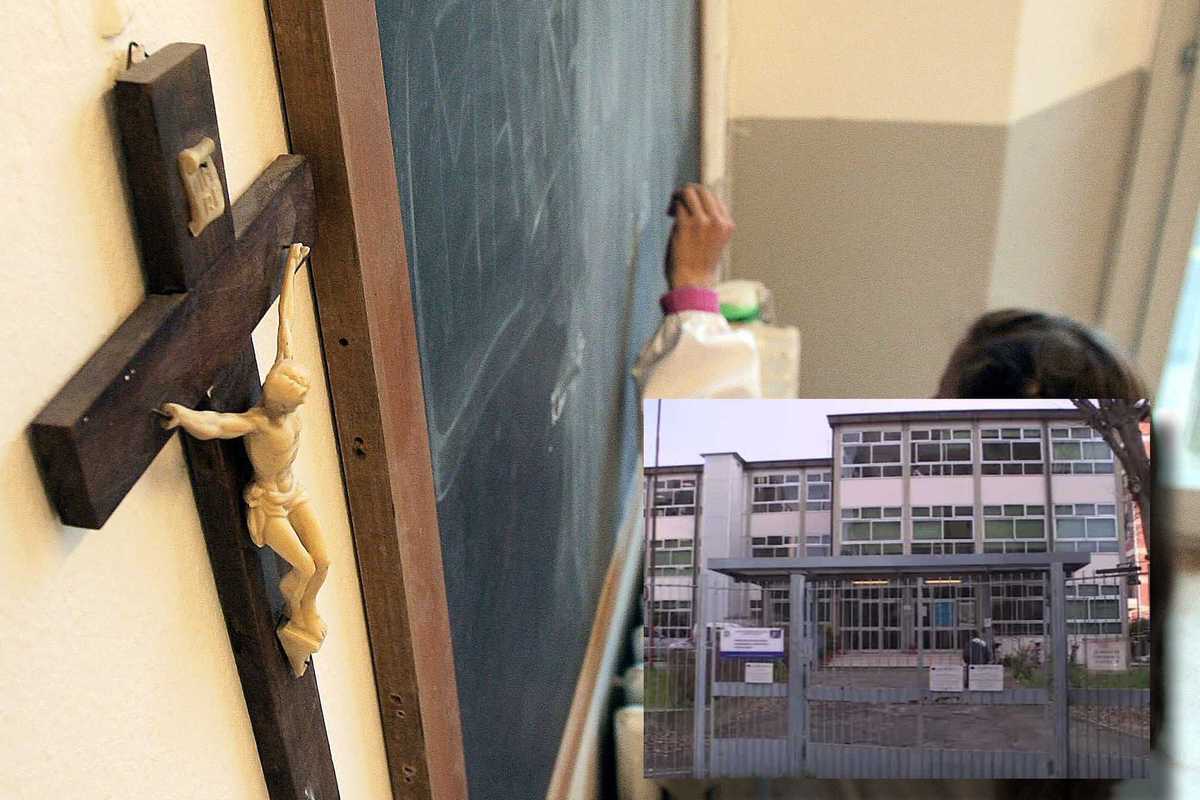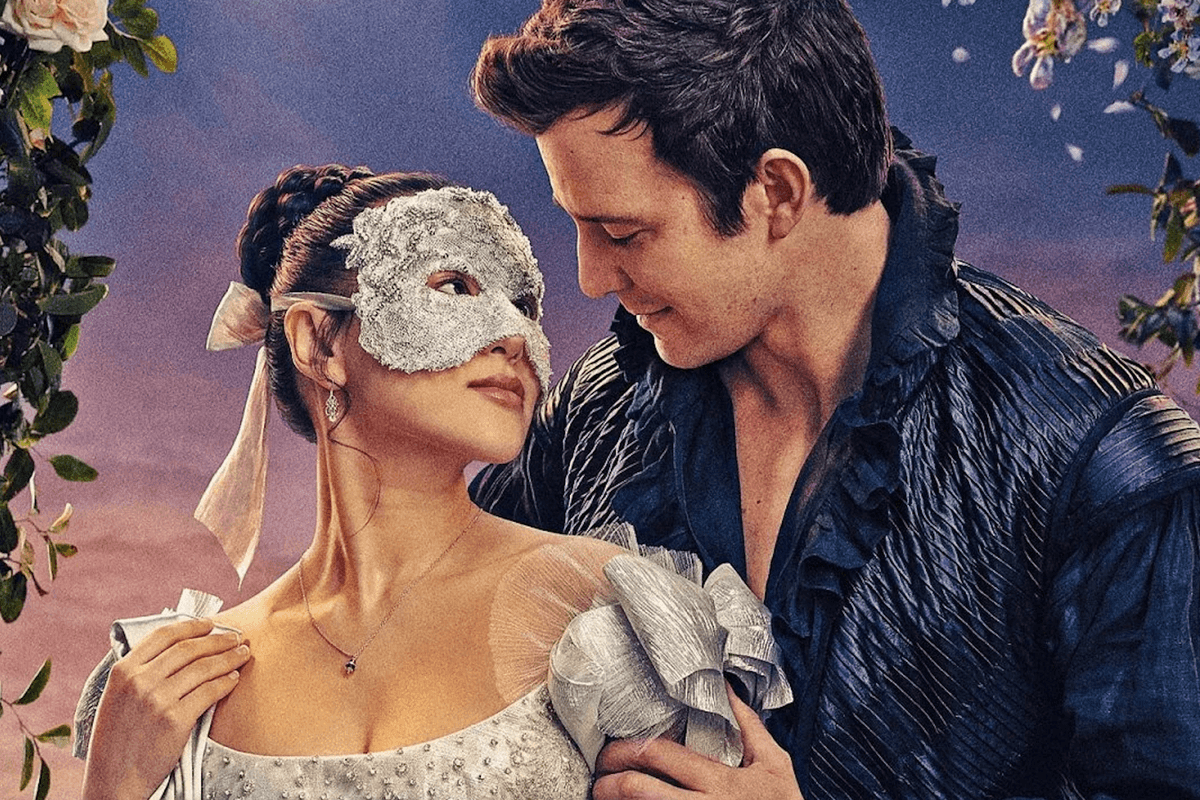La Lagarde premia lo studio che smonta le teorie Ue: tassa sulla CO2 crea povertà

Si ripete come un mantra: la crisi economica derivante dal caro gas è causata dalla guerra di Putin. Ormai è diventato un assioma, eppure le persone, gli imprenditori lo sanno: le bollette hanno cominciato a lievitare molto prima, almeno dall’autunno del 2021. Ed è proprio a settembre di quell’anno che Diego Känzig della London business school pubblicava un paper che spiegava quali sarebbero state le conseguenze economiche delle politiche green. Prevedendo quindi esattamente la tempesta energetica, sociale e finanziaria in cui ci troviamo adesso. «In che modo il prezzo del carbonio influisce sull’economia?», si chiede nel testo. «Riesce a ridurre le emissioni e come influisce sulla disuguaglianza economica?». La risposta è tutt’altro che banale e disegna per filo e per segno la crisi che stiamo vivendo adesso. Il cambiamento climatico ha segnato negli ultimi anni una priorità chiave per i policy makers di tutto il mondo. Un ampio accordo ha stabilito di dare un prezzo alle emissioni di carbonio al fine di mitigare gli effetti dell’inquinamento ritenuto responsabile del surriscaldamento globale. Diversi Paesi, quindi, hanno adottato politiche nazionali di determinazione dei prezzi del carbonio come carbon tax o sistemi cap and trade. Il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (Eu emissions trading system, anche noto con l’acronimo Eu Ets) è il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per controllare le emissioni di inquinanti e gas a effetto serra. Ogni quota comporta il diritto ad emettere una tonnellata di CO2. Il tetto massimo, che viene ridotto ogni anno, determina il numero di quote disponibili nell’intero sistema. Le imprese possono ottenere quote attraverso l’allocazione gratuita, la vendita all’asta o l’acquisto da terzi. Il fatto che le quote sono messe in circolazione in numero finito determina il prezzo del carbonio grazie all’equilibrio tra la quantità di quote di emissioni e la domanda del mercato. Attraverso la riduzione progressiva delle quote di emissione si ottiene l’aumento del prezzo del carbonio. Questo sistema, secondo lo studio, effettivamente produce una riduzione delle emissioni. Poco si sa invece degli effetti economici di tali politiche. Nel breve termine secondo quanto scrive Känzig produrranno enormi costi economici e importanti conseguenze distributive, dall’inflazione al rincaro di tutte le fonti energetiche.
Nello specifico si legge: «Uno shock della politica del carbonio che inasprisce il regime dei prezzi del carbonio provoca un forte e immediato aumento dei prezzi dell’energia. Tutto questo ha un costo, aumentano significativamente i prezzi al consumo e diminuisce l’attività economica, il che tradotto significa minore produzione e maggiore disoccupazione». Aggiunge che secondo le sue previsioni basate su calcoli econometrici: «Il mercato azionario crolla per un anno e mezzo» anche se si attende un rimbalzo e «l’euro si deprezza in termini reali mentre le importazioni crollano in modo significativo». È importante sottolineare che le ricadute economiche non sono equamente distribuite nella società. Spiega: «Mentre la spesa delle famiglie a reddito più elevato diminuisce solo marginalmente, le famiglie a basso reddito vedono ridurre le proprie spese in modo significativo e persistente. Queste famiglie, per altro, sono colpite in due modi: in primo luogo, spendono una quota maggiore della loro disponibilità di reddito per la bolletta energetica lasciando molte meno risorse per altre spese. In secondo luogo, sperimentano anche la crisi del reddito più grave, tendendo a lavorare in settori più esposti al prezzo del carbonio».
La soluzione che propone è quella di mitigare gli effetti di queste politiche con delle politiche fiscali e monetarie mirate. Il paper mostra anche che il prezzo del carbonio porta a un calo significativo nel sostegno delle politiche legate al clima tra famiglie a basso reddito. Pertanto, tali compensazioni mirate possono anche aiutare ad aumentare il sostegno pubblico a tali politiche. Ed è qui che si innesca il cortocircuito. Il presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, poco dopo la pubblicazione di questo paper, decide di premiare il ricercatore Diego Känzig come vincitore dei giovani economisti proprio grazie al lavoro pubblicato. Scrive: «Congratulazioni a Diego Känzig, vincitore del concorso per giovani economisti di quest’anno, per il suo articolo sulle conseguenze economiche di un prezzo al carbonio. La ricerca innovativa è essenziale per un’economia prospera. Grazie a tutti i nostri finalisti per i vostri impressionanti contributi». Viene il dubbio se abbia letto davvero questo importante lavoro, perché senz’altro l’avrebbe aiutata a comprendere quali politiche attuare per intervenire nella mitigazione della crisi in cui ci troviamo. Compreso i picchi di inflazione.
È vero che le politiche energetiche non riguardano direttamente la Bce ma è anche vero che producendo un impatto così significativo in materia di distribuzione economica e nel marchingegno dell’inflazione Francoforte è chiamata in ogni caso in ballo. Le soluzioni ci sarebbero, scritte nere su bianco e pubblicate da ricercatori (premiati) di alto prestigio, eppure non si fa nulla. Cui prodest?