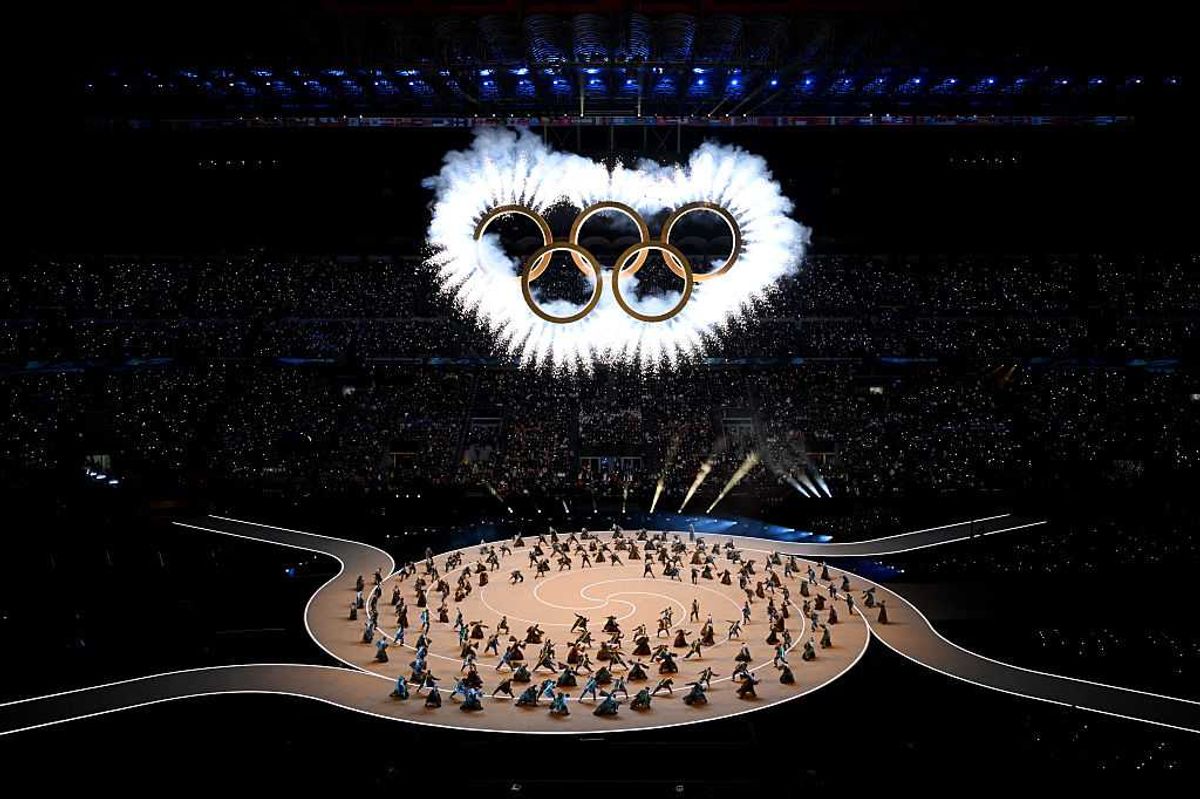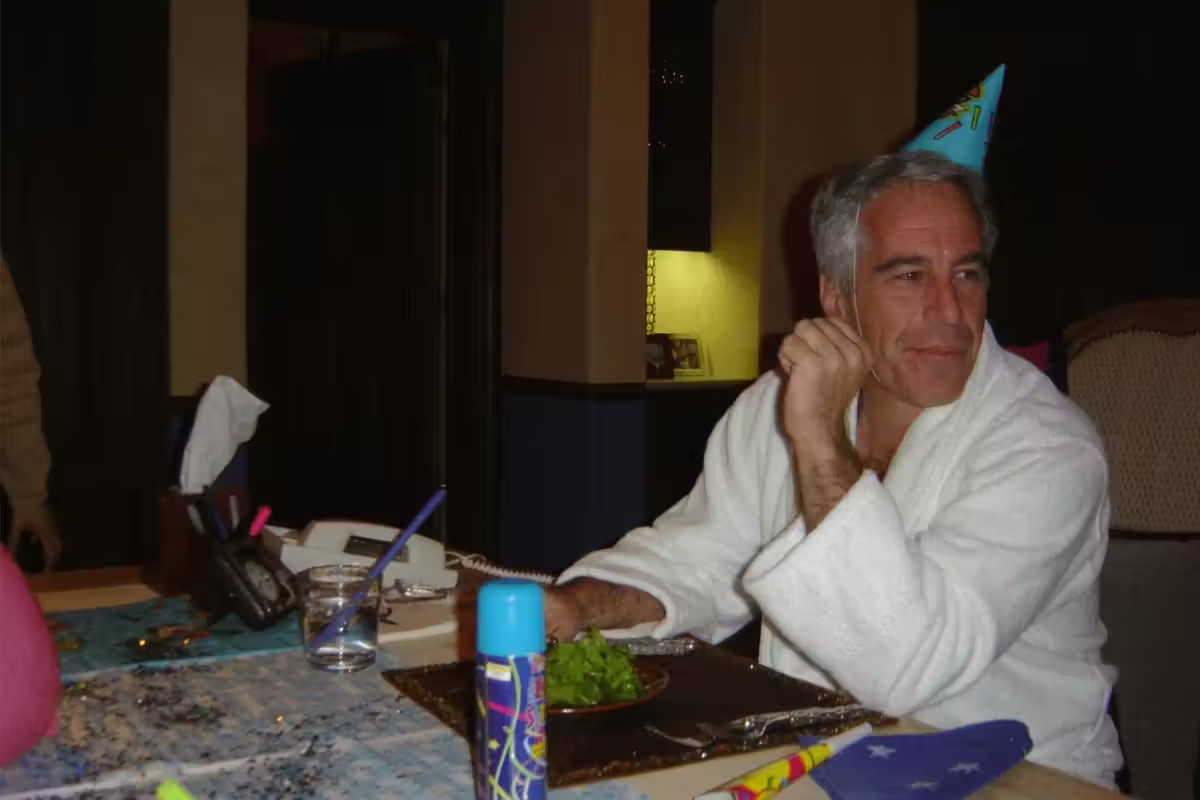«L’astuzia presuppone una intenzione dissimulata: sta dunque a una maniera di agire chiara e dritta come il sofisma sta a una prova serie e diretta». Queste parole di Karl von Clausewitz si attagliano perfettamente alla figura di Henry Kissinger: l’ex segretario di Stato americano, morto ieri all’età di cento anni.
Di famiglia ebraica tedesca, fuggì dalla Germania nel 1938 a causa delle persecuzioni naziste. Stabilitosi negli Usa, intraprese la carriera accademica ad Harvard. Si avvicinò quindi al mondo politico, diventando consigliere per gli affari internazionali di Nelson Rockfeller, che fu più volte candidato invano alla nomination presidenziale repubblicana. Il suo legame con Richard Nixon non era scontato. I due non si amavano. Tuttavia capirono ben presto di aver bisogno l’uno dell’altro. Kissinger si schierò con Nixon, non appena quest’ultimo vinse la nomination del 1968. Nixon, dal canto suo, capì che il brillante accademico avrebbe potuto tornargli utile e lo nominò consigliere per la sicurezza nazionale. Erano gli anni della crisi vietnamita. Sprofondati nel pantano a seguito della linea intrapresa da Lyndon Johnson, gli Usa avevano deciso di affidarsi a Nixon per cercare di archiviare finalmente il disastro. Fu così che Kissinger si ritrovò catapultato nella stanza dei bottoni in una fase storica assai delicata: il Vietnam aveva posto gli Usa davanti alle loro peggiori paure, mentre il senso di invincibilità e di risorse illimitate emerso dalla fine della Seconda guerra mondiale era improvvisamente tramontato. Kissinger decise quindi di abbandonare la costosa politica del contenimento alla Harry Truman, rispolverando i vecchi crismi della politica di equilibrio, che, secondo lui, erano stati principalmente incarnati dal Congresso di Vienna e dalla Pace di Vestfalia.
È in quest’ottica che elaborò una fitta rete di mosse dagli esiti paradossali. Avviò una distensione con l’Unione Sovietica di Leonid Breznev ma, al contempo, sfruttò la rivalità tra Mosca e Pechino, predisponendo lo storico viaggio di Nixon nella Repubblica popolare cinese, avvenuto nel 1972. Un’apertura, quella a Mao Zedong, che avvenne con il preciso obiettivo di indebolire indirettamente il Cremlino, rafforzando sul piano diplomatico e politico il suo concorrente nell’universo comunista.
Dall’altra parte, gli accordi di Parigi del 1973, che Kissinger aveva raggiunto con Le Duc Tho per arrivare alla pace in Vietnam, posero indirettamente le basi per un incremento delle tensioni tra la Cina e il Vietnam.
Il realismo di Kissinger, insomma, è sempre stato innervato da una potente dose di machiavellismo. Distensione e diplomazia sono stati da lui usati come strumenti non solo per supplire ai problemi geopolitici di Washington ma anche per fiaccare gli avversari di quest’ultima, in una serie di ribaltamenti dialettici che si sono talvolta verificati successivamente alla sua uscita di scena. Ecco qui l’astuzia, la dissimulazione. Il fautore della distensione che disseminava scaltramente trappole sul cammino dei suoi avversari. Un ruolo, quello di Kissinger, accresciutosi dopo la sua nomina a segretario di Stato e, soprattutto, durante lo scandalo Watergate che travolse Nixon. Un cataclisma da cui il Nostro uscì indenne, mantenendo il proprio incarico anche con Gerald Ford.
Kissinger ebbe anche significativi legami con il nostro Paese. Grande amico di Gianni Agnelli, definì quest’ultimo un «uomo del Rinascimento», non rinunciando inoltre a tifare Juventus. I due si erano in particolare conosciuti durante un ricevimento al Quirinale, organizzato da Giuseppe Saragat nel 1969. Senza poi ovviamente trascurare l’amicizia tra l’ex segretario di Stato e Giorgio Napolitano, da lui definito «il mio comunista preferito». Kissinger fu inoltre un oppositore del compromesso storico. Questo ci fa capire che, nonostante perseguisse una politica di equilibrio che bypassava in parte i rigidi blocchi contrapposti della Guerra Fredda, Kissinger mantenne comunque una linea inflessibilmente anticomunista in Occidente. È anche in quest’ottica che va letto il golpe cileno del 1973: golpe a cui Kissinger non era estraneo e che rovesciò il governo di Salvador Allende, il quale aveva rafforzato i legami con la Cuba castrista e con l’Unione Sovietica. Senza dimenticare che intervenne su Israele per evitare che quest’ultimo umiliasse l’Egitto durante la guerra dello Yom Kippur: una mossa per cercare di portare Il Cairo nell’orbita occidentale.
Dopo la sconfitta di Ford alle presidenziali del 1976, l’ormai ex segretario di Stato uscì di scena dal punto di vista della politica ufficiale. Nel 1980, Ford provò a negoziare una propria candidatura alla vicepresidenza con Ronald Reagan, chiedendo che Kissinger potesse tornare alla guida del Dipartimento di Stato in una nuova amministrazione repubblicana. Reagan rifiutò e non se ne fece nulla. L’ex segretario di Stato ha quindi svolto un’attività ufficiosa (ma non meno influente) di consigliere per molti dei presidenti americani succedutisi nel tempo, soprattutto sui rapporti con Pechino. Sul dossier cinese, negli scorsi anni ha più volte raccomandato una distensione nelle relazioni tra Washington e il Dragone, esortando a evitare quella che definiva una possibile nuova Guerra fredda. È poi intervenuto sulla crisi ucraina. Nel marzo 2014, Kissinger invocò la neutralità di Kiev, mentre a maggio 2022 suggerì che la Russia avrebbe dovuto abbandonare i territori occupati dopo il 24 febbraio di quell’anno, mantenendo invece il controllo sulla Crimea: una posizione che fu criticata dal governo ucraino. L’ex segretario di Stato cambiò idea lo scorso gennaio, definendo un «risultato appropriato» l’eventuale ingresso di Kiev nella Nato. È scontato dire che Kissinger sia stato un protagonista del Novecento. E questo indipendentemente dalla sua Realpolitik che ha sempre avuto entusiasti ammiratori e accaniti detrattori. La grandezza, si sa, non necessariamente implica giudizi di valore positivi né è scevra da aspetti controversi: aspetti che, neanche a dirlo, nella figura di Kissinger abbondavano. Ma la grandezza va studiata proprio perché è complessa. Kissinger non ci lascia un esempio da seguire. Ci lascia un metodo da comprendere. Un metodo che potrà piacere o non piacere. Ma che ci fa capire come la politica abbia una natura più profonda di certo semplicismo molto in voga oggi.