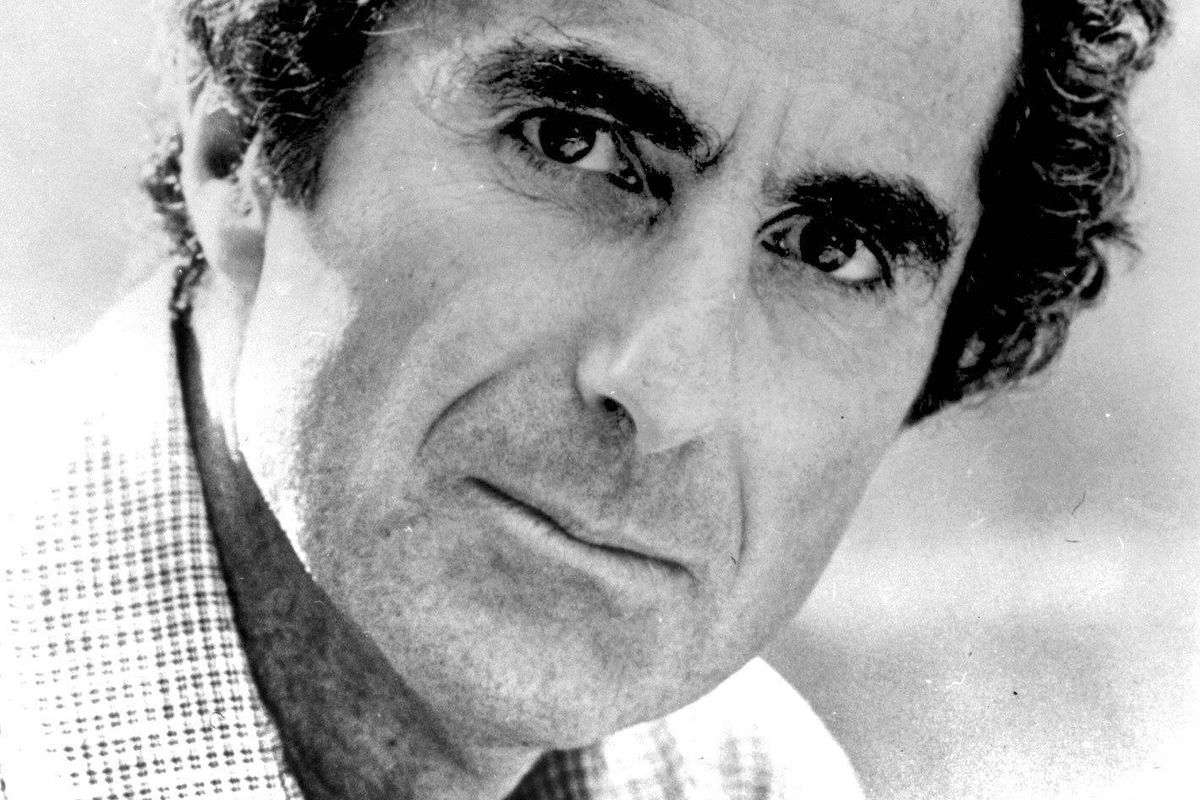
Un giorno si alzò, guardò fuori dalla finestra nell'Upper West Side di Manhattan dove aveva vissuto l'ultimo mezzo secolo alternandolo con un cottage nel Connecticut, e decise che avrebbe smesso di scrivere. «Verso l'orizzonte si alzava il fumo nero di un incendio. Qualcosa bruciava ma non ero più io. Io semplicemente non avevo più niente da dire». Era il 2012 e Philip Roth spegneva il cervello, come un Cristiano Ronaldo, un Valentino Rossi, un Andrea Bocelli a fine corsa, nel giorno predestinato. «Raccontare storie per me era tutto. Ora non lo è più», aggiunse. E cominciò lentamente a morire, tanto che la sua ultima battuta, feroce come sempre, fu: «Chiamatemi il più grande scrittore morente».
È riuscito a completare l'opera ieri notte, a 85 anni, per via di un'insufficienza cardiaca. Lo ha fatto una settimana dopo Tom Wolfe, due giganti evaporati nel tempo in simultanea, mentre nel mondo si moltiplicano i blogger. Roth era un numero uno, in realtà aveva smesso di scrivere perché il mal di schiena era diventato insopportabile ed era costretto a farlo in piedi. Non sarebbe neppure il caso di aggiungere che non ha mai vinto il premio Nobel, se non fosse per l'accanimento dei giurati. I parrucconi dell'Accademia di Svezia non glielo hanno proprio voluto dare, imbastendo con lui un lungo braccio di ferro: ogni anno era in pole position, ogni anno veniva scartato. Troppo corrosivo, troppo maledetto, troppo caustico, troppo libertino, forse troppo intelligente per le vestali del Luogo Comune letterario.
Gli hanno fatto pagare una vita da anticonformista, trascorsa a sparare sentenze contro i balletti del potere «perché tutto quello che ho per difendermi è l'alfabeto; è ciò che mi hanno dato al posto di un fucile». Loro lo mandavano al rogo e lui li snobbava sostenendo che Dio in sette giorni ha inventato gli uccelli, i fiumi, gli esseri umani, ma non ha avuto dieci minuti per inventare la letteratura. «Ci saranno gli idraulici, ci saranno i medici. Ma la letteratura a che serve? Per piacere, sto creando un universo, mica un'università».
Nato a Newark (New Jersey) nel 1933 in una famiglia ebrea piccolo borghese, non ha fatto altro che scrivere. Non è stato un pugile, non ha fatto il ladro, non ha scaricato cassette al mercato del pesce. Si è limitato a sfornare romanzi memorabili partendo da piccole storie di quartiere, da racconti di uomini da marciapiede. «Con semplicità, inesperienza e parecchio entusiasmo» ricordava recentemente, «lo scrittore in embrione che ero scrisse queste storie intorno ai suoi vent'anni, mentre si laureava all'università di Chicago, faceva il soldato nel New Jersey e a Washington e, dopo aver lasciato l'esercito, tornava a Chicago a insegnare inglese».
I suoi libri sono pietre angolari. Nel Lamento di Portnoy la grottesca ricerca della sessualità di un ragazzo si scontra con il perbenismo famigliare e un inconveniente edilizio: in casa c'è un bagno solo perennemente occupato dal padre, afflitto da una stitichezza che «cementa gli intestini». L'assurdo crocevia regala sprazzi da Woody Allen, un umorismo perfido e sottile che non lo abbandonerà mai. Ma è con Pastorale americana e Ho sposato un comunista che Roth raggiunge il paradiso del pensiero. Nel primo racconta la vita di un uomo buono che vorrebbe essere marito solido e papà perfetto (dopo essere stato il più celebrato atleta del college), ma che si ritrova una figlia così devastata da tutta questa melassa da diventare una terrorista bombarola. «Ci ha portato la guerra in casa», è la frase simbolo di un giudizio universale al contrario, dove nessuno verrà perdonato per le proprie buone azioni.
Nel secondo libro traccia un ritratto imperdibile di due divi della radio negli anni del maccartismo e scava una fossa profonda dove seppellire le illusioni del comunismo. «Il capitalismo è un sistema dove cane mangia cane», scrive Roth in un passaggio. «Cos'è la vita se non un sistema dove cane mangia cane? È un sistema in sintonia con la vita ed è proprio per questo che funziona. Guarda, tutto quello che i comunisti dicono del capitalismo è vero, e tutto quello che i capitalisti dicono del comunismo è vero. La differenza è che il nostro sistema funziona perché si basa su quella verità che è l'egoismo della gente, e il loro non funziona perché si basa su quella favola che è la fratellanza. È una favola così fantastica, che per costringere la gente a crederci hanno dovuto prenderla e spedirla in Siberia. Per costringere la gente a crederci hanno dovuto controllarne ogni pensiero o fucilarli. E intanto in Europa, in America, i comunisti continuano a raccontare questa favola anche quando sanno qual è la verità. Non c'è ragione per cui una persona di intelligenza media possa ascoltare questa storia e crederci».
A fine anni Novanta, Roth incendia la letteratura, brucia il passato come il lembo della foto di gruppo sulla copertina di Pastorale americana, dà alle fiamme le rassicuranti banalità del politicamente corretto, che ardono come le stelle («una galassia di fuoco non accesa da mano umana») destinate a sopravviverci, con la consolazione che ciascuno di noi si trasformerà in una piccola luce fissa nel cielo notturno. Folle, imprevedibile, lui diventa un uomo sgualcito dalla vita, prosciugato dalla scrittura. Capace di appostarsi a guardare cervi e folaghe nei boschi del Connecticut, per poi tornare a New York e prenderla a frustate. «Manhattan è una boutique d'Oltremare, l'America vera è nel Bronx e nel Midwest», dice anticipando i borborigmi del malessere trumpiano. Arrivano altri libri, come La macchia umana, Everyman, Nemesi, più claustrofobici, intensi, ma con un obiettivo consueto: il buonsenso comune da crivellare a colpi di mitragliatrice.
Particolare il suo rapporto con Dio. I suoi personaggi ci parlano, lo evocano, lo maledicono, ma ne fanno un perno delle loro esistenze. Lui invece segue un motto che diventa la strofa di una canzone di Tom Waits: «Non esiste il male, esiste Dio che ogni tanto si ubriaca». Lì dentro c'è tutto Philip Roth, in fondo un ebreo convinto che le altre religioni siano più o meno favolette per bambini. Una folgorante invettiva anticristiana sta nel Lamento di Portnoy. «Loro adorano un ebreo, lo sai Alex? Questa gran religione è basata sull'adorare un tale che ai suoi tempi era un ebreo di successo. Ora, non ti pare una stupidaggine? Non la chiameresti menare per il naso la gente? Gesù Cristo, che loro vanno in giro dappertutto a chiamare Dio, in realtà era un ebreo come te e me».
Misogino sorridente, prendeva l'autobus dove si divertiva a guardare la gente appesa alle maniglie per non cadere, tutti potenziali scrittori di fesserie, tutti potenziali volti dei suoi personaggi. Ma non sopportava la cosiddetta gente. Da Pastorale americana: «Capire bene la gente non è vivere, vivere è capirla male. Capirla male, e male e poi male. E dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando. Forse la cosa migliore sarebbe dimenticare di avere ragione o torto sulla gente e godersi semplicemente la gita».
È difficile far stare dentro parole non sue il Picasso della letteratura del '900. È impervio cercare di alzarsi in punta di piedi e guardare l'orizzonte che lui scrutava dai costoni innevati dell'Everest. Bisogna solo leggerlo, rispettarlo, consigliarlo. E ricordarsi la sua ultima pennellata: «Ho vissuto 50 anni in una stanza silenziosa come il fondo di una piscina, in preda a emozioni contrastanti, in una tremenda solitudine». Prima di morire per i parenti, per l'anagrafe e soprattutto per il suo agente letterario - Andrew Wylie detto lo sciacallo -, Roth ha solennemente disposto che il suo archivio venga dato alle fiamme. Perché anche l'ultimo bagliore sia quello di un incendio.






