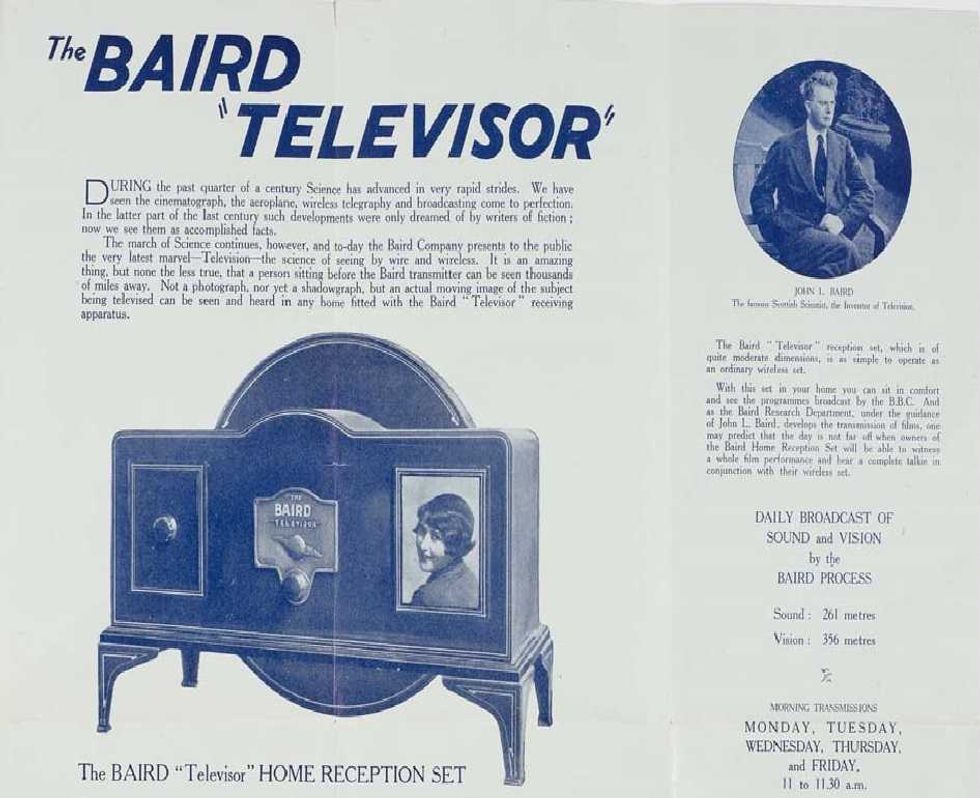Rispolverando un grande classico, il Pd, come capita regolarmente nelle giornate più delicate, si affida alla tattica dell’opossum, l’animale che si finge morto nelle situazioni di pericolo. Così, ieri, le dichiarazioni ufficiali dal Nazareno sono state poche e sorvegliatissime: giusto un tweet di Enrico Letta per rinnovare la narrazione del baratro («Giovedì la Bce presenterà i nuovi strumenti per aiutarci a combattere lo spread. Ma se il giorno prima non siamo noi a tirarci su da soli, sarà più difficile chiedere agli altri di salvarci»).
In realtà il Pd ha un obiettivo principale, di immediata sopravvivenza, e cioè evitare le elezioni a ottobre a qualsiasi costo: vedremo tra poco quali siano i quattro strumenti in campo per conseguire questo risultato. Posto che questo primo obiettivo venga centrato, il Pd conta di guadagnare 8-9 mesi per lavorare poi sulla seconda necessità, e cioè quella di imbastire una coalizione minimamente competitiva. Missione impossibile, se la campagna elettorale iniziasse o fosse iniziata dopodomani. Se invece tutto slittasse a marzo-aprile, nuovi escamotages sarebbero teoricamente immaginabili per ricominciare il gioco delle addizioni: solidificare il 20% attribuito al Pd dai sondaggi (e per farlo tornerebbero buone le battaglie identitarie su ius scholae e cannabis momentaneamente cancellate dal calendario parlamentare), aggiungere un cespuglio alla propria destra convincendo una quota dei centristi, e tentare simmetricamente di piantare un altro cespuglio anche a sinistra, magari facendo convergere l’esperienza di LeU e i grillini. Tutte cose che però richiedono tempo, e non sarebbero nemmeno ipotizzabili con una tempistica bruciante, dopo la rottura determinata da Giuseppe Conte.
Certo, l’ipocrisia domina, e non si trova un dirigente Pd di primo piano disposto a dire a chiare lettere che la strategia perseguita per due anni (il campo largo e la raffigurazione di Conte come «punto di riferimento dei progressisti») si è rivelata un flop clamoroso.
Ma, tornando alla giornata di ieri, sono stati quattro gli strumenti di accanimento terapeutico messi in campo dal Pd.
Il primo è stato il grande rito degli appelli e della mobilitazione pro Draghi. Ufficialmente, tutto spontaneo. In realtà, molto è parso sin dall’inizio «spintaneo», a partire dalla raccolta di firme dei sindaci. Ne è testimonianza la stizza dei sindaci Pd quando Giorgia Meloni ha fatto notare l’inopportunità dell’uso della carica di primo cittadino per fini politici nazionali. Come mossi da un pilota automatico, hanno subito reagito Matteo Ricci («Cara Giorgia Meloni, i sindaci italiani ragionano con la loro testa nell’interesse del paese. Non prendono ordini da nessuno. Quelli erano i podestà») e Dario Nardella («L’attacco all’appello dei sindaci dimostra nervosismo e aggressività da parte di Giorgia Meloni»). Dichiarazioni da uomini di partito: cosa che dovrebbe indurre a una riflessione chi, da destra (sindaci di Venezia, Genova, Palermo), si è prestato a fare da stampella all’operazione.
Il secondo strumento (ed è il fatto nuovo, forse decisivo, della giornata di ieri) è stato ottenere che mercoledì, dopo gli interventi di Draghi alle Camere, ci sia un voto di fiducia: cosa che non era affatto scontata, nel senso che il premier avrebbe potuto tenere un discorso pesantissimo, confermare le dimissioni e andarsene. Naturalmente il fatto che sia fissato un voto di fiducia non significa che sia scontato il suo esito favorevole: ma è difficile pensare che, su questa scelta, prima che le Conferenze dei capigruppo si orientassero in questo senso, non sia stato sondato il premier, ottenendone un avallo.
Il terzo strumento caro al Pd sarebbe stato fare in modo che, domani, fosse la Camera a pronunciarsi prima del Senato. E perché? Perché a Montecitorio il centrodestra è numericamente meno forte che a Palazzo Madama. E dunque - questo era il ragionamento del Pd - se ci fosse stata prima una fiducia alla Camera, sarebbe stato più difficile per Fi e Lega sfilarsi al Senato. Ma su questo il Pd ha tirato troppo la corda: sia al Colle che a Palazzo Chigi ieri c’era semmai preoccupazione per una forzatura giudicata eccessiva. E infatti nel pomeriggio la necessaria intesa tra Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati ha confermato l’ordine previsto: prima il Senato e poi la Camera, senza colpi di mano.
Il quarto e ultimo strumento è quello a cui le talpe del Pd, triangolando con Luigi Di Maio, stanno lavorando alacremente: svuotare i gruppi M5S, inducendo il maggior numero possibile di grillini (soprattutto alla Camera) a mollare Conte e aderire al gruppo dimaiano, o comunque a staccarsi. L’operazione, secondo il Pd, sarebbe win win: utile o a mettere Conte totalmente fuori gioco, oppure (ed è uno scenario che al Nazareno non è stato affatto abbandonato) a puntare un coltello alla gola di Conte inducendolo a cedere a sua volta. L’operazione sarebbe coronata dalla fuoriuscita del capogruppo pentastellato Davide Crippa, leader dell’ala governista (e ieri autore sia del mancato rinnovo del contratto di Rocco Casalino, sia della sponda al Pd - peraltro senza aver preventivamente informato Conte - rispetto al tentativo di votare la fiducia prima a Montecitorio e poi al Senato). E quindi saremmo non al ratto delle Sabine ma al ratto del Crippa.
Lecito chiedersi: ma sarebbe seria e politicamente robusta un’operazione del genere? Dalle parti del Pd non hanno dubbi e sorridono di soddisfazione.