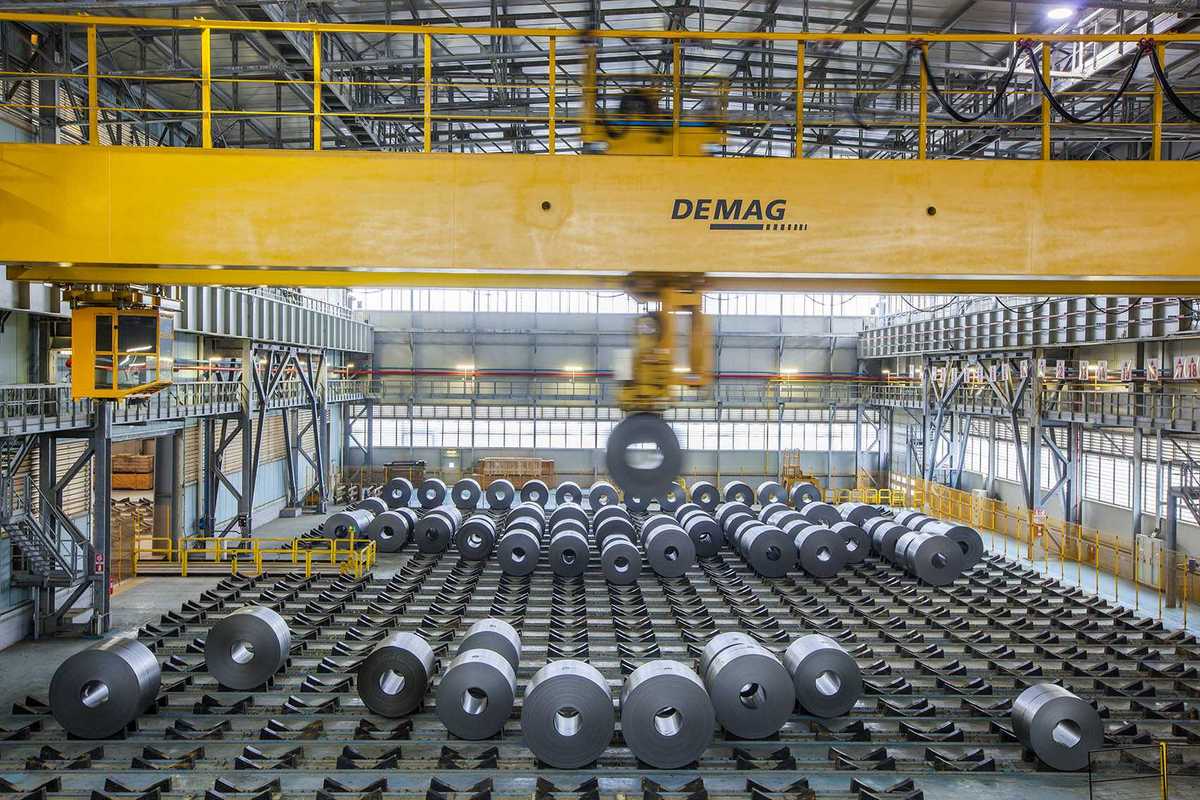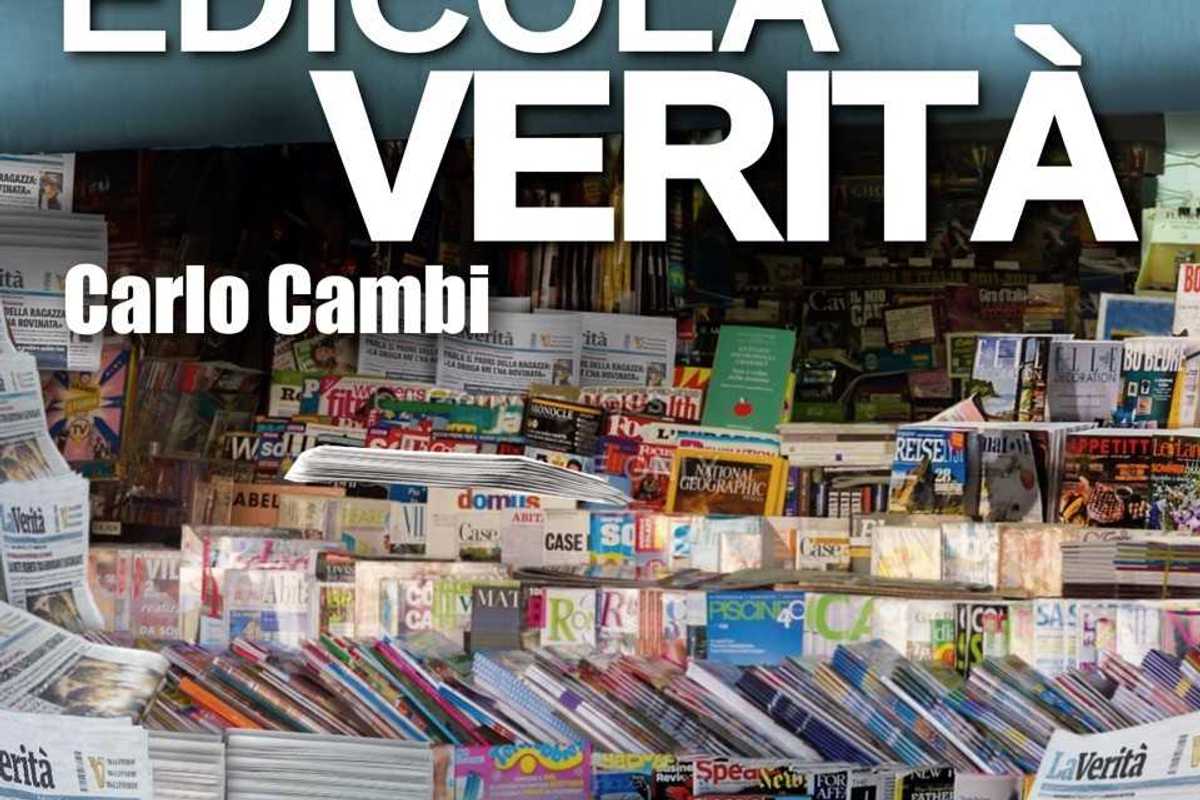Dev’essere stata una misteriosa reazione avversa (allo scoop) quella che ha colto il traduttore in italiano dell’audizione di Janine Small, top manager Pfizer, alla commissione Covid del Parlamento europeo. Quando arriva la risposta sui vaccini messi sul mercato senza alcun test sulla loro capacità di fermare il contagio, il traduttore si perde un po’ di parole in inglese e accelera vorticosamente il ritmo, fornendo un servizio ai limiti della non fruibilità. Si sentono invece molto meglio le risibili risposte di Small sullo scottante tema dei messaggini tra il suo capo Albert Bourla e il presidente della Commissione Ursula von der Leyen. In sostanza, questa la difesa della manager Pfizer, non c’è nessun problema perché mega contratti come quelli di fornitura non possono certo girare per sms sul cellulare.
La seduta della commissione è quella di lunedì scorso e al posto di Bourla si presenta Janine Small, responsabile marketing per i mercati esteri del colosso farmaceutico statunitense. A un certo punto, le viene chiesto sei i vaccini contro il Covid della Pfizer erano stati testati anche ai fini dello stop al contagio e Small ha una reazione del tutto imprevista. Si fa una bella risata ed esclama: «No!». Già questo è un colpo di scena e diciamo che sarebbe stato bello saperlo prima. Prima di fare campagne di vaccinazione al limite dell’ossessività e chiudendo la bocca a chiunque osasse avanzare dubbi o domande sull’efficacia delle punture. Poi Small racconta quanto segue: «Noi abbiamo dovuto realmente muoverci alla velocità della scienza e abbiamo dovuto fare tutto a nostro rischio». La manager cita quindi il numero uno di Pfizer, Bourla, sostenendo che egli «ha capito l’importanza di quello che stava succedendo nel mondo e abbiamo speso due miliardi di dollari per essere sul mercato, a costo di mettere a rischio capitali tutti nostri, pur di essere sicuri di poter produrre e di essere in una posizione tale da poter aiutare di fronte alla pandemia».
Small cita anche con orgoglio la stampa. «Per questo mi sento molto orgogliosa», continua, «quando ho letto una pubblicazione dell’Imperial college che diceva che in quel periodo abbiamo salvato quattro milioni di vite». E così, dal suo punto di vista, quel che conta è solo che «noi eravamo presenti quando il mondo ha avuto bisogno di noi».
Non c’è che dire, un ottimo spot, al termine di un’ammissione pazzesca sulle condizioni «primordiali» in cui è stato immesso il primo vaccino di massa contro il Covid-19. Questo, almeno, è il tenore delle dichiarazioni di Small se ascoltate in lingua originale sul sito dell’Europarlamento, ovvero in inglese. Qui si sente chiaramente la manager affermare: «Se sapevamo se il vaccino interrompesse o no la trasmissione, prima di immetterlo sul mercato? No!». In italiano, questo passaggio è tradotto a buon peso. Una distorsione rende impossibile ascoltare e capire la premessa («Se sapevamo se il vaccino interrompesse o no la trasmissione, prima di immetterlo sul mercato?»): un italiano che avesse seguito l’audizione avrebbe sentito la Small esclamare «No!», ma senza sapere a quale domanda. Ancora nell’arco della stessa risposta, Small si dedica a una certa autocelebrazione quando afferma: «Non vorrei mai pensare che situazione si sarebbe creata se compagnie come la nostra non avessero preso i propri rischi, se non avessero sviluppato i propri prodotti».
Uno dei temi più caldi della commissione Covid riguarda il caso dello scambio di messaggini tra la von der Leyen e Bourla nel pieno della negoziazione dei vaccini con l’Ue. La Commissione ha fatto muro, dopo che nell’aprile dello scorso anno il New York Times ha riportato che il presidente tedesco e l’ad di Pfizer avevano trattato tramite «chiamate ed sms» una fornitura di vaccini. Sul punto anche Janine Small fa muro, buttandola sull’assurdo. «Il contratto non è stato certo negoziato con un sms», spiega la manager, «perché non si può negoziare un contratto da 8 miliardi con degli sms». «Servono squadre enormi, non è possibile contrattare con i messaggini… non li ho contati neppure, ma io non ho il pallottoliere. Ci sono voluti giorni, settimane». Quindi, garantisce Small, «il contratto ha rispettato i normali canali di comunicazione» ed eventuali «binari paralleli di comunicazione non avrebbero potuto esserci». Per carità, è evidente che non ci si manda contratti di centinaia di pagine per sms e che questo vale anche per le tabelle e magari, concediamo, pure per singoli articoli contrattuali. Ma è altrettanto evidente che se nel corso della delicata contrattazione il numero uno della Pfizer e il numero uno della Commissione Ue si scrivono messaggini possono farlo anche solo per indirizzare i lavori, orientare il confronto, cassare o perorare una certa soluzione tecnica o giuridica. Insomma, per trattare su temi importanti, a volte, bastano poche frasi ben calibrate e poi se la vedono gli sherpa.
Interessante, infine, anche la risposta di Small alle domande sui prezzi dei vaccini venduti. La manager è stata categorica: «So di deludervi, ma di prezzi per noi non si può discutere… è un tema confidenziale». Su tutta la questione, forse, ci sono un po’ troppe faccende confidenziali.