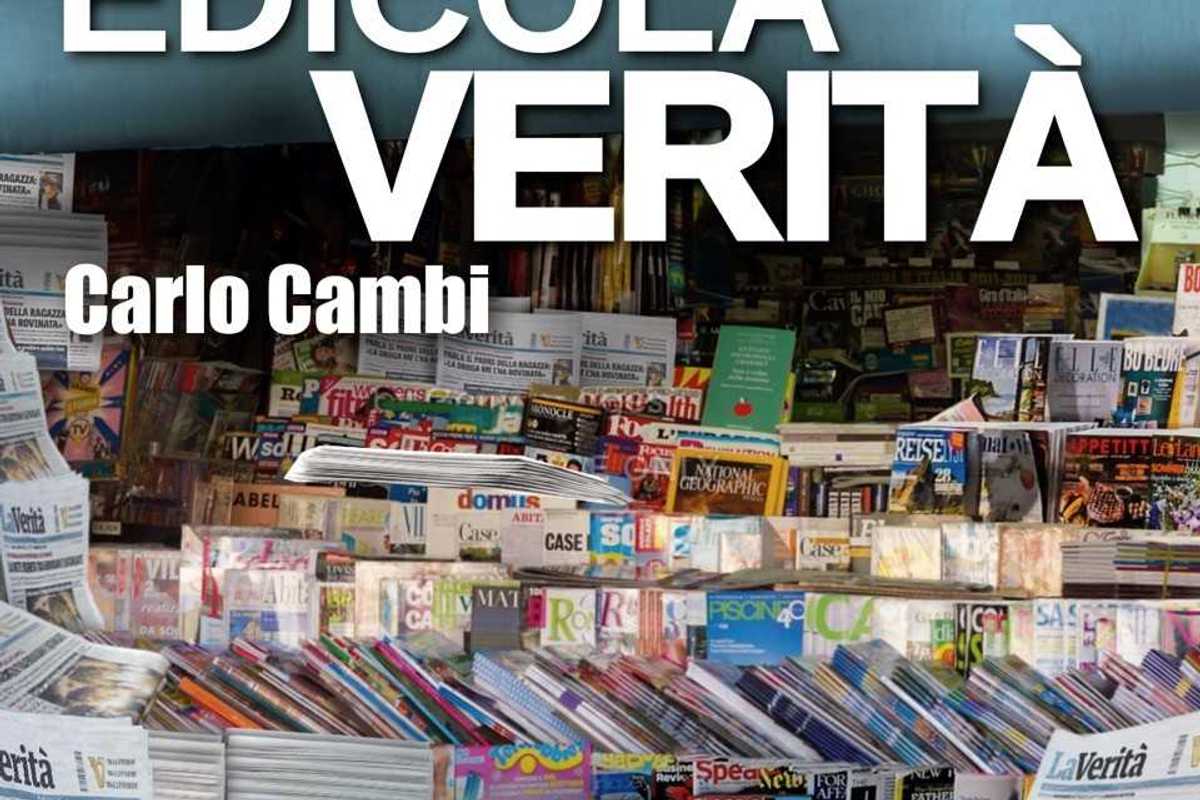True
2022-04-04
L’Ue: effetto green, tasse energia +640%
C’è un momento in cui l’emergenza diventa normalità. È già successo con il Covid, potrebbe accadere di nuovo con la crisi energetica. Quando le fibrillazioni sugli approvvigionamenti si ridurranno, gli aumenti in bolletta arriveranno per decreto. A leggere il calendario dell’Unione europea, quel momento non dovrebbe essere poi così lontano: dal 1° gennaio 2023, a Bruxelles contano di introdurre una nuova direttiva in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, con l’obiettivo di superare le norme e i prezzi stabiliti circa 20 anni fa. «La direttiva del 2003 non è più allineata alle politiche attuali dell’Ue in materia di clima ed energia», si legge nella proposta, che dovrebbe arrivare nella plenaria di Strasburgo il prossimo luglio. Le aspirazioni «green» passano attraverso una progressiva riduzione delle emissioni interne, da raggiungere soprattutto con l’aumento delle tasse sulle fonti di energia fossile, più inquinanti ma difficili da rimpiazzare. Almeno nel breve periodo.
«La tassazione svolge un ruolo diretto nel sostenere la transizione verde», scrive la Commissione europea, senza specificare quale sarà il prezzo da pagare. A farlo ci ha pensato la Corte dei conti europea, che ha analizzato le aliquote minime studiate dai tecnici di Bruxelles, fornendo un quadro preoccupante: nel 2023, è previsto un aumento del 500% per il gas naturale a uso commerciale, che crescerà ancora nel giro di 10 anni (+640% nel 2033). Più o meno il destino che toccherà al carbone per uso commerciale, lo stesso che il commissario Ue all’Industria e mercato interno, Thierry Breton, vorrebbe usare per sostituire il metano russo: il prossimo anno, il ritocco all’insù sarà del 300%, che arriverà fino a un +640% nel 2033. Viene il sospetto che la mano destra non sappia quel che fa la sinistra.
Più contenuti, si fa per dire, gli aumenti del carbone a uso non commerciale e del gasolio. Spulciando tra le tabelle allegate al testo della direttiva, spuntano fuori anche le ipotesi di riforma dei carburanti per i veicoli a motore: la base imponibile sulla benzina passerebbe dagli attuali 359 euro per ogni 1.000 litri ai 443 euro nel 2033. Le imposizioni sul gas naturale aumenterebbero del 400% in 10 anni. Almeno 11 Parlamenti europei hanno già esaminato la proposta, per ora solo il Senato della Repubblica Ceca ha espresso qualche riserva sulla direttiva, che non lascerebbe «sufficienti margini di discrezionalità nelle politiche fiscali degli Stati membri». La Commissione politiche europee del Senato italiano non ha sollevato criticità, sebbene la relazione del governo rilevi possibili «ricadute sull’articolazione delle politiche pubbliche», per quel che riguarda industria, famiglie e trasporti.
«Negli ultimi due anni c’è stato un tale sovvertimento delle cose che oggi il Green deal europeo rischia di essere antistorico, non tanto negli obiettivi, quanto nei tempi e negli strumenti», spiega l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia. «Il tessuto economico non ha avuto sufficiente tempo per reagire alle conseguenze della pandemia, c’è il rischio che gli obiettivi siano eccessivamente ambiziosi rispetto alle reali capacità di adattamento della nostra economia». Già lo scorso anno, secondo i numeri elaborati dal Centro Europa ricerche, l’Italia è stato il Paese che più ha sofferto lo shock energetico, con un aumento dei prezzi delle fonti fossili del 180%. Per avere un termine di paragone, la crescita dei prezzi negli Stati Uniti si è attestata poco sotto il 70%. «Piove sul bagnato», confida alla Verità Aldo Arici, amministratore di Unifond, impresa bresciana che produce semilavorati in ottone. Le proiezioni elaborate sulle spese di marzo, le prime a risentire degli effetti della guerra, riflettono un aumento dei costi in bolletta di almeno 4 volte, con i prezzi dell’energia che sono schizzati dai 16.000 euro dello scorso anno agli attuali 66.000. «Per un’impresa come la nostra, la voce energia, insieme alla manodopera, fa il bilancio: se l’aumento è esponenziale, non c’è storia. Diventa un bagno di sangue», spiega Arici.
Le fonderie chiedono almeno di poter slegare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas. Peccato che, finora, nessuno abbia pensato di mettere mano a questa anomalia, a eccezione di Spagna e Portogallo, che hanno presentato un documento formale alla Commissione europea per fissare un tetto al prezzo del gas ed evitare l’effetto contagio. «Non possiamo fare di tutta l’erba un fascio», raccontano i rappresentanti delle imprese energivore del Nord Italia. «Se vogliamo parlare di transizione ecologica, va bene. Il problema è che qualcuno se ne deve fare carico, le aziende non possono chiudere. Il rischio è che si aprano casse integrazioni una dietro l’altra, con tutti i problemi sociali che si ripercuoterebbero sulla società». Più che una possibilità, purtroppo è una certezza per la Commissione europea: i settori energetici, infatti, saranno quelli che soffriranno il «più alto impatto in termini di disoccupazione», come si legge nel testo della nuova direttiva.
Nel 2035, il comparto dell’estrazione del gas perderà il 12% della forza lavoro attualmente impegnata nel nostro continente, senza certezze di reimpiego nelle nuove competenze della green economy. «Il caro energia non è una mera questione transitoria», commenta Antonio Gigliotti, direttore del centro studi Fiscal focus, il primo a evidenziare le criticità della nuova proposta europea. «Ci troviamo di fronte a un processo decennale, che non può essere affrontato a compartimenti stagni. Un processo che metterà a dura prova la capacità di risposta degli Stati europei, soprattutto quelli che si sono rivelati più dipendenti dalle fonti fossili come l’Italia».
«Gli ambientalisti ci costano il 2% del Pil»
«Improvvisamente scopriamo che siamo dipendenti dalla Russia. Ma dove siamo stati negli ultimi 50 anni? È dal 1974 che importiamo gas dalla Russia. La cultura verde in tutta Europa ha imposto divieti e questo è il risultato». Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, non le manda a dire.
C’è una ricetta per compensare gli errori del passato?
«Magari. Dobbiamo cominciare ad alleggerire il peso della Russia facendo ciò che abbiamo tentato nei passati 50 anni, cioè più fonti rinnovabili, diversificare su altri Paesi, fare un altro gasdotto dal Medio Oriente dove c’è molto gas, altri due-tre rigassificatori, tenere aperta qualche centrale a carbone, fare accumuli di energia. Tutte cose belle da annunciare ma molto difficili da realizzare. Gli ecologisti devono rendersi conto che le rinnovabili fanno qualcosa, ma nel nostro bilancio energetico il fotovoltaico e l’eolico contano per il 17% della produzione elettrica che è il 6% del bilancio energetico. Il 97% della domanda dei trasporti è di derivati del petrolio. Non ci sono alternative».
Paghiamo il conto di politiche demagogiche e miopi?
«Anche la Francia, che pure ha scelto il nucleare, non sta meglio. Fra qualche anno avremo un problema in tutta Europa che è il sistema elettrico francese: quelle centrali stanno invecchiando e ora sono la prima fonte di produzione elettrica in Europa. Noi importiamo molta energia elettrica dalla Francia».
E le rinnovabili?
«Possiamo pure farle ma sono intermittenti. Il problema gas è cominciato la scorsa estate perché non c’era vento nel Nord Europa».
La scelta è quindi tra progredire inquinando o la decrescita felice?
«In un certo senso sì. Noi siamo in una trappola per il cambiamento climatico. Le emissioni di CO2 non caleranno perché avremo bisogno di più energia che non potrà non derivare da fonti fossili. C’è poi un altro lucchetto in questa trappola».
Quale lucchetto?
«La dipendenza dalle autocrazie. I governi della Russia, del Venezuela, dell’Iran durano a lungo proprio perché riforniscono di energia tutto il mondo, hanno un potere immenso. Io sono stato sempre favorevole alle importazioni di gas della Russia perché è meno costoso, i rifornimenti sono vicini e perché dobbiamo aiutare la Russia a liberarsi dell’autocrazia diventando una democrazia».
Anche noi dovremmo liberarci di tante paure.
«Potevamo fare più centrali nucleari ma la gente le teme. Potevamo fare più carbone e più trivelle: bloccati. Anche contro le rinnovabili c’è l’ostilità di chi non vuole davanti a case le pale eoliche, gigantesche e rumorose».
Come se ne esce?
«Siamo in una trappola. Al momento non c’è un’alternativa al petrolio».
Vanno riviste le scadenze della transizione ecologica?
«Non servirà rivederle, erano già un sogno. Nessuno ci ha mai creduto. Potevamo avvicinarci. I prezzi delle fonti fossili sono esplosi e per le fonti rinnovabili che costano meno ci sarà un’esplosione dei progetti, come già sta accadendo. Noi rincorriamo in Europa i sogni. Intanto negli Stati Uniti stanno andando avanti con il fracking, cioè la tecnica estrattiva che permette di sfruttare lo share gas. L’effetto è che il loro gas costa un decimo del nostro».
È un sistema che si potrebbe applicare anche in Italia?
«Tecnicamente sarebbe possibile ma è vietato in Europa perché considerato ambientalmente invasivo. Siamo dominati da quella cultura verde che ci impone di vietare l’estrazione in questo modo del gas come pure limita l’uso delle trivelle. Ma è un delitto economico».
La cultura verde è stata messa a dura prova dall’impatto del conflitto ucraino. Ci sarà una marcia indietro?
«È probabile un ridimensionamento. Molti si accorgono adesso che importiamo fossili e gas, ma prima dov’erano? Le rinnovabili si possono pure accelerare ma più di 2-3 miliardi di metri cubi di fonti fossili in meno sarà un miracolo, mentre importiamo 29 metri cubi di gas dalla Russia. I 5 stelle, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il suo vice Frans Timmermans sono in linea con le posizioni ecologiste e adesso devono prendere atto di queste difficoltà. Ma è tardi».
Quale è il costo che i veti ecologisti ci stanno facendo pagare?
«Quest’anno, con questi prezzi, le importazioni di energia hanno superato i 90 miliardi di euro, contro un valore dell’anno scorso intorno a 40 miliardi. Nel 2019 era stato di 23 miliardi di euro. Sono due punti di pil che vanno all’estero a cui si aggiunge la mancata crescita e l’inflazione. Avere tanto ecologismo accentua i problemi. Più rigassificatori e un maggiore sfruttamento del carbone ci avrebbero fatto comodo».
«Il vero disastro è stato dire no al nucleare»
«Oggi si dice di inasprire le sanzioni alla Russia e chiudere i rubinetti del gas per mettere Mosca in difficoltà. Ma per decenni in Italia abbiamo detto una serie di no allo sfruttamento delle nostre risorse e alla diversificazione delle fonti energetiche. Eppure già nel gennaio 2016, di fronte a un mancato pagamento di gas dall’Ucraina, la Russia chiuse i rubinetti verso Sud e in Italia subimmo uno shock negli approvvigionamenti, dovendo fare ricorso a misure di emergenza. Non abbiamo imparato niente», dice Carlo Andrea Bollino, professore di economia dell’energia all’università Luiss di Roma e presidente onorario dell’Associazione degli economisti dell’energia.
Da dove cominciamo con le follie dei fondamentalisti del green?
«In Italia il primo capolavoro, in senso ironico, è ovvio, è stata la rinuncia al nucleare. I francesi, vicini a noi culturalmente, sono favorevoli al nucleare da 40 anni e lo gestiscono in sicurezza».
Quanto ci è costato questo no?
«Basta guardare la Borsa elettrica e fare la differenza per tutti gli anni, da quando abbiamo bocciato il nucleare, tra i prezzi di mercato dell’energia in Italia e quelli in Francia e Germania. Primo anno di apertura della borsa elettrica in Italia, 2004: prezzo in Italia 51 euro a megawattora, prezzo medio in Germania, Francia e Spagna 28. Dieci anni dopo, nel 2014, prezzo medio italiano 52 euro, prezzo medio in Germania e Francia 33. Nel 2020 la pandemia ha fatto abbassare i prezzi: in Italia prezzo medio 39 euro, in Germania e Francia 30. Avessimo pagato l’elettricità ai prezzi di francesi e tedeschi, negli ultimi 15 anni avremmo risparmiato 80 miliardi di euro».
E la diversificazione delle fonti energetiche?
«I demagoghi della rivoluzione ecologista hanno anche ostacolato lo sviluppo di altre fonti energetiche. Si diceva no al nucleare e anche no al carbone. Risultato: oggi usiamo il doppio del gas di altri Paesi europei. Che dire poi della scellerata politica contro i termovalorizzatori?».
Intende gli inceneritori?
«I rifiuti vengono mandati in Germania, noi paghiamo lo smaltimento e il trasporto e loro li usano per produrre energia elettrica. Paghiamo per sottrarre energia all’Italia e darla ad altri. Questo accade soprattutto nel Centro e nel Mezzogiorno. Ma gli ecologisti non si sono messi d’accordo nemmeno sull’energia pulita delle rinnovabili».
Eolico e fotovoltaico?
«In questo caso hanno fatto fronte comune con i sindaci. Si è sempre detto che gli impianti dell’eolico e del fotovoltaico rovinano la bellezza dei paesaggi, il panorama dei borghi e sono un danno per il turismo. Quando li abbiamo permessi nel settore agricolo c’è anche chi aveva storto il naso, con l’argomentazione che si sarebbe consumato territorio agricolo. In realtà la lungimiranza imprenditoriale dei nostri agricoltori ha permesso di utilizzare fonti rinnovabili per migliorare le pratiche agricole. Ora il Pnrr ha sfoltito parte della burocrazia ma abbiamo perso tempo prezioso».
Anche l’idrogeno non raccoglie molti consensi.
«I tedeschi, nel loro Pnrr, affermano che vogliono essere i leader della nuova tecnologia europea dell’idrogeno, mentre noi non abbiamo ancora un indirizzo certo. In Italia è mancata una strategia energetica che guardasse lontano. Ora si agisce sull’emergenza ma temo che, conclusa la guerra, tutto tornerà come prima. Ad esempio, i sauditi vorrebbero fornirci l’idrogeno blu, dove l’anidride carbonica che risulta dal processo non viene liberata in aria ma catturata e immagazzinata. I verdi hanno storto il naso perché comunque all’origine si usa il petrolio che per loro è il diavolo, così come per il mini nucleare».
Che cos’è?
«Il sistema è in fase sperimentale negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È una tecnologia ancora in fase di studio: il mini impianto può essere interrato, occupa poco spazio e richiede solo due anni per la costruzione contro i 12 di una normale centrale. Ma finché in Italia c’è il veto sull’atomo non si va avanti. E pensare che la tecnologia civile nucleare risale agli anni Quaranta ed è un vanto della scienza italiana».
Da quanto dice, l’obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 è un sogno.
«Le proiezioni più accreditate dicono che bisognerebbe quintuplicare gli investimenti in fonti rinnovabili. Poiché non vedo costruire cinque volte tanto gli impianti oggi, temo che sia un sogno irrealizzabile. Vietare è più facile che permettere la ricerca».
Continua a leggereRiduci
La Commissione Ue ha previsto rincari fiscali astronomici per «sostenere la transizione verde» nei prossimi 10 anni. Ma si è ben guardata dal comunicarli. Li ha scoperti la Corte dei conti: eccoli.Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli: «Le scadenze fissate a Bruxelles? Non ci ha mai creduto nessuno».Il docente Carlo Andrea Bollino: «Francia e Germania pagano l’energia la metà di quanto facciamo noi».Lo speciale contiene tre articoliC’è un momento in cui l’emergenza diventa normalità. È già successo con il Covid, potrebbe accadere di nuovo con la crisi energetica. Quando le fibrillazioni sugli approvvigionamenti si ridurranno, gli aumenti in bolletta arriveranno per decreto. A leggere il calendario dell’Unione europea, quel momento non dovrebbe essere poi così lontano: dal 1° gennaio 2023, a Bruxelles contano di introdurre una nuova direttiva in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, con l’obiettivo di superare le norme e i prezzi stabiliti circa 20 anni fa. «La direttiva del 2003 non è più allineata alle politiche attuali dell’Ue in materia di clima ed energia», si legge nella proposta, che dovrebbe arrivare nella plenaria di Strasburgo il prossimo luglio. Le aspirazioni «green» passano attraverso una progressiva riduzione delle emissioni interne, da raggiungere soprattutto con l’aumento delle tasse sulle fonti di energia fossile, più inquinanti ma difficili da rimpiazzare. Almeno nel breve periodo. «La tassazione svolge un ruolo diretto nel sostenere la transizione verde», scrive la Commissione europea, senza specificare quale sarà il prezzo da pagare. A farlo ci ha pensato la Corte dei conti europea, che ha analizzato le aliquote minime studiate dai tecnici di Bruxelles, fornendo un quadro preoccupante: nel 2023, è previsto un aumento del 500% per il gas naturale a uso commerciale, che crescerà ancora nel giro di 10 anni (+640% nel 2033). Più o meno il destino che toccherà al carbone per uso commerciale, lo stesso che il commissario Ue all’Industria e mercato interno, Thierry Breton, vorrebbe usare per sostituire il metano russo: il prossimo anno, il ritocco all’insù sarà del 300%, che arriverà fino a un +640% nel 2033. Viene il sospetto che la mano destra non sappia quel che fa la sinistra. Più contenuti, si fa per dire, gli aumenti del carbone a uso non commerciale e del gasolio. Spulciando tra le tabelle allegate al testo della direttiva, spuntano fuori anche le ipotesi di riforma dei carburanti per i veicoli a motore: la base imponibile sulla benzina passerebbe dagli attuali 359 euro per ogni 1.000 litri ai 443 euro nel 2033. Le imposizioni sul gas naturale aumenterebbero del 400% in 10 anni. Almeno 11 Parlamenti europei hanno già esaminato la proposta, per ora solo il Senato della Repubblica Ceca ha espresso qualche riserva sulla direttiva, che non lascerebbe «sufficienti margini di discrezionalità nelle politiche fiscali degli Stati membri». La Commissione politiche europee del Senato italiano non ha sollevato criticità, sebbene la relazione del governo rilevi possibili «ricadute sull’articolazione delle politiche pubbliche», per quel che riguarda industria, famiglie e trasporti. «Negli ultimi due anni c’è stato un tale sovvertimento delle cose che oggi il Green deal europeo rischia di essere antistorico, non tanto negli obiettivi, quanto nei tempi e negli strumenti», spiega l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia, membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia. «Il tessuto economico non ha avuto sufficiente tempo per reagire alle conseguenze della pandemia, c’è il rischio che gli obiettivi siano eccessivamente ambiziosi rispetto alle reali capacità di adattamento della nostra economia». Già lo scorso anno, secondo i numeri elaborati dal Centro Europa ricerche, l’Italia è stato il Paese che più ha sofferto lo shock energetico, con un aumento dei prezzi delle fonti fossili del 180%. Per avere un termine di paragone, la crescita dei prezzi negli Stati Uniti si è attestata poco sotto il 70%. «Piove sul bagnato», confida alla Verità Aldo Arici, amministratore di Unifond, impresa bresciana che produce semilavorati in ottone. Le proiezioni elaborate sulle spese di marzo, le prime a risentire degli effetti della guerra, riflettono un aumento dei costi in bolletta di almeno 4 volte, con i prezzi dell’energia che sono schizzati dai 16.000 euro dello scorso anno agli attuali 66.000. «Per un’impresa come la nostra, la voce energia, insieme alla manodopera, fa il bilancio: se l’aumento è esponenziale, non c’è storia. Diventa un bagno di sangue», spiega Arici. Le fonderie chiedono almeno di poter slegare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas. Peccato che, finora, nessuno abbia pensato di mettere mano a questa anomalia, a eccezione di Spagna e Portogallo, che hanno presentato un documento formale alla Commissione europea per fissare un tetto al prezzo del gas ed evitare l’effetto contagio. «Non possiamo fare di tutta l’erba un fascio», raccontano i rappresentanti delle imprese energivore del Nord Italia. «Se vogliamo parlare di transizione ecologica, va bene. Il problema è che qualcuno se ne deve fare carico, le aziende non possono chiudere. Il rischio è che si aprano casse integrazioni una dietro l’altra, con tutti i problemi sociali che si ripercuoterebbero sulla società». Più che una possibilità, purtroppo è una certezza per la Commissione europea: i settori energetici, infatti, saranno quelli che soffriranno il «più alto impatto in termini di disoccupazione», come si legge nel testo della nuova direttiva. Nel 2035, il comparto dell’estrazione del gas perderà il 12% della forza lavoro attualmente impegnata nel nostro continente, senza certezze di reimpiego nelle nuove competenze della green economy. «Il caro energia non è una mera questione transitoria», commenta Antonio Gigliotti, direttore del centro studi Fiscal focus, il primo a evidenziare le criticità della nuova proposta europea. «Ci troviamo di fronte a un processo decennale, che non può essere affrontato a compartimenti stagni. Un processo che metterà a dura prova la capacità di risposta degli Stati europei, soprattutto quelli che si sono rivelati più dipendenti dalle fonti fossili come l’Italia». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/effett-green-tasse-sullenergia-640-2657085918.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="gli-ambientalisti-ci-costano-il-2-del-pil" data-post-id="2657085918" data-published-at="1649009749" data-use-pagination="False"> «Gli ambientalisti ci costano il 2% del Pil» «Improvvisamente scopriamo che siamo dipendenti dalla Russia. Ma dove siamo stati negli ultimi 50 anni? È dal 1974 che importiamo gas dalla Russia. La cultura verde in tutta Europa ha imposto divieti e questo è il risultato». Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, non le manda a dire. C’è una ricetta per compensare gli errori del passato? «Magari. Dobbiamo cominciare ad alleggerire il peso della Russia facendo ciò che abbiamo tentato nei passati 50 anni, cioè più fonti rinnovabili, diversificare su altri Paesi, fare un altro gasdotto dal Medio Oriente dove c’è molto gas, altri due-tre rigassificatori, tenere aperta qualche centrale a carbone, fare accumuli di energia. Tutte cose belle da annunciare ma molto difficili da realizzare. Gli ecologisti devono rendersi conto che le rinnovabili fanno qualcosa, ma nel nostro bilancio energetico il fotovoltaico e l’eolico contano per il 17% della produzione elettrica che è il 6% del bilancio energetico. Il 97% della domanda dei trasporti è di derivati del petrolio. Non ci sono alternative». Paghiamo il conto di politiche demagogiche e miopi? «Anche la Francia, che pure ha scelto il nucleare, non sta meglio. Fra qualche anno avremo un problema in tutta Europa che è il sistema elettrico francese: quelle centrali stanno invecchiando e ora sono la prima fonte di produzione elettrica in Europa. Noi importiamo molta energia elettrica dalla Francia». E le rinnovabili? «Possiamo pure farle ma sono intermittenti. Il problema gas è cominciato la scorsa estate perché non c’era vento nel Nord Europa». La scelta è quindi tra progredire inquinando o la decrescita felice? «In un certo senso sì. Noi siamo in una trappola per il cambiamento climatico. Le emissioni di CO2 non caleranno perché avremo bisogno di più energia che non potrà non derivare da fonti fossili. C’è poi un altro lucchetto in questa trappola». Quale lucchetto? «La dipendenza dalle autocrazie. I governi della Russia, del Venezuela, dell’Iran durano a lungo proprio perché riforniscono di energia tutto il mondo, hanno un potere immenso. Io sono stato sempre favorevole alle importazioni di gas della Russia perché è meno costoso, i rifornimenti sono vicini e perché dobbiamo aiutare la Russia a liberarsi dell’autocrazia diventando una democrazia». Anche noi dovremmo liberarci di tante paure. «Potevamo fare più centrali nucleari ma la gente le teme. Potevamo fare più carbone e più trivelle: bloccati. Anche contro le rinnovabili c’è l’ostilità di chi non vuole davanti a case le pale eoliche, gigantesche e rumorose». Come se ne esce? «Siamo in una trappola. Al momento non c’è un’alternativa al petrolio». Vanno riviste le scadenze della transizione ecologica? «Non servirà rivederle, erano già un sogno. Nessuno ci ha mai creduto. Potevamo avvicinarci. I prezzi delle fonti fossili sono esplosi e per le fonti rinnovabili che costano meno ci sarà un’esplosione dei progetti, come già sta accadendo. Noi rincorriamo in Europa i sogni. Intanto negli Stati Uniti stanno andando avanti con il fracking, cioè la tecnica estrattiva che permette di sfruttare lo share gas. L’effetto è che il loro gas costa un decimo del nostro». È un sistema che si potrebbe applicare anche in Italia? «Tecnicamente sarebbe possibile ma è vietato in Europa perché considerato ambientalmente invasivo. Siamo dominati da quella cultura verde che ci impone di vietare l’estrazione in questo modo del gas come pure limita l’uso delle trivelle. Ma è un delitto economico». La cultura verde è stata messa a dura prova dall’impatto del conflitto ucraino. Ci sarà una marcia indietro? «È probabile un ridimensionamento. Molti si accorgono adesso che importiamo fossili e gas, ma prima dov’erano? Le rinnovabili si possono pure accelerare ma più di 2-3 miliardi di metri cubi di fonti fossili in meno sarà un miracolo, mentre importiamo 29 metri cubi di gas dalla Russia. I 5 stelle, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il suo vice Frans Timmermans sono in linea con le posizioni ecologiste e adesso devono prendere atto di queste difficoltà. Ma è tardi». Quale è il costo che i veti ecologisti ci stanno facendo pagare? «Quest’anno, con questi prezzi, le importazioni di energia hanno superato i 90 miliardi di euro, contro un valore dell’anno scorso intorno a 40 miliardi. Nel 2019 era stato di 23 miliardi di euro. Sono due punti di pil che vanno all’estero a cui si aggiunge la mancata crescita e l’inflazione. Avere tanto ecologismo accentua i problemi. Più rigassificatori e un maggiore sfruttamento del carbone ci avrebbero fatto comodo». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/effett-green-tasse-sullenergia-640-2657085918.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="il-vero-disastro-e-stato-dire-no-al-nucleare" data-post-id="2657085918" data-published-at="1649009749" data-use-pagination="False"> «Il vero disastro è stato dire no al nucleare» «Oggi si dice di inasprire le sanzioni alla Russia e chiudere i rubinetti del gas per mettere Mosca in difficoltà. Ma per decenni in Italia abbiamo detto una serie di no allo sfruttamento delle nostre risorse e alla diversificazione delle fonti energetiche. Eppure già nel gennaio 2016, di fronte a un mancato pagamento di gas dall’Ucraina, la Russia chiuse i rubinetti verso Sud e in Italia subimmo uno shock negli approvvigionamenti, dovendo fare ricorso a misure di emergenza. Non abbiamo imparato niente», dice Carlo Andrea Bollino, professore di economia dell’energia all’università Luiss di Roma e presidente onorario dell’Associazione degli economisti dell’energia. Da dove cominciamo con le follie dei fondamentalisti del green? «In Italia il primo capolavoro, in senso ironico, è ovvio, è stata la rinuncia al nucleare. I francesi, vicini a noi culturalmente, sono favorevoli al nucleare da 40 anni e lo gestiscono in sicurezza». Quanto ci è costato questo no? «Basta guardare la Borsa elettrica e fare la differenza per tutti gli anni, da quando abbiamo bocciato il nucleare, tra i prezzi di mercato dell’energia in Italia e quelli in Francia e Germania. Primo anno di apertura della borsa elettrica in Italia, 2004: prezzo in Italia 51 euro a megawattora, prezzo medio in Germania, Francia e Spagna 28. Dieci anni dopo, nel 2014, prezzo medio italiano 52 euro, prezzo medio in Germania e Francia 33. Nel 2020 la pandemia ha fatto abbassare i prezzi: in Italia prezzo medio 39 euro, in Germania e Francia 30. Avessimo pagato l’elettricità ai prezzi di francesi e tedeschi, negli ultimi 15 anni avremmo risparmiato 80 miliardi di euro». E la diversificazione delle fonti energetiche? «I demagoghi della rivoluzione ecologista hanno anche ostacolato lo sviluppo di altre fonti energetiche. Si diceva no al nucleare e anche no al carbone. Risultato: oggi usiamo il doppio del gas di altri Paesi europei. Che dire poi della scellerata politica contro i termovalorizzatori?». Intende gli inceneritori? «I rifiuti vengono mandati in Germania, noi paghiamo lo smaltimento e il trasporto e loro li usano per produrre energia elettrica. Paghiamo per sottrarre energia all’Italia e darla ad altri. Questo accade soprattutto nel Centro e nel Mezzogiorno. Ma gli ecologisti non si sono messi d’accordo nemmeno sull’energia pulita delle rinnovabili». Eolico e fotovoltaico? «In questo caso hanno fatto fronte comune con i sindaci. Si è sempre detto che gli impianti dell’eolico e del fotovoltaico rovinano la bellezza dei paesaggi, il panorama dei borghi e sono un danno per il turismo. Quando li abbiamo permessi nel settore agricolo c’è anche chi aveva storto il naso, con l’argomentazione che si sarebbe consumato territorio agricolo. In realtà la lungimiranza imprenditoriale dei nostri agricoltori ha permesso di utilizzare fonti rinnovabili per migliorare le pratiche agricole. Ora il Pnrr ha sfoltito parte della burocrazia ma abbiamo perso tempo prezioso». Anche l’idrogeno non raccoglie molti consensi. «I tedeschi, nel loro Pnrr, affermano che vogliono essere i leader della nuova tecnologia europea dell’idrogeno, mentre noi non abbiamo ancora un indirizzo certo. In Italia è mancata una strategia energetica che guardasse lontano. Ora si agisce sull’emergenza ma temo che, conclusa la guerra, tutto tornerà come prima. Ad esempio, i sauditi vorrebbero fornirci l’idrogeno blu, dove l’anidride carbonica che risulta dal processo non viene liberata in aria ma catturata e immagazzinata. I verdi hanno storto il naso perché comunque all’origine si usa il petrolio che per loro è il diavolo, così come per il mini nucleare». Che cos’è? «Il sistema è in fase sperimentale negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È una tecnologia ancora in fase di studio: il mini impianto può essere interrato, occupa poco spazio e richiede solo due anni per la costruzione contro i 12 di una normale centrale. Ma finché in Italia c’è il veto sull’atomo non si va avanti. E pensare che la tecnologia civile nucleare risale agli anni Quaranta ed è un vanto della scienza italiana». Da quanto dice, l’obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 è un sogno. «Le proiezioni più accreditate dicono che bisognerebbe quintuplicare gli investimenti in fonti rinnovabili. Poiché non vedo costruire cinque volte tanto gli impianti oggi, temo che sia un sogno irrealizzabile. Vietare è più facile che permettere la ricerca».
Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 24 febbraio con Carlo Cambi