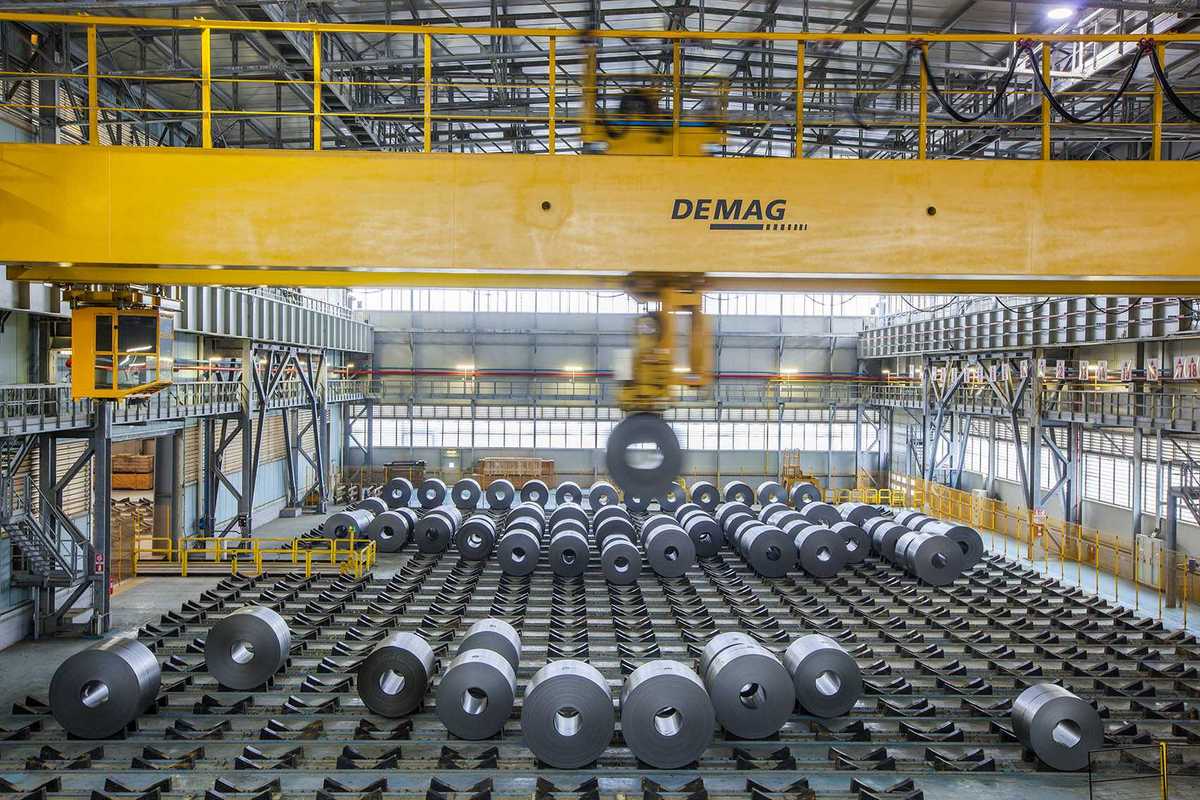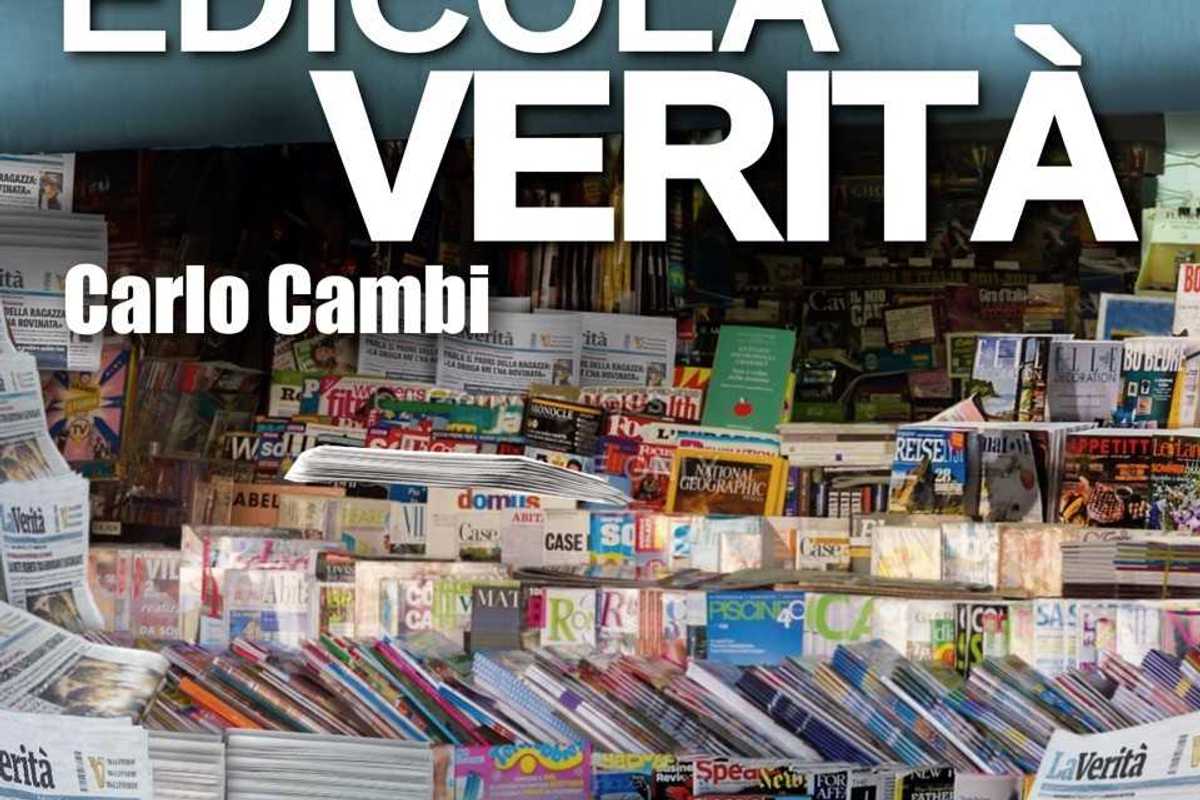La scuola senza socialità non educa e mette a rischio la democrazia
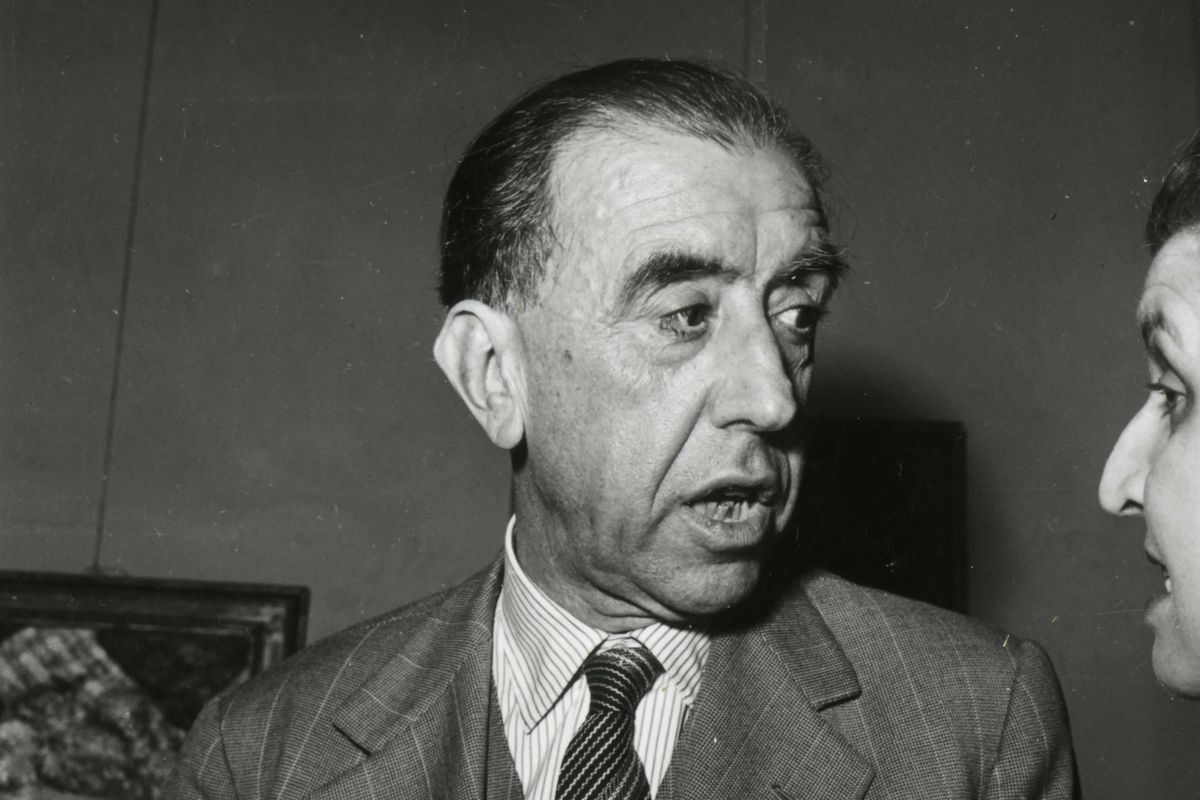
L'11 febbraio 1950, parlando al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale svoltosi a Roma, Piero Calamandrei, uno dei padri fondatori della nostra repubblica, pronunciò il brano seguente. Leggiamolo insieme; è un po' lungo ma ne vale la pena. «La scuola, come la vedo io, è un organo "costituzionale". Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. Come voi sapete, tutti voi avrete letto la nostra Costituzione (forse allora era vero; oggi dubito che l'abbia letta chi ci governa, nda) nella seconda parte della Costituzione, quella che si intitola “l'ordinamento dello Stato", sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la volontà del popolo. Quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi. Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l'organismo costituzionale e l'organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare il sangue […]. Questo può farlo soltanto la scuola, la quale è il complemento necessario del suffragio universale.»
Per riassumere quanto detto in uno slogan, se consideriamo il nostro Stato una democrazia, dobbiamo renderci conto che il suffragio universale è solo metà della democrazia; l'altra metà è l'educazione. Senza di essa - senza un appropriato sforzo teso a far sbocciare la loro maturità di pensiero e di giudizio - gli elettori saranno facile preda dei demagoghi e degli imbonitori di turno e compiranno scelte dissennate. Non dimentichiamo che fu una democrazia a condannare a morte Socrate e che Hitler arrivò al potere sull'onda di un successo elettorale. Mia madre, che (come me) fu un'insegnante per quarant'anni, mi diceva spesso che l'educazione è la migliore forma di autodifesa: dalla propaganda, dall'ipocrisia, dalla menzogna. Se è vero che la divisione fra i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (da tenere rigorosamente distinti) è il miglior modo per promuovere il benessere dei cittadini, è anche vero che quei cittadini bisogna innanzitutto formarli (bisogna creare il sangue che circoli nelle vene e arterie dello Stato, per usare la metafora di Calamandrei), e ciò deve farlo la scuola, dove quei cittadini vengono educati.
È opportuno però andare oltre lo slogan, perché le frasi brevi e incisive possono essere fraintese e vanno spiegate con cura. Che cosa vuol dire educare dei cittadini? Quale ruolo svolge la scuola in tale educazione? Il suo ruolo non può ridursi a comunicare delle nozioni, che si potrebbero anche imparare per conto proprio, leggendole su un libro o cercandole in rete. E che, in ogni caso, vengono quasi completamente dimenticate: quanti fra noi ricordano una sola battaglia della prima guerra punica, o la capitale dell'Honduras? Queste nozioni sono fatte, potremmo dire, per essere dimenticate: per essere apprese in un breve spazio di tempo, rigurgitate in un esame o una verifica e poi per sempre accantonate.
È altro quel che si dovrebbe imparare a scuola. È, in primo luogo, l'esempio, positivo o negativo, offerto dai nostri insegnanti, buoni e cattivi: il modo in cui li abbiamo visti valutare uno di noi, rispondere a una domanda, gestire un problema disciplinare. Quando avremo un negozio, lavoreremo in una banca o in uno studio legale, questi esempi ci guideranno a scegliere come operare e non operare: come affrontare e non affrontare un problema o una difficoltà.
In secondo luogo, a scuola dovremmo imparare a socializzare con i nostri compagni. In un'aula scolastica convivono studenti di estrazione diversa, con interessi e valori disparati, attesi da un futuro ancora in parte ignoto ma certo non uniforme; e tra loro si stringono legami, e comunque si impara a discorrere e a litigare, a farsi valere e a rispettarsi. Tutte la capacità, tutte le competenze insomma che sono indispensabili per convivere con correttezza ed equità nell'aula ben più ampia di uno Stato: per confrontarsi e capirsi, per ragionare e discutere, per proporre e controbattere - per costruire insieme un'autentica democrazia, in cui il suffragio popolare è solo metà della storia. Sprovvisti di queste capacità e competenze, i «cittadini» potranno solo urlare le loro inarticolate preferenze (inarticolate perché non sono cresciute, non si sono sviluppate nel confronto con l'altro) cercando di sovrastare le urla altrui. Come avviene regolarmente in un salotto (meglio sarebbe dire un postribolo) televisivo, o in Parlamento.
Riflettiamo allora su quale educazione sia stata offerta ai nostri giovani negli ultimi due anni scolastici, e venga promessa da quello appena iniziato. Un'assenza totale di socialità, nell'isolamento casalingo davanti a un computer oppure nel distanziamento e nell'orrore del contatto. Da un po' di tempo in qua, una occhiuta e rapace discriminazione fra vaccinati e non, sia per gli studenti sia per i loro genitori. L'impossibilità non solo di toccarsi ma anche di guardarsi in faccia: di apprendere il linguaggio delle espressioni, dei sorrisi e delle smorfie, e di costruire su questo linguaggio il riconoscimento etico dell'altro. (È Emmanuel Lévinas a insegnarci che l'etica nasce dall'incontro con il volto dell'altro; una maschera che lo copra impedisce dunque che nasca e fa di noi e dei nostri figli degli analfabeti in materia).
Potrei continuare, ma non ce n'è bisogno, perché sapete benissimo di che sto parlando. Infanzia e adolescenza sono una breve finestra durante la quale gli uomini e le donne di domani hanno la preziosa opportunità di acquisire le qualità di cui avranno bisogno nella loro vita adulta di cittadini. Assoggettarli per buona parte del breve tempo disponibile a una insana deprivazione di questa opportunità significa fare di tutto perché nel nostro Stato circoli sangue marcio, perché sia abitato da mostri. È questo il futuro che vogliamo realizzare?