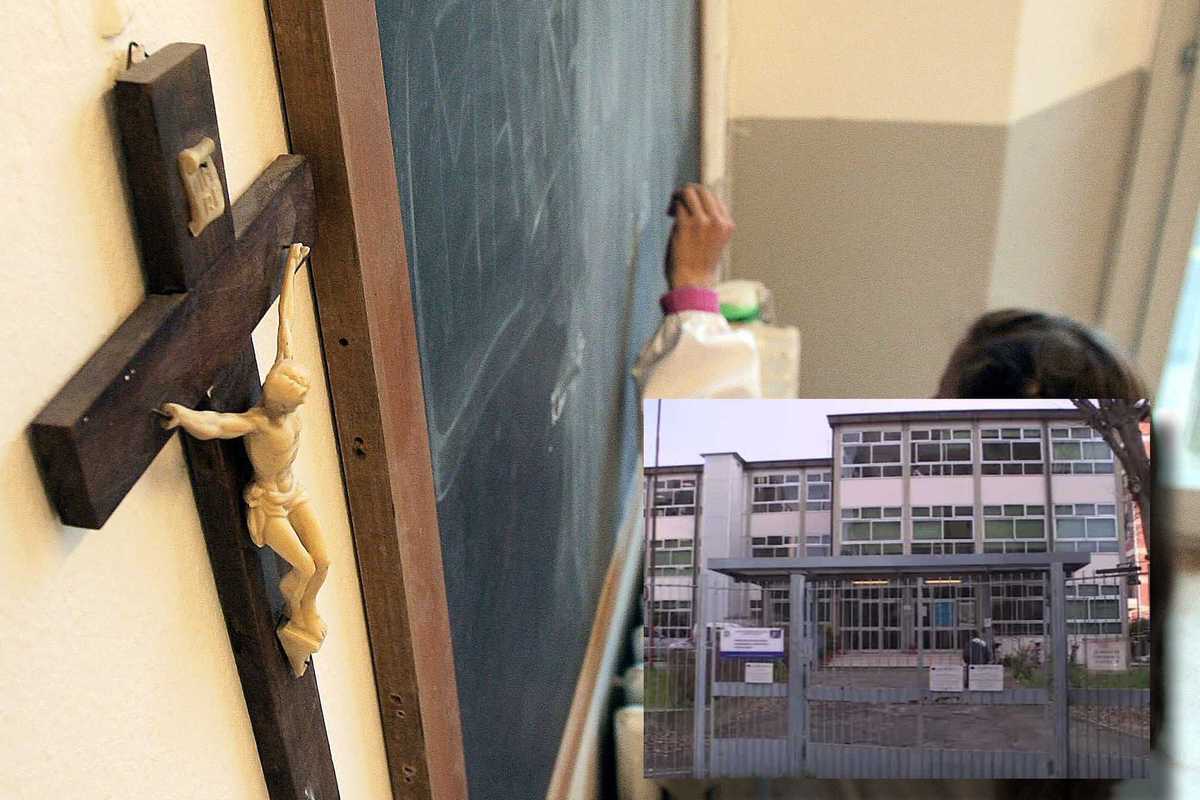Quel giorno era sceso al pontile di Tremezzo ad attendere il battello da Como; la figlia Maria Enrica, impiegata di banca a Cantù, gli aveva promesso che avrebbe trascorso il weekend al lago da lui. In mezzo alla folla dei turisti di quel ramo del lago di Clooney, l'autista in pensione Giovanni Battista Geninazza era un uomo invisibile. Quello che aveva desiderato dopo una vita trascorsa a fuggire da una vicenda lontana. Qualche anno prima aveva negato un'intervista a Storia Illustrata, rinunciando a 10 milioni di lire del 1996, perché «la tranquillità non ha prezzo». Ma adesso, a 87 anni, era arrivato il momento di parlare e lo avrebbe fatto non con uno storico di grido, ma con un ricercatore dilettante appassionato di Storia contemporanea che lo tampinava da una decina d'anni e lo stava aspettando in casa, Pierangelo Pavesi. L'autista del commando partigiano che uccise Benito Mussolini e Claretta Petacci era pronto a raccontare la sua verità.
Quella e altre conversazioni fra il 2006 e il 2008, più un memoriale aperto dopo la morte nel 2009, sono l'architrave di un libro unico e forse definitivo, Sparami al petto! (Ritter edizioni, 400 pagine), la ricostruzione più originale di quel sanguinoso, simbolico, misterioso evento del 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra, culminato con la raffica di mitra francese Mas calibro 7,65 con un nastrino rosso legato alla canna, che chiuse i conti con il fascismo. Il volume è originale per il più semplice dei motivi: lo sguardo di Pavesi è rivolto verso il basso.
Poiché dei protagonisti Walter Audisio o colonnello Valerio, Aldo Lampredi, Michele Moretti si sa tutto; poiché sul coinvolgimento del Pci nell'organizzazione del blitz e nella gestione dell'informazione sono stati versati fiumi d'inchiostro; poiché le sette versioni accreditate (le due di Audisio, quella di Moretti, la pista inglese, la doppia fucilazione della versione Pisanò, l'esecuzione al mattino, il rapporto dell'agente della Cia, Valerian Lada-Mocarski) riposano dentro un centinaio di libri e migliaia di dossier spolpati dalla pubblicistica mondiale, l'autore ha illuminato gli invisibili, le comparse, coloro ai quali la Storia non dà diritto di parola. Come Akira Kurosawa nel capolavoro Rashomon, Pavesi ha rintracciato l'ordinary people, la gente comune che dietro gli scuri di una casa, all'angolo di una strada, tra il fogliame di una siepe ha visto e sentito. E qui offre il suo tassello di verità per il mosaico della Storia.
Giovanni Battista Geninazza aveva 26 anni ed era uno dei pochi a saper guidare l'automobile; aveva imparato da militare e cominciò a fare l'autista di professione. Come lui stesso racconta, fu «requisito» a Dongo dai partigiani dopo la cattura di Mussolini e gli fu affidata una Fiat 1100 nera di proprietà dell'Accademia d'Italia, la stessa sulla quale un anno prima a Firenze era stato ucciso Giovanni Gentile. Con quell'auto andò a prelevare il duce e Claretta Petacci nella casermetta di Germasino (Dongo) dov'erano piantonati e con la scorta guidata dal mitico capitano Neri li condusse a Bonzanigo (Mezzegra) nella casa dei contadini Giacomo e Lia De Maria, luogo in cui trascorsero l'ultima notte.
«Prima della missione Neri mi disse: di ciò che vedrai o sentirai non devi parlarne con nessuno, pena la morte. Sì, proprio pena la morte», rivelò l'autista a Pavesi. «Entrato nella piccola caserma della guardia di finanza vidi Mussolini di profilo in una stanza illuminata, con Pedro e i finanzieri. Trasecolai ma non fiatai, capii la minaccia di Neri». Alla domanda sul giorno, l'ora e il luogo dove furono uccisi il capo del fascismo e la sua amante, Geninazza rispose: «Alle quattro di pomeriggio davanti al cancello di Villa Belmonte a Giulino di Mezzegra. Ero vicinissimo, sentii e vidi tutto mio malgrado. Debbo dire che l'emozione provata si sfogò il giorno dopo: mi venne una febbre da cavallo, poi a poco a poco mi ripresi. La paura però non passò. Molti dei miei compaesani mi avevano visto a Bonzanigo e a Giulino quando fui costretto a ritornare e caricare, aiutato da partigiani locali, i cadaveri di Mussolini e della Petacci. Uno spettacolo che mi sarei volentieri risparmiato. Mi videro tutti, alcuni erano vicini di casa. La domanda che gli leggevo negli occhi era: chissà se ha sparato? Fino a che punto ha partecipato? Volevo una dichiarazione da parte del Cln che attestasse che non c'entravo niente e che ero stato presente al fatto non di mia spontanea volontà. Non la ottenni mai».
Temeva una vendetta da parte dei fascisti e quando cominciò a notare sparizioni sospette in zona decise di trasferirsi a Milano. Si sposò nel 1946 a Collecchio e nella foto del matrimonio la moglie Albertina Alinovi indossa il cappotto di cammello delle Sorelle Fontana che Claretta Petacci aveva lasciato in auto. Oltre ai protagonisti, quel giorno all'esecuzione vista lago parteciparono in tanti, almeno in 20. Tutti fantasmi, tutti sullo sfondo, tutti silenziosi per anni. C'era l'ingegner Bernardo Bellini con la moglie e la figlia, allora proprietari di Villa Belmonte, che videro la «1100» fermarsi con uno sbattere di portiere, il duce e la Petacci avvicinarsi al muro di cinta, e sentirono la raffica partire. C'erano Lino e Sandrino, due partigiani che avevano piantonato i prigionieri, ma che al momento di uscire per accompagnare il commando verso il luogo dell'esecuzione non avevano gli scarponi, quindi persero tempo a calzarli, ad allacciarli, e alla fine sbagliarono strada [...].
Poi le donne. C'era Lia De Maria, che preparò polenta calda con il latte a Claretta e pane e salame a Benito. C'erano la Cecchina, l'Erminia e l'Eralda, tre lavandaie apparentemente chine sui panni al passaggio della strana comitiva, ma che con la loro presenza fecero cambiare i piani al colonnello Valerio. C'era Geneviève Mantz Carpani, che sentì due raffiche di mitra alle 16.10 di quel pomeriggio. C'era Maria Jemoli, la sua domestica, che si era imbattuta nel corteo e lo aveva seguito da lontano. E c'era Roberto Remund, svizzero, l'ultimo partigiano [...].
Sparami al petto!, perché quel titolo così enfatico? Anche qui Pavesi ha voluto approfondire un luogo comune per avvicinarsi alla verità. Nei memoriali di Audisio (Valerio) pubblicati da L'Unità è scritto che Mussolini morì male, balbettando e promettendo imperi pur non avendo più in mano neppure la propria vita. Ma l'autista Geninazza ha sentito altro. «La Petacci fu la prima a capire la sua tragica situazione. Valerio premette il grilletto, ma la raffica non partì. In quel momento lei prese con tutte e due le mani la canna del mitra implorando che non potevano ammazzarli così. Valerio chiamò Pietro (Moretti) perché gli consegnasse il suo mitra. Allora Mussolini, portando la mano al bavero all'altezza dello stomaco, disse due volte: «Sparami al petto«. La raffica partì». Quando tornò il silenzio, Valerio estrasse dal pacchetto due sigarette. Una per sé e una per l'autista, che non aveva mai fumato in vita sua e che nel memoriale annotò: «Le mani gli tremavano».