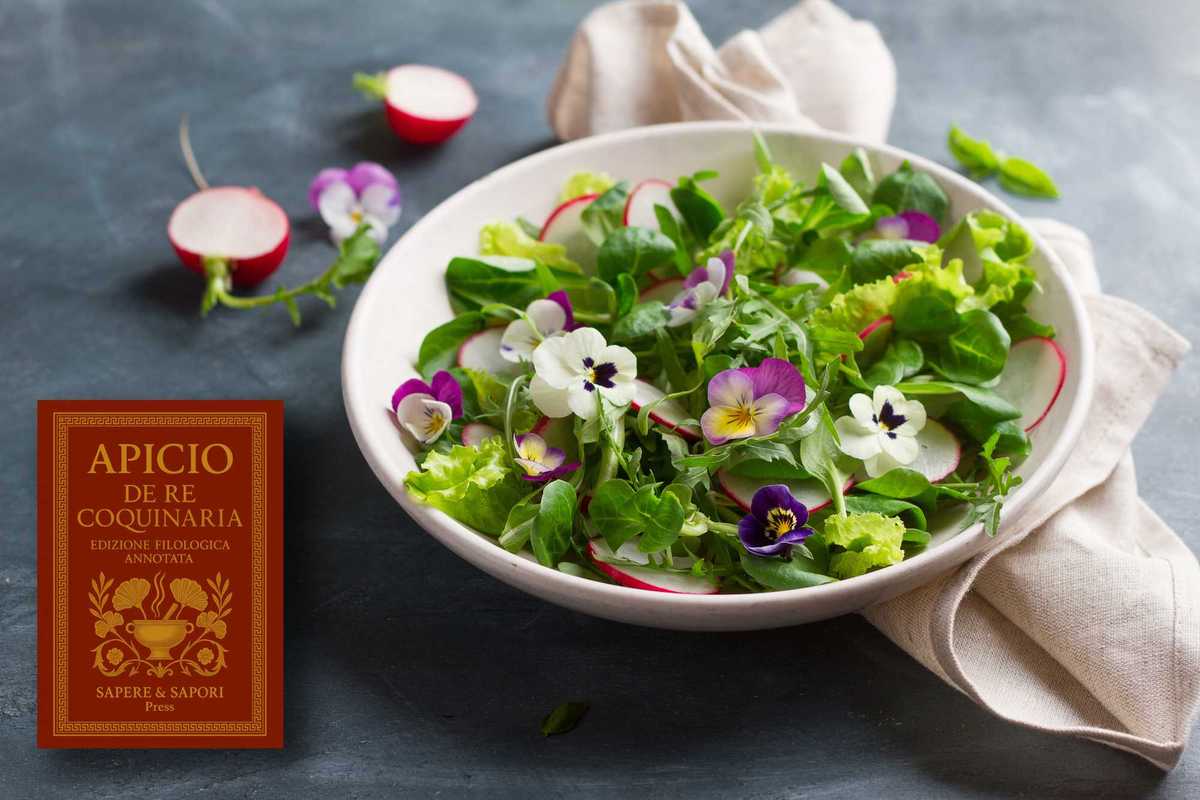Non è tutto oro quello che luccica (ammesso e non concesso che luccichi) nella legge di bilancio presentata dal governo di Mario Draghi per il 2022. Anzi, il bilancio del prossimo anno potrebbe essere ricordato come una delle più grandi opportunità perse dal nostro Paese per ridurre significativamente la pressione fiscale.
Da fine settembre è in corso un dibattito molto acceso su come distribuire i 30 miliardi per il 2022 e la legge di Bilancio ha finalmente offerto un quadro - per certi aspetti ancora provvisorio - sulla distribuzione di tali risorse tra spese, investimenti e riduzioni di tasse, ma quasi nulla si è detto sul perché si sia arrivati a tale cifra. Anzi a tali cifre: 6 miliardi sono il frutto di interventi di ottimizzazione e tagli. Gli altri 24 sono in deficit. E alla fine rappresentano il centro del pallottoliere e il vero saldo netto della legge Finanziaria. Perché, se il bilancio dello Stato del 2021 prevede spese per 937 miliardi oltre a interessi per 60 miliardi, lo spazio di manovra si riduce a 24 miliardi?
Allora proviamo a fare luce su questo tema, e dobbiamo ricordare che la definizione della politica di bilancio - dal 2011 quando fu varato il programma di coordinamento che va sotto il nome di «semestre europeo»- si svolge sotto lo stretto controllo della Commissione di Bruxelles. E si articola in tre tappe: fine aprile, quando va presentato il Documento di Economia e Finanza (Def); fine settembre, quando va presentata la nota di aggiornamento (Nadef) a quel primo documento; metà ottobre, quando va inviato il Documento Programmatico di Bilancio (Dpb), che contiene già tutti i saldi di bilancio per il triennio successivo che poi saranno dettagliati nella legge di bilancio presentata alle Camere entro il 20 ottobre.
Insomma, ormai da dieci anni, i saldi del bilancio vengono comunicati a Bruxelles prima ancora che alle Camere e queste ultime possono solo agire entro un perimetro ben definito.
La lettura combinata e organica di questi tre documenti per gli anni 2021-2024, porta a due constatazioni: pur essendo il 2022 l'ultimo anno in cui resterà attiva la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità, il governo Draghi ha rinunciato a sfruttare questo eccezionale e probabilmente irripetibile spazio di manovra offerto e, in soli cinque mesi, è addirittura indietreggiato negli obiettivi fissati ad aprile, quando aveva promesso un deficit/Pil del 5,9% nel 2022 che poi a settembre ha fissato al 5,6%; inoltre il percorso definito per gli anni successivi è tutto orientato al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità, confermandone in toto i principali cardini.
Altro che revisione del Patto, i nostri documenti di bilancio fino al 2024 ne confermano la piena operatività e promettono il sostanziale azzeramento del saldo primario nel 2024 (-0,8% l'obiettivo programmatico), partendo da un disavanzo di 106 miliardi nel 2021.
Come rilevabile dal grafico in pagina, ad aprile 2021, Draghi e il ministro dell'economia Daniele Franco, si sono presi la responsabilità di confermare che la legge di bilancio 2021 - presentata da Roberto Gualtieri e Giuseppe Conte, e poi integrata da numerosi decreti nei primi mesi di attività del nuovo governo - prevedeva un deficit/Pil del 11,8% per il 2021 e 5,9% per il 2022. Sono bastati solo cinque mesi per fare scendere queste previsioni al 9,4% e 4,3%. Crescita del Pil, aumento delle entrate e riduzione delle spese, tutti superiori alle stime iniziali, le cause di queste variazioni.
Sorgono perplessità su come sia stato possibile avere due previsioni così divergenti a distanza di soli cinque mesi l'una dall'altra. In ogni caso, poiché a caval donato non si guarda in bocca, senza derogare all'impegno del 11,8% preso con Bruxelles, nell'ultimo trimestre del 2021 c'era una eccezionale opportunità di un maxi aiuto fiscale agli italiani - nell'ordine di oltre due punti di Pil, circa 35 miliardi - e non è stata sfruttata. Lo stesso schema si è ripetuto per il 2022. Avevamo promesso alla Commissione il 5,9%, in soli cinque mesi, l'andamento economico ci porta a ridurre la previsione al 4,3% e Draghi e Franco cosa fanno?
Fissano il nuovo obiettivo al 5,6%, quindi al di sotto della promessa iniziale. Da qui originano quei famosi 24 miliardi: si tratta del 1,3% del Pil, proprio la differenza tra 4,3% e 5,6%.
La legge di bilancio 2022 è tutta giocata all'interno di questo perimetro e il Dpb ne definisce la cornice, specificando misura per misura, come ci si dovrà dividere quel 1,3% del Pil di deficit aggiuntivo rispetto a quello che avremmo avuto a legislazione vigente. La pressione fiscale - salita allo stratosferico livello del 42,8% nel 2020 - è prevista scendere al 41,9% nel 2021 e al 41,7% nel 2022. Movimenti impercettibili, quando sarebbe stato possibile osare di più.
La razione di cioccolata è stata aumentata da 30 a 20 grammi, il popolo esulta, ma noi ci permettiamo di avere le stesse perplessità di Winston.