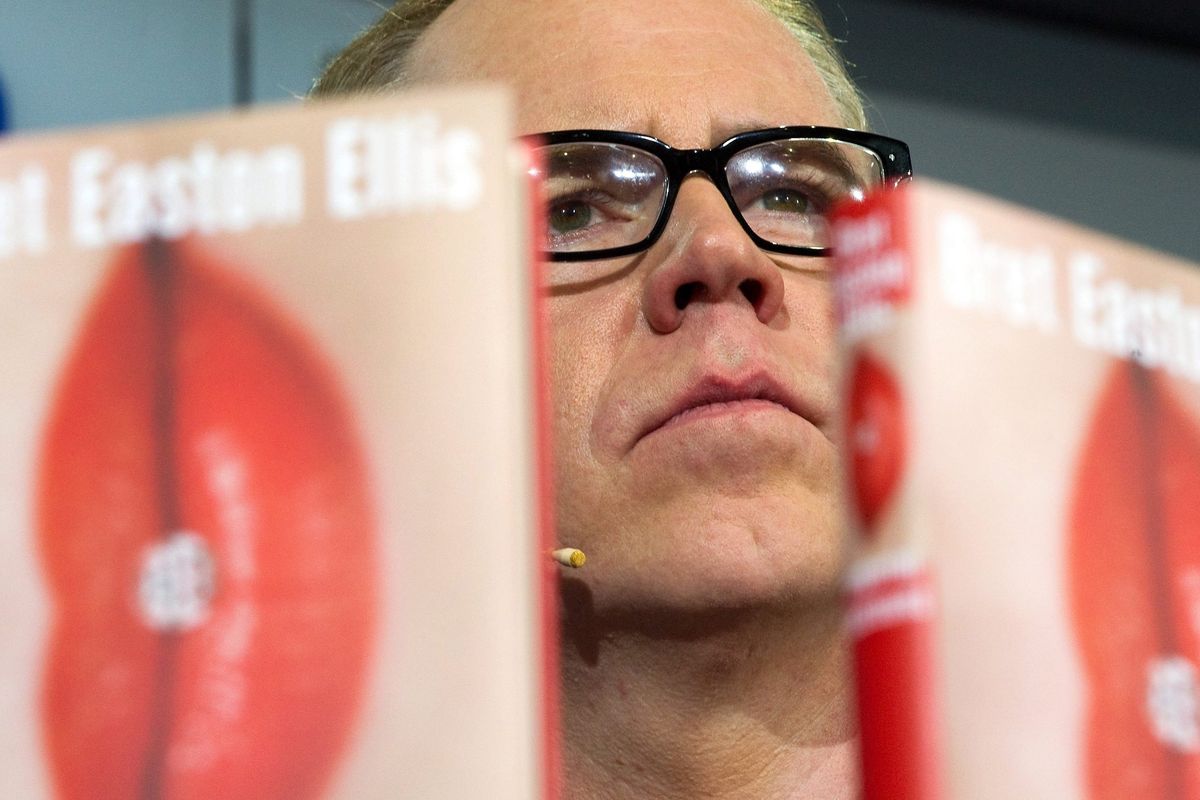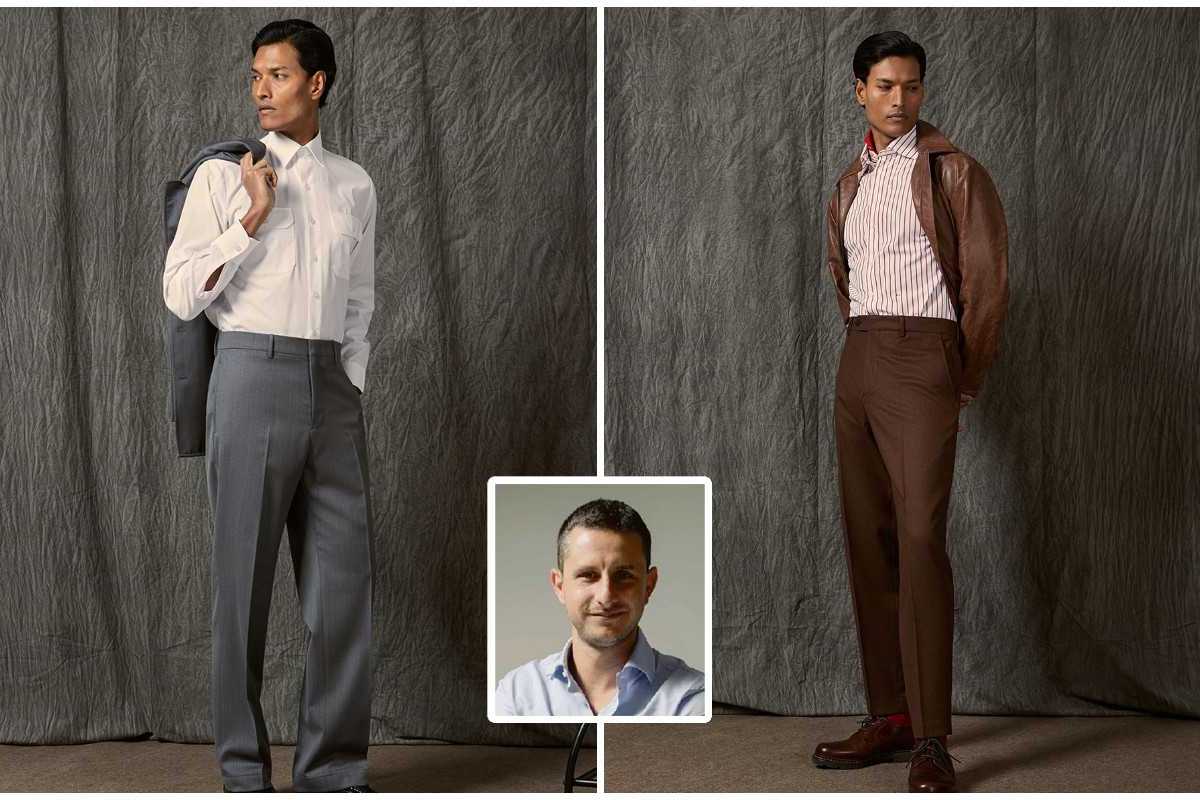True
2025-03-17
Dioniso è tornato in città. Così Fitzgerald e Ellis cantano il lato funebre dell’edonismo
Bret Easton Ellis (Ansa)
Per qualche istante fugace, fu Dioniso scatenato. La musica era forte e ritmata, il sudore imperlava le schiene e le fronti, i sorrisi erano smaglianti. Il denaro fluiva rapido, tutto sembrava facile e raggiungibile. Non è forse così il paradiso in terra? «Fu l’età dei miracoli, l’età dell’arte, l’età degli eccessi, e l’età della satira», così la rimpiangeva Francis Scott Fitzgerald. «Era la generazione in cui le ragazze si raffiguravano come maschiette, la generazione che corrompeva i più vecchi e che superò sé stessa più per mancanza di gusto che per mancanza di principi morali», raccontava lo scrittore americano che in quegli anni infilava il capo in una nube di profumo di successo. «Se solo uno potesse mostrare il 1922! Fu l’anno in cui la giovane generazione toccò l’apice, perché anche se l’Età del jazz continuò, fu sempre meno una questione di gioventù. Gli strascichi furono come una festa per bambini in cui i grandi prendono il sopravvento, lasciando i bambini perplessi, piuttosto trascurati e piuttosto spaesati. Nel 1923, i più grandi, stanchi di stare a guardare il carnevale con malcelata invidia, avevano scoperto che l’alcol giovane aveva preso il posto del sangue giovane, e un urlo diede inizio all’orgia».
Fu Dioniso scatenato, dunque. «Una razza intera diventava edonistica, abbracciando il piacere. Le precoci intimità della giovane generazione ci sarebbero state con o senza il proibizionismo; erano insite nel tentativo di adattare le usanze inglesi al contesto americano». Era l’età del jazz, e Francis era il suo profeta. Proprio lui, cattolico in un mondo protestante, bianco-bianco d’origini irlandesi, nato addirittura nel Minnesota. Che c’entrava, lui, con il jazz della metropoli, con i drink annacquati e le sale da ballo, con le lusinghe di Los Angeles e i fumi di New York? La Grande Mela lo attirava, i genitori acconsentirono a iscriverlo a Princeton, che lo rese uno scrittore (fu lì, tra l’altro, che conobbe il futuro critico Edmund Wilson, divenuto suo affezionato amico).
Francis sognava l’aristocrazia del Sud, la nobiltà d’animo, la cortesia e l’eroismo virile. Non ottenne nulla di tutto ciò. In cambio ebbe fama e dolore. Nel 1920 uscì il suo primo romanzo, Di qua dal paradiso, che il glorioso editor Max Perkins aveva curato per l’editore Scribner. In un lampo, Francis non era più il ragazzino che bramava la gloria militare ma si fece tutta la prima guerra mondiale rimpallando per gli Stati Uniti. Era diventato Scott Fitzgerald, il canto dell’età del jazz, il giovane prodigio: una celebrità.
«Nel suo percorso verso la rispettabilità, la parola Jazz ha significato prima di tutto sesso, poi ballo e infine musica», scrisse parecchi anni dopo. «Essa viene associata a uno stato di eccitazione nervosa, non dissimile da quello delle grandi città a ridosso di un fronte di guerra. Per molti inglesi la guerra non è mai finita perché tutte le forze che li minacciano sono ancora attive - e dunque mangiamo, beviamo e siamo felici perché domani saremo morti. Ma diverse erano le cause che avevano dato luogo a un’analoga situazione in America; sebbene ci fossero intere categorie di persone (i cinquantenni, per esempio) che passarono un decennio a negarne l’esistenza, anche quando la sua faccia dispettosa faceva capolino nella cerchia famigliare. Essi non si sognavano nemmeno di aver contribuito alla sua comparsa. […] Donne dai capelli argentei e uomini dai bei volti anziani, gente che non ha mai fatto consapevolmente nulla di disonesto in tutta la vita, continuano a rassicurarsi vicendevolmente nei residence di New York, Boston e Washington ripetendo che “sta crescendo un’intera generazione di giovani che non conoscerà mai il sapore dell’alcol”. Nel frattempo, nei convitti, le loro nipoti si passano la copia consumata de L’amante di Lady Chatterley e, semmai cominciano a viaggiare, a sedici anni conoscono già il sapore del gin e del bourbon». Dioniso era in città: avevano provato a scacciarlo ma era ritornato più forte di prima. Non restava che abbandonarsi al suo ballo, fingendo almeno per un po’ che non fosse una danza macabra.
Francis Scott Fitzgerald ha 24 anni e viene da Princeton quando pubblica il primo besteller. Bret Easton Ellis proviene da Camden e ne ha appena 22 quando il mondo si accorge di lui per Meno di zero. In Lunar Park, a metà tra finzione e autobiografia, racconta così la sua ascesa: «Da studente, al Camden College nel New Hampshire, mi ero iscritto a un corso di scrittura creativa e nell’inverno del 1983 avevo tirato fuori un manoscritto che alla fine era diventato Meno di zero. Raccontava per filo e per segno le vacanze di Natale a Los Angeles - per la precisione a Beverly Hills - di uno studente ricco, alienato e sessualmente ambiguo, iscritto a un college della costa orientale, descrivendo tutte le feste per cui vagava e tutte le droghe che prendeva e tutte le ragazze e i ragazzi con cui faceva sesso e tutti gli amici che osservava passivamente mentre si perdevano nella tossicodipendenza, nella prostituzione e in una smisurata apatia; giorni passati correndo strafatti di Nembutal con bellissime bionde su cabriolet scintillanti verso la spiaggia; notti perdute nelle sale vip dei club alla moda e tirando cocaina ai tavoli in vetrina di Spago».
Non è più l’età del jazz, sono i plastificati anni Ottanta. Ma le luci sono di nuovo accese, la musica torna a essere alta, i vestiti sono elegantissimi e le scarpe brillano. La nuova generazione si annoia con gin e bourbon: preferisce le droghe. Bret, come Francis, è il cantore della sua generazione, è una celebrità, è uno Scott Fitzgerald sotto anfetamine e amplificato da Mtv. Belli e dannati, come il romanzo di Fitzgerald del 1922. Bret e Francis sono, a tratti, la stessa persona, mezzo secolo dopo o poco più. Lo ha certificato sulla Stampa Giuseppe Culicchia, che ha tradotto le opere di entrambi: «Tante, forse troppe le similitudini che la vita ha riservato ai due scrittori», ha scritto. «Come Scott, Bret in giovane età ha conosciuto grazie ai suoi libri una fortuna e una popolarità straordinarie. E alla pari del primo, di cui scrivevano non solo le pagine culturali ma anche quelle in cui di Fitzgerald si documentavano i viaggi in transatlantico e la vita scintillante tra Parigi e la Costa Azzurra in compagnia di Hemingway o Picasso, anche lui si è ritrovato non solo sul Times Literary Supplement ma anche nella sezione gossip dedicata da quotidiani e riviste al jet-set newyorkese assieme a Jay McInerney o Jean-Michel Basquiat. Entrambi, all’indomani di quel successo che non a caso il nostro Ennio Flaiano definiva come il participio passato di succedere, a un certo punto delle rispettive carriere letterarie hanno tentato la strada di Hollywood, ed entrambi hanno scoperto di non essere fatti per gli schemi assai rigidi della Mecca del Cinema. Dopo il crollo di Wall Street del 1929 il mondo era cambiato, e agli occhi dei produttori le storie e i personaggi di Scott non funzionavano più. Quanto alle storie e ai personaggi di Bret, non potevano e non possono certo funzionare a Hollywood».
Due autori diversi, la stessa persona, persino le date fatidiche si inseguono. Nel 1925, cento anni fa, Francis Scott Fitzgerald pubblica Il Grande Gatbsy, e si consegna senza saperlo all’immortalità. Meno di zero di Bret è del 1985, Lunar Park che ne ricorda i fasti è del 2005. Vent’anni dopo, pochi giorni fa, nelle librerie italiane è uscita la versione tascabile di Le schegge, il suo ultimo, straordinario romanzo. Che cos’hanno in comune questi libri? La rabdomanzia. Hanno raccontato anche il ritorno di Dioniso, certo, ma nel crepuscolo che dipingevano hanno saputo indovinare le profondità delle tenebre in arrivo. Dalle opere di Francis come da quelle di Bret esala, tremendo, il fetore marcio del crollo.
I primi romanzi di Bret Easton Ellis erano - a sentire lui - «un atto d’accusa non solo a uno stile di vita che mi era familiare ma anche - pensavo con una certa presunzione - ai reaganiani anni Ottanta e, indirettamente, alla civiltà occidentale contemporanea». I successivi hanno sancito la distruzione di una generazione, la decadenza della civiltà. Dietro i sorrisi smaltati s’annidava l’incubo. Tama Janowitz che negli Ottanta fu compagna di scorribande e successo di Bret e ora in Italia è pressoché sconosciuta (ci è voluta la coraggiosa Accento edizioni per ristampare il suo piccolo gioiello Schiavi di New York, con prefazione di Veronica Raimo) lo ha scritto chiaro: «Per me gli altri esseri umani sono un misto di vipere, scimpanzé e formiche, una massa virtualmente indistinguibile… che si annusa le dita e stupra». Sembra la descrizione di Patrick Bateman, il serial killer che Ellis ha evocato nel suo capolavoro American Psycho e che ancora lo perseguita. Dietro lo sfavillio delle mille luci di New York si nascondeva il mostro, l’ombra. Dietro il sorriso alcolico di Dioniso, ecco Kali la sanguinaria, pronta al massacro.
L’era dionisiaca finisce sempre nel sangue, nella mattanza. Se ne accorse Fitzgerald che, alla metà degli anni Trenta, constatava: «I miei contemporanei cominciarono a scomparire nelle oscure fauci della violenza. Un mio compagno di classe aveva ucciso la moglie e sé stesso a Long Island, un altro era “accidentalmente” precipitato da un grattacielo di Philadelphia, un altro si era volutamente gettato da un grattacielo di New York. Uno era stato ucciso in uno spaccio clandestino di alcolici a Chicago; un altro lo avevano picchiato a sangue in uno spaccio clandestino di New York e si era rifugiato al Princeton Club, dove era morto; un altro ancora si era fatto spaccare la testa dall’ascia di un folle nel manicomio in cui era rinchiuso. Non furono catastrofi che mi sporsi a guardare: si trattava di miei amici; e per giunta, non erano successe durante la depressione, ma durante il boom economico».
Le bellezza dell’effimero è il maquillage del naufragio. Fitzgerald intravedeva l’angoscia e lo spaesamento dell’America, al pari del pittore suo contemporaneo Edward Hopper. «Nei quadri di Hopper», ha scritto il poeta Mark Strand, «ad accadere sono le cose che hanno a che fare con l’attesa. Le persone di Hopper paiono non avere occupazioni di sorta. Sono come personaggi abbandonati dai loro copioni che ora, intrappolati nello spazio della propria attesa, devono farsi compagnia da sé, senza una chiara destinazione, senza futuro». Così sono i ricchi e belli di Fitzgerald: anime dannate che si scaldano davanti agli ultimi fuochi. Così, in larga parte, sono i personaggi di Bret Easton Ellis, i nostri contemporanei. Il jazz e il pop, in lontananza, hanno una cadenza funebre.
Vettriano, il «signore delle ombre» snobbato dai critici perché popolare
Jack Vettriano, nato a Methil in Scozia nel 1951, è morto il primo di marzo. Per la prima volta l’Italia ospitava una sua grande mostra (a Palazzo Pallavicini a Bologna, aperta fino a luglio) e lui se n’è andato un paio di giorni dopo l’inaugurazione, quasi di soppiatto. Sorprendente coincidenza. Ma ancora più sorprendente è che di mostre di Vettriano - grandi mostre, di quelle con ampio apparato pubblicitario - non ne siano mai state realizzate. Non circolano suoi libri illustrati né merchandise. Eppure il pittore scozzese è stato per decenni tra gli artisti più popolari. Dipende probabilmente dal fatto che i critici, quasi tutti, non gli hanno mai perdonato il successo, il fatto che le sue opere risultassero gradite a molti, adatte ai tempi. L’arte contemporanea richiede più elaborazione concettuale, più impegno sociale e politico, più fuffa concettosa. Vettriano invece veniva da un altro tempo, dipingeva un altro mondo. Era sospeso nell’età del jazz. Scrive Francesca Bogliolo nell’introduzione al catalogo della mostra che «l’arte diviene per Vettriano occasione di introspezione e confronto con condizioni opposte, parti inconciliabili, conflittuali eppure necessarie, inevitabili. La musica a cui sembra rispondere questo sentimento è senza dubbio il jazz: per questo motivo i titoli delle sezioni di questa mostra si ispirano al genere musicale che Jack Vettriano ascolta durante la creazione delle sue opere, tanto da accompagnarne il naturale fluire. [...] Vettriano sa invitare a danzare, corteggia lo sguardo, lo accompagna al ballo senza fine della vita e lo consegna di volta in volta nelle mani di nostalgia, mistero, solitudine, intimità, fino a congedarsi con un inchino».
Un pittore da un altro tempo. Che ritirare donne e uomini anzi maschi e femmine e la loro sensualità, sempre con un lato in ombra. Oleoso sulla superficie, accattivante. Ma il crollo è sempre in agguato, la dissoluzione si avverte, la solitudine aleggia. Dicono che assomigli a Edward Hopper, anzi che lo copiasse. E certo delle somiglianze vi sono. Ma Vettriano è più oscuro. Hopper tenta, tramite la luce, di farsi investire dalla speranza. Vettriano è una superficie liscia, un completo stirato, una acconciatura fresca di parrucchiere, ma con il baratro aperto sotto i piedi. Un buco da cui il desiderio e altre passioni divoranti possono sbucare all’improvviso.
«Tra le sue opere, luce e oscurità si alternano, la presenza convive con l’assenza, la forma dialoga con il contenuto», scrive Bogliolo.
Come tanti artisti inzuppati in atmosfere più o meno decadenti, Vettriano ha venerato la femminilità, senza però ignorarne l’aspetto terribile. «Seducenti e romantiche, le donne di Vettriano occupano la tela con l’eleganza e la raffinatezza delle femme fatale, dive ammalianti eppure irraggiungibili», dice Bogliolo. Gli uomini, invece, «affascinanti e autorevoli, sembrano tuttavia possessori di un potere effimero e apparente, capace di vacillare davanti al colore di un rossetto, a un paio di tacchi a spillo, al bordo sottile di una veste. La passione è misurata, mai volgare, la tensione palpabile, le atmosfere rarefatte. La vita e l’immaginazione vanno sfumando i propri confini, compenetrandosi e sovrapponendosi al pari della luce e del buio. L’amore per la vita è nascosto tra i dettagli, che aprono a una narrazione dagli infiniti finali: in un barlume di luce è nascosto il segreto dell’ombra». Vettriano è lo sfavillio dell’età del jazz, con il crollo in agguato. I critici lo hanno detestato, il pubblico lo ha adorato. Chissà quanti ne hanno avvertito davvero il sotterraneo tormento.
Continua a leggereRiduci
Cento anni fa «Il Grande Gatsby» celebrava gli eccessi di una civiltà già segnata dai germi del disfacimento. Motivi che ci suonano sinistramente familiari. Non a caso ritornano nell’opera dell’autore de «Le schegge».Il pittore scozzese si è spento a inizio marzo, proprio mentre l’Italia per la prima volta ospita una sua mostra (a Bologna). Un’occasione per dare un ultimo tributo a un artista paragonato a Hopper, ma più tormentatoLo speciale contiene due articoliPer qualche istante fugace, fu Dioniso scatenato. La musica era forte e ritmata, il sudore imperlava le schiene e le fronti, i sorrisi erano smaglianti. Il denaro fluiva rapido, tutto sembrava facile e raggiungibile. Non è forse così il paradiso in terra? «Fu l’età dei miracoli, l’età dell’arte, l’età degli eccessi, e l’età della satira», così la rimpiangeva Francis Scott Fitzgerald. «Era la generazione in cui le ragazze si raffiguravano come maschiette, la generazione che corrompeva i più vecchi e che superò sé stessa più per mancanza di gusto che per mancanza di principi morali», raccontava lo scrittore americano che in quegli anni infilava il capo in una nube di profumo di successo. «Se solo uno potesse mostrare il 1922! Fu l’anno in cui la giovane generazione toccò l’apice, perché anche se l’Età del jazz continuò, fu sempre meno una questione di gioventù. Gli strascichi furono come una festa per bambini in cui i grandi prendono il sopravvento, lasciando i bambini perplessi, piuttosto trascurati e piuttosto spaesati. Nel 1923, i più grandi, stanchi di stare a guardare il carnevale con malcelata invidia, avevano scoperto che l’alcol giovane aveva preso il posto del sangue giovane, e un urlo diede inizio all’orgia».Fu Dioniso scatenato, dunque. «Una razza intera diventava edonistica, abbracciando il piacere. Le precoci intimità della giovane generazione ci sarebbero state con o senza il proibizionismo; erano insite nel tentativo di adattare le usanze inglesi al contesto americano». Era l’età del jazz, e Francis era il suo profeta. Proprio lui, cattolico in un mondo protestante, bianco-bianco d’origini irlandesi, nato addirittura nel Minnesota. Che c’entrava, lui, con il jazz della metropoli, con i drink annacquati e le sale da ballo, con le lusinghe di Los Angeles e i fumi di New York? La Grande Mela lo attirava, i genitori acconsentirono a iscriverlo a Princeton, che lo rese uno scrittore (fu lì, tra l’altro, che conobbe il futuro critico Edmund Wilson, divenuto suo affezionato amico).Francis sognava l’aristocrazia del Sud, la nobiltà d’animo, la cortesia e l’eroismo virile. Non ottenne nulla di tutto ciò. In cambio ebbe fama e dolore. Nel 1920 uscì il suo primo romanzo, Di qua dal paradiso, che il glorioso editor Max Perkins aveva curato per l’editore Scribner. In un lampo, Francis non era più il ragazzino che bramava la gloria militare ma si fece tutta la prima guerra mondiale rimpallando per gli Stati Uniti. Era diventato Scott Fitzgerald, il canto dell’età del jazz, il giovane prodigio: una celebrità.«Nel suo percorso verso la rispettabilità, la parola Jazz ha significato prima di tutto sesso, poi ballo e infine musica», scrisse parecchi anni dopo. «Essa viene associata a uno stato di eccitazione nervosa, non dissimile da quello delle grandi città a ridosso di un fronte di guerra. Per molti inglesi la guerra non è mai finita perché tutte le forze che li minacciano sono ancora attive - e dunque mangiamo, beviamo e siamo felici perché domani saremo morti. Ma diverse erano le cause che avevano dato luogo a un’analoga situazione in America; sebbene ci fossero intere categorie di persone (i cinquantenni, per esempio) che passarono un decennio a negarne l’esistenza, anche quando la sua faccia dispettosa faceva capolino nella cerchia famigliare. Essi non si sognavano nemmeno di aver contribuito alla sua comparsa. […] Donne dai capelli argentei e uomini dai bei volti anziani, gente che non ha mai fatto consapevolmente nulla di disonesto in tutta la vita, continuano a rassicurarsi vicendevolmente nei residence di New York, Boston e Washington ripetendo che “sta crescendo un’intera generazione di giovani che non conoscerà mai il sapore dell’alcol”. Nel frattempo, nei convitti, le loro nipoti si passano la copia consumata de L’amante di Lady Chatterley e, semmai cominciano a viaggiare, a sedici anni conoscono già il sapore del gin e del bourbon». Dioniso era in città: avevano provato a scacciarlo ma era ritornato più forte di prima. Non restava che abbandonarsi al suo ballo, fingendo almeno per un po’ che non fosse una danza macabra.Francis Scott Fitzgerald ha 24 anni e viene da Princeton quando pubblica il primo besteller. Bret Easton Ellis proviene da Camden e ne ha appena 22 quando il mondo si accorge di lui per Meno di zero. In Lunar Park, a metà tra finzione e autobiografia, racconta così la sua ascesa: «Da studente, al Camden College nel New Hampshire, mi ero iscritto a un corso di scrittura creativa e nell’inverno del 1983 avevo tirato fuori un manoscritto che alla fine era diventato Meno di zero. Raccontava per filo e per segno le vacanze di Natale a Los Angeles - per la precisione a Beverly Hills - di uno studente ricco, alienato e sessualmente ambiguo, iscritto a un college della costa orientale, descrivendo tutte le feste per cui vagava e tutte le droghe che prendeva e tutte le ragazze e i ragazzi con cui faceva sesso e tutti gli amici che osservava passivamente mentre si perdevano nella tossicodipendenza, nella prostituzione e in una smisurata apatia; giorni passati correndo strafatti di Nembutal con bellissime bionde su cabriolet scintillanti verso la spiaggia; notti perdute nelle sale vip dei club alla moda e tirando cocaina ai tavoli in vetrina di Spago».Non è più l’età del jazz, sono i plastificati anni Ottanta. Ma le luci sono di nuovo accese, la musica torna a essere alta, i vestiti sono elegantissimi e le scarpe brillano. La nuova generazione si annoia con gin e bourbon: preferisce le droghe. Bret, come Francis, è il cantore della sua generazione, è una celebrità, è uno Scott Fitzgerald sotto anfetamine e amplificato da Mtv. Belli e dannati, come il romanzo di Fitzgerald del 1922. Bret e Francis sono, a tratti, la stessa persona, mezzo secolo dopo o poco più. Lo ha certificato sulla Stampa Giuseppe Culicchia, che ha tradotto le opere di entrambi: «Tante, forse troppe le similitudini che la vita ha riservato ai due scrittori», ha scritto. «Come Scott, Bret in giovane età ha conosciuto grazie ai suoi libri una fortuna e una popolarità straordinarie. E alla pari del primo, di cui scrivevano non solo le pagine culturali ma anche quelle in cui di Fitzgerald si documentavano i viaggi in transatlantico e la vita scintillante tra Parigi e la Costa Azzurra in compagnia di Hemingway o Picasso, anche lui si è ritrovato non solo sul Times Literary Supplement ma anche nella sezione gossip dedicata da quotidiani e riviste al jet-set newyorkese assieme a Jay McInerney o Jean-Michel Basquiat. Entrambi, all’indomani di quel successo che non a caso il nostro Ennio Flaiano definiva come il participio passato di succedere, a un certo punto delle rispettive carriere letterarie hanno tentato la strada di Hollywood, ed entrambi hanno scoperto di non essere fatti per gli schemi assai rigidi della Mecca del Cinema. Dopo il crollo di Wall Street del 1929 il mondo era cambiato, e agli occhi dei produttori le storie e i personaggi di Scott non funzionavano più. Quanto alle storie e ai personaggi di Bret, non potevano e non possono certo funzionare a Hollywood».Due autori diversi, la stessa persona, persino le date fatidiche si inseguono. Nel 1925, cento anni fa, Francis Scott Fitzgerald pubblica Il Grande Gatbsy, e si consegna senza saperlo all’immortalità. Meno di zero di Bret è del 1985, Lunar Park che ne ricorda i fasti è del 2005. Vent’anni dopo, pochi giorni fa, nelle librerie italiane è uscita la versione tascabile di Le schegge, il suo ultimo, straordinario romanzo. Che cos’hanno in comune questi libri? La rabdomanzia. Hanno raccontato anche il ritorno di Dioniso, certo, ma nel crepuscolo che dipingevano hanno saputo indovinare le profondità delle tenebre in arrivo. Dalle opere di Francis come da quelle di Bret esala, tremendo, il fetore marcio del crollo.I primi romanzi di Bret Easton Ellis erano - a sentire lui - «un atto d’accusa non solo a uno stile di vita che mi era familiare ma anche - pensavo con una certa presunzione - ai reaganiani anni Ottanta e, indirettamente, alla civiltà occidentale contemporanea». I successivi hanno sancito la distruzione di una generazione, la decadenza della civiltà. Dietro i sorrisi smaltati s’annidava l’incubo. Tama Janowitz che negli Ottanta fu compagna di scorribande e successo di Bret e ora in Italia è pressoché sconosciuta (ci è voluta la coraggiosa Accento edizioni per ristampare il suo piccolo gioiello Schiavi di New York, con prefazione di Veronica Raimo) lo ha scritto chiaro: «Per me gli altri esseri umani sono un misto di vipere, scimpanzé e formiche, una massa virtualmente indistinguibile… che si annusa le dita e stupra». Sembra la descrizione di Patrick Bateman, il serial killer che Ellis ha evocato nel suo capolavoro American Psycho e che ancora lo perseguita. Dietro lo sfavillio delle mille luci di New York si nascondeva il mostro, l’ombra. Dietro il sorriso alcolico di Dioniso, ecco Kali la sanguinaria, pronta al massacro.L’era dionisiaca finisce sempre nel sangue, nella mattanza. Se ne accorse Fitzgerald che, alla metà degli anni Trenta, constatava: «I miei contemporanei cominciarono a scomparire nelle oscure fauci della violenza. Un mio compagno di classe aveva ucciso la moglie e sé stesso a Long Island, un altro era “accidentalmente” precipitato da un grattacielo di Philadelphia, un altro si era volutamente gettato da un grattacielo di New York. Uno era stato ucciso in uno spaccio clandestino di alcolici a Chicago; un altro lo avevano picchiato a sangue in uno spaccio clandestino di New York e si era rifugiato al Princeton Club, dove era morto; un altro ancora si era fatto spaccare la testa dall’ascia di un folle nel manicomio in cui era rinchiuso. Non furono catastrofi che mi sporsi a guardare: si trattava di miei amici; e per giunta, non erano successe durante la depressione, ma durante il boom economico».Le bellezza dell’effimero è il maquillage del naufragio. Fitzgerald intravedeva l’angoscia e lo spaesamento dell’America, al pari del pittore suo contemporaneo Edward Hopper. «Nei quadri di Hopper», ha scritto il poeta Mark Strand, «ad accadere sono le cose che hanno a che fare con l’attesa. Le persone di Hopper paiono non avere occupazioni di sorta. Sono come personaggi abbandonati dai loro copioni che ora, intrappolati nello spazio della propria attesa, devono farsi compagnia da sé, senza una chiara destinazione, senza futuro». Così sono i ricchi e belli di Fitzgerald: anime dannate che si scaldano davanti agli ultimi fuochi. Così, in larga parte, sono i personaggi di Bret Easton Ellis, i nostri contemporanei. Il jazz e il pop, in lontananza, hanno una cadenza funebre. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/dioniso-e-tornato-in-citta-cosi-fitzgerald-e-ellis-cantano-il-lato-funebre-delledonismo-2671337402.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="vettriano-il-signore-delle-ombre-snobbato-dai-critici-perche-popolare" data-post-id="2671337402" data-published-at="1742149791" data-use-pagination="False"> Vettriano, il «signore delle ombre» snobbato dai critici perché popolare Jack Vettriano, nato a Methil in Scozia nel 1951, è morto il primo di marzo. Per la prima volta l’Italia ospitava una sua grande mostra (a Palazzo Pallavicini a Bologna, aperta fino a luglio) e lui se n’è andato un paio di giorni dopo l’inaugurazione, quasi di soppiatto. Sorprendente coincidenza. Ma ancora più sorprendente è che di mostre di Vettriano - grandi mostre, di quelle con ampio apparato pubblicitario - non ne siano mai state realizzate. Non circolano suoi libri illustrati né merchandise. Eppure il pittore scozzese è stato per decenni tra gli artisti più popolari. Dipende probabilmente dal fatto che i critici, quasi tutti, non gli hanno mai perdonato il successo, il fatto che le sue opere risultassero gradite a molti, adatte ai tempi. L’arte contemporanea richiede più elaborazione concettuale, più impegno sociale e politico, più fuffa concettosa. Vettriano invece veniva da un altro tempo, dipingeva un altro mondo. Era sospeso nell’età del jazz. Scrive Francesca Bogliolo nell’introduzione al catalogo della mostra che «l’arte diviene per Vettriano occasione di introspezione e confronto con condizioni opposte, parti inconciliabili, conflittuali eppure necessarie, inevitabili. La musica a cui sembra rispondere questo sentimento è senza dubbio il jazz: per questo motivo i titoli delle sezioni di questa mostra si ispirano al genere musicale che Jack Vettriano ascolta durante la creazione delle sue opere, tanto da accompagnarne il naturale fluire. [...] Vettriano sa invitare a danzare, corteggia lo sguardo, lo accompagna al ballo senza fine della vita e lo consegna di volta in volta nelle mani di nostalgia, mistero, solitudine, intimità, fino a congedarsi con un inchino». Un pittore da un altro tempo. Che ritirare donne e uomini anzi maschi e femmine e la loro sensualità, sempre con un lato in ombra. Oleoso sulla superficie, accattivante. Ma il crollo è sempre in agguato, la dissoluzione si avverte, la solitudine aleggia. Dicono che assomigli a Edward Hopper, anzi che lo copiasse. E certo delle somiglianze vi sono. Ma Vettriano è più oscuro. Hopper tenta, tramite la luce, di farsi investire dalla speranza. Vettriano è una superficie liscia, un completo stirato, una acconciatura fresca di parrucchiere, ma con il baratro aperto sotto i piedi. Un buco da cui il desiderio e altre passioni divoranti possono sbucare all’improvviso. «Tra le sue opere, luce e oscurità si alternano, la presenza convive con l’assenza, la forma dialoga con il contenuto», scrive Bogliolo. Come tanti artisti inzuppati in atmosfere più o meno decadenti, Vettriano ha venerato la femminilità, senza però ignorarne l’aspetto terribile. «Seducenti e romantiche, le donne di Vettriano occupano la tela con l’eleganza e la raffinatezza delle femme fatale, dive ammalianti eppure irraggiungibili», dice Bogliolo. Gli uomini, invece, «affascinanti e autorevoli, sembrano tuttavia possessori di un potere effimero e apparente, capace di vacillare davanti al colore di un rossetto, a un paio di tacchi a spillo, al bordo sottile di una veste. La passione è misurata, mai volgare, la tensione palpabile, le atmosfere rarefatte. La vita e l’immaginazione vanno sfumando i propri confini, compenetrandosi e sovrapponendosi al pari della luce e del buio. L’amore per la vita è nascosto tra i dettagli, che aprono a una narrazione dagli infiniti finali: in un barlume di luce è nascosto il segreto dell’ombra». Vettriano è lo sfavillio dell’età del jazz, con il crollo in agguato. I critici lo hanno detestato, il pubblico lo ha adorato. Chissà quanti ne hanno avvertito davvero il sotterraneo tormento.
Gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard applaudono il brasiliano Lucas Pinheiro-Braathen durante la cerimonia di premiazione per lo slalom Gigante maschile delle gare di sci alpino ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)
Durante la pausa aveva detto: «Quest’anno ho già fatto delle belle rimonte, bisogna tirare fuori tutto, vado all-in». Invece è out. Lo sguardo finisce su Giovanni Franzoni, cognome che finora ha significato salvezza. Niente da fare, il bresciano è sfinito (24º), l’argento nella Libera può bastare. «Sono esausto, non vedo l’ora di staccare un po’ a casa. Gli avversari erano più freschi, mi è uscita la spalla prima di partire, sono al limite. La mia priorità è la velocità, in gigante non mi sono allenato molto. Ho dato tutto e va bene, prima olimpiade positiva, mi darei 8,5».
Archiviata la pratica italiana rimane una gara storica, con la prima medaglia d’oro del Brasile sugli sci: la ghermisce come un’aquila reale Luca Pinheiro-Braaten, superfigo in tuta, con due manche da guerriero delle Alpi come Alberto Tomba, capace di tenersi dietro nella tormenta Marco Odermatt e l’altro svizzero Loic Meillard. Padre norvegese e madre brasiliana, Pinheiro-Braaten ha trascorso i suoi primi 25 anni di vita a fare la spola fra le due sponde dell’Atlantico: a Oslo quando i genitori erano insieme, a San Paolo dopo la separazione, di nuovo in Norvegia per gareggiare con la squadra più organizzata. Ma tre anni fa, per una questione legata agli sponsor, ecco la rottura con la federazione, la fuga in Brasile da mamma Alessandra, un anno per riorganizzarsi e l’invenzione della samba bianca. Bohèmien, casinista il giusto nelle notti di Coppa del Mondo (sei vittorie sempre fra i pali), Pinheiro-Braaten si percepisce manager etico di se stesso. E al traguardo, prima di mettersi l’oro al collo, ha pure il tempo per un messaggio gandhiano: «Spero che i brasiliani capiscano che la differenza è un superpotere. Non importa il background, il colore della pelle, da dove arrivi. Se credi fortemente nel tuo sogno, lo realizzi». Lo diceva già Ayrton Senna, ma va bene uguale. Facile ripeterlo per lui, che guadagna milioni dagli sponsor, può permettersi di pagare uno staff personale da paura, investe in immobili e ha preso casa a Milano: «Dell’Italia amo tutto, le montagne, il sistema di vita, questa città così creativa». Tomba lo chiama al telefono: «Sei il migliore, adesso ci credi?». Il brasiliano piange di gioia. Si scende da Bormio con l’illusione che quell’exploit sia anche un po’ nostro.
Un angelo vola, un angelo cade. È il Superman del pattinaggio artistico, lo statunitense Ilia Malinin (genitori uzbeki), presentato come un genio assoluto, l’oro più scontato (non perdeva dal 2023) con copertina su Sport Illustrated, l’imperatore del quadruplo Axel, un Rudolf Nureyev con le lame sotto i piedi. Morale: ottavo nella gara della vita dopo due cadute rovinose. Un incubo psicologico lo accompagnava da giorni, era obbligato a vincere ed è crollato. Se la testa non è fredda, lo Sport diventa una scimmia sulla schiena; ora il suo mental coach avrà di che lavorare. Mentre l’Italia di hockey subisce una dura lezione dalla Finlandia (11-0) e va a casa con tre sconfitte, contiamo le altre ferite di giornata. Solo dignitosa la staffetta femminile di Fondo (6ª), delude il Biathlon donne sprint dove Lisa Vittozzi non riesce a ripetere l’impresa di una settimana fa e arriva quinta mentre la leader più accreditata Dorothea Wierer scompare nelle retrovie dopo sequenze imbarazzanti al poligono. Oro alla norvegese Maren Kirkeide. Neppure sulla pista milanese di Pattinaggio velocità va meglio: nella 500 maschile Jeffrey Rosanelli sbiadisce al 17º posto nella gara dominata dal fuoriclasse statunitense Jordan Stolz (già oro nei 1000). Ci va male anche in allenamento: ieri la mascotte italiana, la napoletana di 16 anni Giada D’Antonio cade in slalom e si rompe un legamento crociato. Adieu.
È una giornata così, sarà il clima di San Valentino distrutto a colpi di insulti nel curling, dove gli svedesi sconfitti accusano due volte i canadesi di aver toccato la stone con una mano dopo il lancio. Il FairPlay va a farsi benedire e il Var non c’è. Allora ci pensa il capitano canadese Marc Kennedy a chiudere la polemica con un «Fuck you, la scopa puoi mettertela…» che ci costringe a ripensamenti sulla proverbiale compostezza anglosassone.
Oggi riparte la caccia al record delle 20 medaglie di Lillehammer. Per l’Italia tornano in pista i grossi calibri: Federica Brignone e Sofia Goggia (Gigante), Michela Moioli (Snowboard) e Francesca Lollobrigida (Pattinaggio), obiettivi preferiti dei fotografi. Ieri a Bormio non si capiva perché i paparazzi girassero attorno al gigantista argentino Tiziano Gravier, finito nelle retrovie. È il figlio dell’ex modella Valeria Mazza, cercavano tutti la mamma.
Continua a leggereRiduci