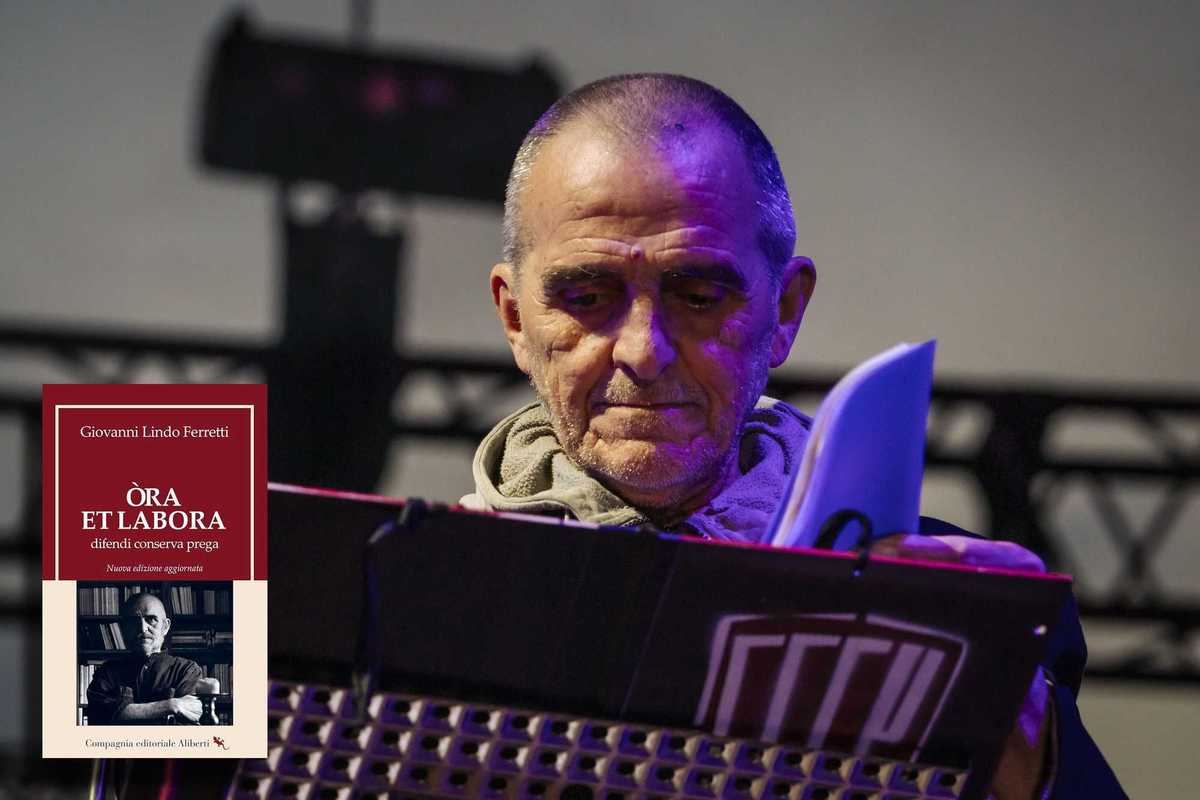La Sicilia, nella sua storia recente, ha avuto un ambasciatore di rara efficacia quale Andrea Camilleri a promuoverne le mille ricchezze della culturale materiale, assieme al suo alter ego goloso, il commissario Salvo Montalbano. Con ventun milioni di copie vendute, le serie televisive andate in onda per quindici stagioni, Camilleri & Montalbano sono entrati stabilmente nell'immaginario collettivo, non solo nazionale.
Una storia partita da lontano. Nato nel 1925 a Porto Empedocle, sulla costa agrigentina, il piccolo Andrea è cresciuto in una grande famiglia patriarcale dove chi comandava in cucina era nonna Elvira, un'autentica «generalessa». La chiave di volta in un'intervista rilasciata a Sebastiano Messina: «E così lei vuole sapere da me la storia degli arancini di Montalbano e dei suoi piatti preferiti. Vuole farmi arriminare (muovermi) in quella zona della mia memoria dove sono sarbati (conservati) i profumi, gli aromi, i sapori della tavola del commissario. Cioè la mia».
Nonna Elvira passava le ore in cucina, fin dal primo mattino, una passione per la lavorazione del pane. «Lavorava l'impasto sullo scanaturi (il tagliere di legno di faggio). Alla fine si siedeva sopra così da spianare bene tutte le forme prima di infornarle». A lui toccava la scanatedda (una focaccina) che tagliava, condiva con olio, pepe nero e pecorino e poi andava a papparsela sotto un albero di carruba «a dieci anni mi bastava e avanzava per essere felice». Varie altre le testimonianze di un imprinting rimasto poi senza tempo, perché i sapori del passato sono irripetibili. «Una volta, bevendo l'uovo, appena scodellato, ti accorgevi subito se la gallina aveva sconfinato nel campo di trigonella» (una pianta aromatica presente fuori dall'aia, nei pascoli riservati al bestiame).
Porto Empedocle in cui non c'era solo nonna Elvira a marcare il Dna identitario. Con una sosta brevissima si fermò (un quarto d'ora) pure il Duce. Gli fecero assaggiare il gelato del Caffè Castiglione. La settimana dopo la capitaneria di porto ricevette una telefonata direttamente da Roma. Un idrovolante stava atterrando per caricare apposta «un pozzo di gelato». Cosa che avvenne, regolarmente, per diversi sabato di fila. Nella traduzione letteraria Porto Empedocle divenne Vigata, protagonista di gran parte delle storie di Montalbano, anche se le scene televisive vennero poi girate a Scicli. Camilleri seppe fidelizzare i suoi lettori non solo per le avvincenti trame (pure golose) che vedevano protagonista il suo commissario, ma anche per un linguaggio di inedita contaminazione italo Trinacria. A Stefania Campo che gli chiedeva i segreti di tale idioma fece una sintesi impeccabile. «La lingua che uso nei miei libri non è una trascrizione del dialetto siciliano, ma una reinvenzione del dialetto. Un recupero di una certa quantità di parole contadine che si sono perse nel tempo». Una sorta di «vigatese» per uso letterario.
Mentre la memoria dei piatti è reale, autentica archeologia golosa che si riscopre attraverso le pagine laddove un estatico Montalbano si gusta ai quattro palmenti (e in rigoroso silenzio) a' munnizza come la fragaglia, la pappanozza per concludere in gloria con la petrafennula. Chi era veramente Salvo Montalbano, dietro l'inattaccabile veste di baluardo della giustizia interpretato da Luca Zingaretti? Gli piace «mangiare in assoluto silenzio non solo a casa, ma anche nei locali, dove ama isolarsi dal mondo», salvo sbottare con manifesta indignazione quando capita che qualcuno violi delle regole base della buona tavola. Un giorno al suo braccio destro, Mimì Augello, viene concesso di condividere un pranzo per parlare di lavoro, ma qua avviene il patatrac. Il maldestro Mimì osa ricoprire con abbondanti dosi di parmigiano degli innocenti spaghetti con le vongole. «Persino una jena che è una jena e si nutre di carogne avrebbe dato di stomaco all'idea di un piatto di pasta alla vongole con il parmigiano sopra». Monsignor Giovanni Della Casa forse avrebbe usato un altro tono, ma la sostanza non cambia. In realtà Montalbano sa che, a casa, lo attendono mani sicure in cucina, quelli della fedele cuoca Adelina, una sorta di psicologa ai fornelli che sa intercettare, in base agli umori del commissario, quali siano i piatti che vanno meglio nei diversi contesti, «ricette della tradizione, quelle che solo le donne siciliane conoscono e si tramandano oralmente di generazione in generazione».
Qualcuno si è preso la briga di monitorare le citazioni culinarie di Camilleri applicate alle storie di Montalbano. Ben centoventidue ricette in un'antologia, tra ripescaggi storici e variazioni di genere, che lo rendono una sorta di Pellegrino Artusi a dimensione Trinacria. Le relative citazioni sono una dolorosa scelta per sottrazione. Cominciamo con una grande classico, la caponata di melanzane. «Appena aperto il frigo la vide. La caponatina! Sciavurosa (profumata), colorita, abbondante. Erano mesi che non gliela faceva trovare. Naturali, spontanee, gli acchianarono (gli salirono) in bocca le note della marcia trionfale dell'Aida». Gli arancini sono un must dello street food insulare, eppure prepararli era «lungariusu», richiedeva molto tempo, come gli ricordava nonna Elvira. Non si friggevano subito, andavano preparati la sera prima e poi si fanno friggere fino a quando «pigliano un colore d'oro vecchio». Montalbano aveva il suo trattore di fiducia, l'oste Calogero, ma un giorno questi abbassò le serrande, e il commissario dovette trovare un altro porto sicuro per le sue riflessioni golose. Incrocia il trattore Filippo, la scena è degna di un film di Sergio Leone, un duello che finì poi ad armi pari, con soddisfazione reciproca.
Le polpette di pesce potrebbero sembrare semplici comparse, ma hanno un loro valore, se dosate con sapienza nei vari ingredienti. Ecco il nostro commissario impegnato nell'ennesima sfida, identificarli, uno ad uno. «Si mise in bocca mezza polpetta e con la lingua e il palato principiò un'analisi scientifica che Jacomuzzi (il capo della scientifica, ndr) poteva andare ad ammucciarsi (nascondersi)». Si può rendere l'onore delle armi ad un umile nasello? Certo, basta saperlo valorizzare a dovere. «Gridavano, i pezzi di nasello, la loro gioia per essere stati cucinati come Dio comanda. Portò alla bocca il primo boccone, ma non lo ingoiò subito. Lasciò che il gusto si diffondesse dolcemente e uniformemente su lingua e palato, che lingua e palato si rendessero pienamente conto del dono che veniva loro offerto».
Un Montalbano che, quando apre il frigo al termine di una giornata di lavoro, è curioso di vedere cosa Adelina gli abbia preparato e, alla vista del sauro imperiale con cipollata, «fece un nitrito di felicità». Si potrebbe continuare per altre puntate, ma se qualcuno vuol mettersi a dieta ecco il tinnirume, i germogli delle zucchine lunghe, la felicità dei dietologi.
Ma è ora di finire in gloria ed ecco la petrafennula, un dolce oramai a forte rischio di estinzione. «Più duro era più gustoso diventava», tradizione della Festa dell'Immacolata, l'8 dicembre. Un croccante frutto di miele, mandorle, bucce di cedro e arance. Il fine pasto dei lauti pranzi natalizi. Tanto che, l'unico modo di gustarlo, è lasciarlo sciogliere pazientemente in bocca. Non a caso, tra la gente sicula «farsi petrafennula» significa «essere del tutto inamovibili sui propri principi».


 Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania
Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania