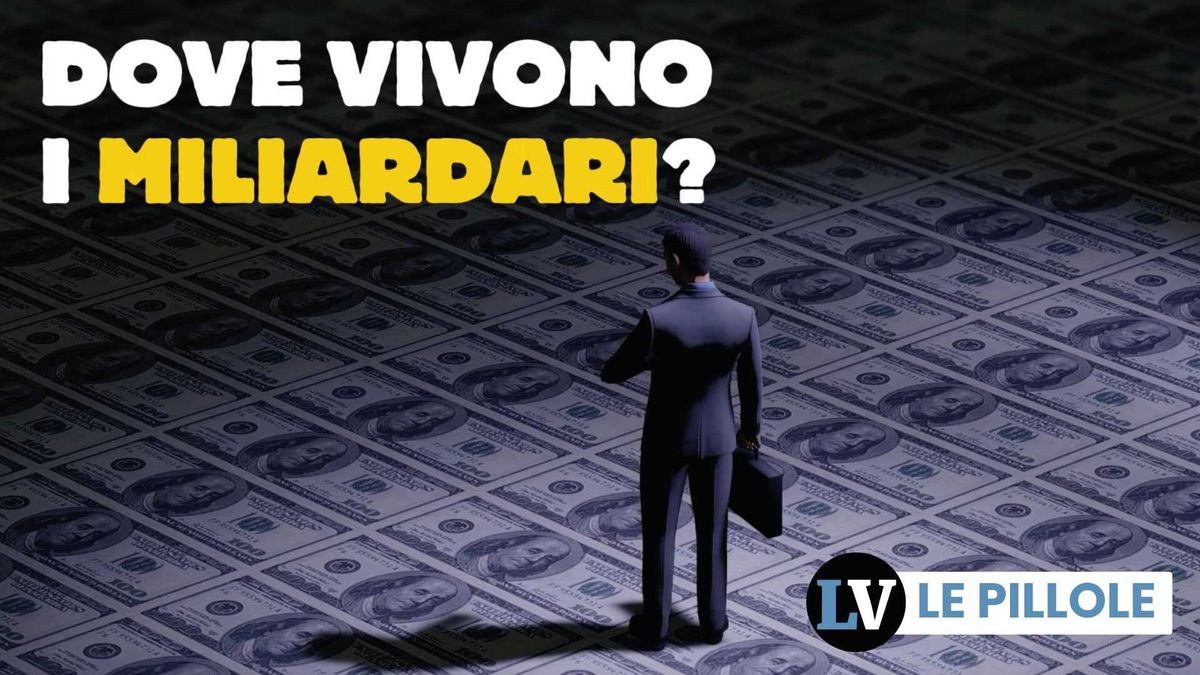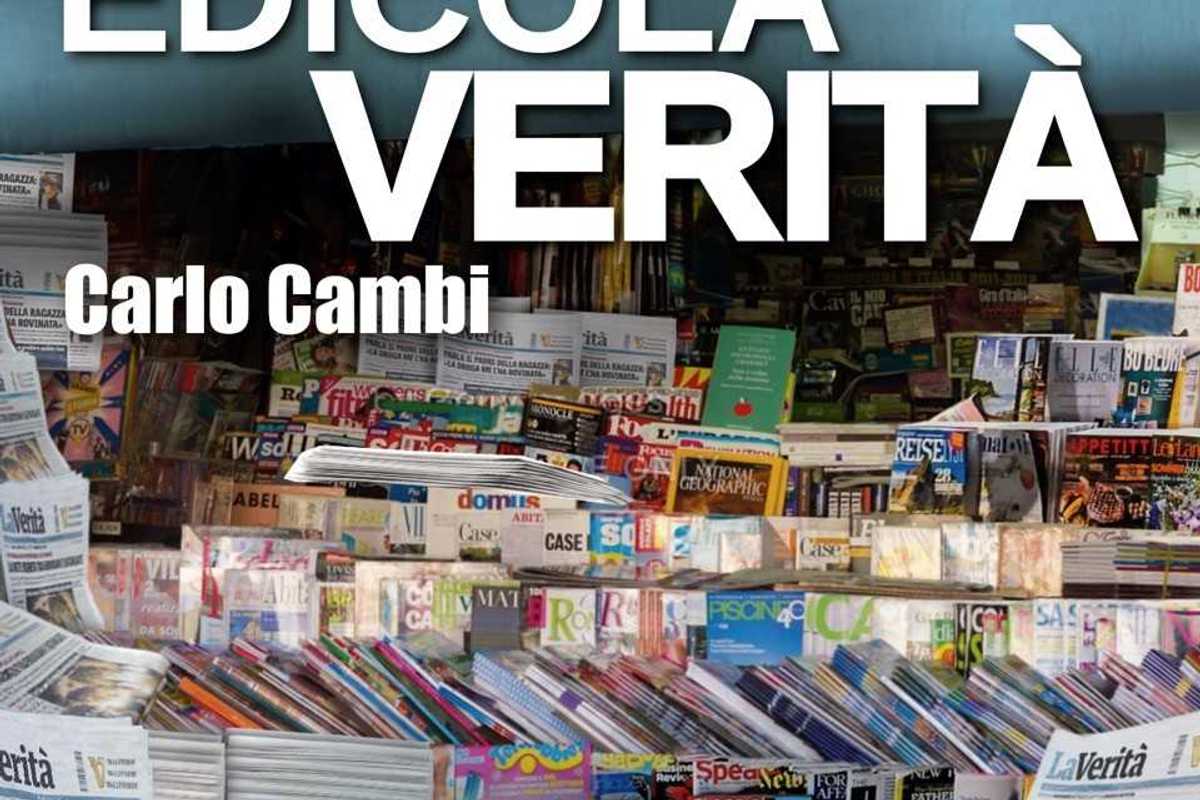- Continua a crescere il numero dei fuori ruolo autorizzati dal Csm. Lavorano (con doppio stipendio) nelle pubbliche amministrazioni spesso all’estero e lasciano sguarniti gli uffici di provenienza.
- Il presidente dell’Unione delle camere penali Gian Domenico Caiazza: «Formalmente i distacchi rispondono a chiamate personali ma sono concordati con l’Anm e dosati tra le varie correnti. La Cartabia dovrebbe toglierli dall’ordinamento».
Lo speciale contiene due articoli.
La giustizia italiana avanza come una lumaca, ma la magistratura sotto organico si concede il lusso di consentire a oltre 200 toghe di fare altri lavori. È il fenomeno dei magistrati fuori ruolo: giudici e pubblici ministeri distaccati in posti chiave di ministeri e altri enti statali o internazionali. Capi di gabinetto e di dipartimento, capi del personale, consiglieri giuridici, responsabili degli uffici legislativi, inviati all’estero: sono molteplici le opportunità di lavorare lontano dai tribunali. E naturalmente con doppio stipendio: quello di magistrato e di «gran commis» di Stato. Una soluzione che conviene sia al magistrato (due stipendi per un lavoro solo) sia al ministero, che paga solo l’indennità: se dovesse assumere qualcuno, dovrebbe farsi carico di uno stipendio intero.
Un esempio. Nell’elenco pubblico degli attuali 161 fuori ruolo con incarichi amministrativi figura la dottoressa Tiziana Coccoluto, che dopo una carriera da magistrato di tutto rispetto (ha prestato servizio al tribunale di Roma con funzioni di gip e gup), è passata a lavorare nei ministeri. Ai Beni culturali dal 2015 è stata vice capo di gabinetto vicario e successivamente capo di gabinetto dei ministri Dario Franceschini e Alberto Bonisoli; dal 2019 è consigliere giuridico confunzioni di vice capo di gabinetto vicario al ministero della Salute guidato da Roberto Speranza. In questi anni da fuori ruolo, la dottoressa Coccoluto è passata dalla quinta alla sesta valutazione di professionalità, con relativo scatto di stipendio: la retribuzione lorda annua dei magistrati di quinta valutazione è sui 105.000 euro (la somma esatta dipende anche dall’anzianità di servizio e relativi scatti) mentre quella dei magistrati di sesta sta su 110.000 euro esclusi tredicesime, arretrati, indennità speciali, adeguamenti di stipendio. A questa paga base si aggiunge un compenso annuo lordo di 41.846,11 euro per le funzioni svolte al ministero della Salute.
reclutati a via arenula
Dei 180 responsabili amministrativi al ministero della Giustizia, 90 appartengono all’ordine giudiziario, tutti con incarichi di vertice. Un nome per tutti: il dottor Marcello Rescigno è incardinato al tribunale di Napoli, in una Regione dove la giustizia soffre di organici carenti ed enormi arretrati; ciononostante egli è stato chiamato ad assumere la funzione di ispettore generale in Via Arenula, anch’egli con stipendio da magistrato più l’indennità ministeriale. Altro paradosso: al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), che dipende dal ministero della Giustizia, operano magistrati fuori ruolo che sono tutti pubblici ministeri.
Sul sito del Csm compaiono gli elenchi dei fuori ruolo. Al 30 aprile 2021, i magistrati collocati fuori ruolo presso altri uffici o enti sono 161 (erano 152 nel 2017) rispetto a un tetto fissato dalla legge in 200; quelli collocati fuori ruolo presso organi costituzionali o di rilievo costituzionale sono 47 (lavorano al Csm stesso, alla Corte costituzionale e alla presidenza della Repubblica); quelli fuori ruolo per incarichi elettivi sono 20; infine altri 3 sono in aspettativa per ricongiungimento coniugale. Le amministrazioni sono numerosissime: ministeri, Parlamento, autorità di garanzia (dal Garante per la concorrenza all’Anticorruzione), ambasciate. Parecchi sono all’estero: Commissione europea, Consiglio d’Europa, Corte di giustizia europea, Corte dei diritti dell’uomo e altri ancora. Il dottor Alberto Landolfi, in organico a Genova nella direzione antimafia e antiterrorismo, è stato spedito fuori ruolo a Rabat, in Marocco, come «magistrato di collegamento» dal 2019. Nello stesso anno il Csm ha deliberato che la dottoressa Roberta Collidà svolgesse il ruolo di magistrato di collegamento tra il ministero della Giustizia francese e il Principato di Monaco, con sede a Parigi, dove nei mesi scorsi ha seguito, tra l’altro, l’arresto dei 10 terroristi rossi da anni latitanti Oltralpe. Dalla risposta a un’interpellanza dell’onorevole Enrico Costa (oggi in Azione) ed ex sottosegretario alla Giustizia si apprende che magistrati italiani, oltre che a Parigi e Rabat, lavorano anche a Strasburgo, Tunisi, Lussemburgo, Tirana e all’Aja alla Corte penale internazionale.
La dottoressa Elisabetta Maria Cesqui, magistrato di grande esperienza con un curriculum fatto di importanti inchieste, ha svolto funzioni non giudiziarie al ministero della Giustizia dal 3 giugno 1998 al 21 giugno 2001 e dal 15 ottobre 2014 al 27 giugno 2018, per un totale di 6 anni e 9 mesi (il collocamento fuori ruolo non può superare i 10 anni complessivi). Lo scorso febbraio il Csm ha autorizzato, eccezionalmente, il collocamento fuori ruolo della Cesqui come capo di gabinetto al ministero del Lavoro nonostante che nell’ufficio di appartenenza, cioè la Procura generale della Cassazione, l’organico fosse scoperto per il 28,57%: il limite di legge è il 20%.
organici in sofferenza
Secondo l’Eu Justice scoreboard 2021, il rapporto annuale di comparazione fra i sistemi giudiziari degli Stati Ue, quello italiano è tra più lenti d’Europa: occorrono in media 500 giorni per la conclusione di una causa civile in primo grado, si sfiorano gli 800 giorni in appello e si superano i 1.200 giorni nel terzo grado di giudizio. Il nostro Paese rimane soggetto alla sorveglianza rafforzata del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per la durata dei procedimenti amministrativi e penali. La giustizia lumaca va di pari passo con le carenze d’organico. E ha pesanti ripercussioni economiche. All’ultimo Forum Ambrosetti di Cernobbio, il guardasigilli Marta Cartabia ha quantificato in 573.779.000 euro gli indennizzi che lo Stato italiano ha pagato negli ultimi 5 anni per i ritardi nei processi. Questa somma, per esempio, comprende i 5.500 euro sborsati per la durata irragionevole del processo (11 anni, 4 mesi e 27 giorni) al boss di mafia Luigi Mancuso. Da Bruxelles ci hanno bacchettato più volte: il Consiglio europeo nelle sue annuali Raccomandazioni ha costantemente sollecitato l’Italia a «ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio», nonché ad «aumentare l’efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione».
L’assottigliamento di un organico già in difficoltà è però soltanto uno dei problemi posti dal massiccio ricorso alle toghe fuori ruolo per incarichi nella pubblica amministrazione. L’altro è proprio la commistione tra magistratura e politica. Come rileva Costa, all’ufficio legislativo di Via Arenula lavora un solo non magistrato: gli altri sono tutti giudici o pm. Difficile che un parere o una bozza di provvedimento uscito dal ministero della Cartabia possa urtare l’interesse delle toghe. In quegli uffici potrebbero lavorare avvocati, docenti universitari, funzionari pubblici, ma a decidere o a fare pressioni sono sempre magistrati. Il conflitto d’interessi è dietro l’angolo, mentre si consolida il potere delle toghe sull’esecutivo.
«La presenza nei ministeri rafforza il potere delle toghe sulla politica»
A che punto è la riforma della giustizia alla quale ha messo mano il guardasigilli Marta Cartabia? I primi provvedimenti sono stati una delusione. E non si fanno altri passi avanti, soprattutto sulla situazione dei fuori ruolo. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione delle camere penali italiane.
Come reputa la riforma proposta dal ministro della Giustizia?
«Riteniamo che la riforma non affronti in modo adeguato le situazioni sulle quali è necessario intervenire, se si vuole arrivare a una vera riforma dell’ordinamento giudiziario. È una riforma troppo concentrata sul sistema elettorale che, a nostro giudizio, costituisce un aspetto marginale sul quale intervenire. Non è certamente cambiando il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura che si risolvono i problemi della degenerazione del correntismo e della credibilità della magistratura italiana».
Dove bisognerebbe incidere?
«Si fa molto poco sul tema, importantissimo, dei giudizi di professionalità per l’avanzamento delle carriere. A nostro giudizio vanno introdotti i criteri che responsabilizzano professionalmente il magistrato chiamato a rispondere dei risultati delle proprie scelte professionali e della sua operatività. Di tutto questo nella riforma non c’è traccia».
E i fuori ruolo?
«Una novità anche rispetto alle più recenti bozze della riforma, dove il problema era stato ignorato. Si tratta, però, di un passo in avanti ancora timido perché nella riforma si dà solo un’indicazione di massima annunciando una “diminuzione” del loro numero».
La questione era stata segnalata negli anni, anche da voi. Non si poteva fare qualcosa prima?
«Il tema è cruciale. Sicuramente si poteva affrontare prima, ma non è mai stato fatto. La diminuzione ipotizzata nella bozza Cartabia è un elemento positivo ma insufficiente. Intanto è una definizione molto generica: diminuire va bene, ma bisogna indicare di quanto: del 10, del 50, del 70%? Il problema non è la percentuale di riduzione, ma l’eliminazione del fenomeno. Non c’è ragione di affidare ruoli amministrativi a chi ha vinto un concorso in magistratura».
Perché non basta una riduzione del numero?
«Chi vince il concorso di magistratura deve fare il magistrato, non andare a occupare ruoli nell’esecutivo. Questo determina una commistione tra due poteri dello Stato, quello esecutivo e quello giudiziario, sottraendo risorse a quest’ultimo. Ci lamentiamo che il numero dei magistrati è largamente insufficiente per il carico delle cause, e poi lasciamo che 200 vengano dirottati nei ministeri. Bisognerebbe intervenire in modo molto più radicale, sostanzialmente impedendo, tranne casi eccezionali, il distacco dei magistrati dai propri ruoli».
Quindi non tutti i magistrati fuori ruolo sono realmente indispensabili in altri incarichi?
«Assolutamente no. L’esperienza giudiziaria può essere utile come consulenza, ma i compiti attualmente ricoperti da magistrati nella pubblica amministrazione possono essere assunti innanzitutto da personale di ruolo delle stesse amministrazioni. Non è affatto detto che in un ministero il capo di gabinetto, del settore legislativo o del personale debbano essere magistrati. Nel settore pubblico esistono risorse professionali molto qualificate. Se il loro numero è insufficiente, che vengano banditi concorsi per assunzioni senza attingere dal bacino della magistratura».
C’è anche un tema economico: le toghe fuori ruolo mantengono lo stipendio più un’indennità per gli incarichi che vanno a ricoprire…
«Certamente c’è anche questo, ma non è il problema fondamentale. È molto più grave la commistione che si è creata con la politica, perché poi queste persone ritorneranno in magistratura. Ci si sbraccia per rivendicare l’indipendenza della magistratura dalla politica, ma ogni nuovo governo si siede a tavolino con l’Associazione nazionale magistrati per spostarne 200 nell’esecutivo. Più dipendenza e commistione con la politica di questo è difficile immaginare».
Il Csm concede «eccezionalmente» il collocamento dei fuori ruolo anche quando si supera la soglia del 20% di scoperto nell’ufficio di provenienza del magistrato.
«Questo dimostra quanto valore politico la magistratura attribuisca a questi distacchi che, di fatto, conferiscono un potere straordinario e indebito non solo al singolo fuori ruolo, ma all’intera categoria in generale. Formalmente i distacchi rispondono a chiamate personali dei singoli ministri, in realtà sappiamo benissimo che sono concordati con l’Associazione nazionale magistrati e accuratamente dosati tra le varie correnti anche tenendo conto del colore politico del governo. In questo modo la magistratura ottiene un potere di interlocuzione molto forte con la politica».
È per questo che anche la riforma Cartabia è molto timida in materia?
«Certamente. Registriamo comunque un primo segno di attenzione».
Altro caso sono i magistrati direttamente impegnati in politica.
«I fuori ruolo sono magistrati spostati dalla funzione giudiziaria a quella amministrativa. Poi sì, ci sono anche quelli che si fanno eleggere parlamentari, sindaci, consiglieri regionali… E poi, finito il mandato, riattraversano le cosiddette “porte girevoli” e vengono reintegrati nelle proprie funzioni. Nemmeno su questo tema mi pare vi siano grandi novità all’orizzonte. Noi pensiamo che un magistrato entrato in politica debba abbandonare definitivamente la funzione giurisdizionale. Il problema non è dopo quanti anni, o se deve tornare a svolgere le funzioni in una regione diversa da quella del collegio elettorale. Un magistrato che ha cambiato mestiere non deve più rientrare nei ranghi della magistratura».