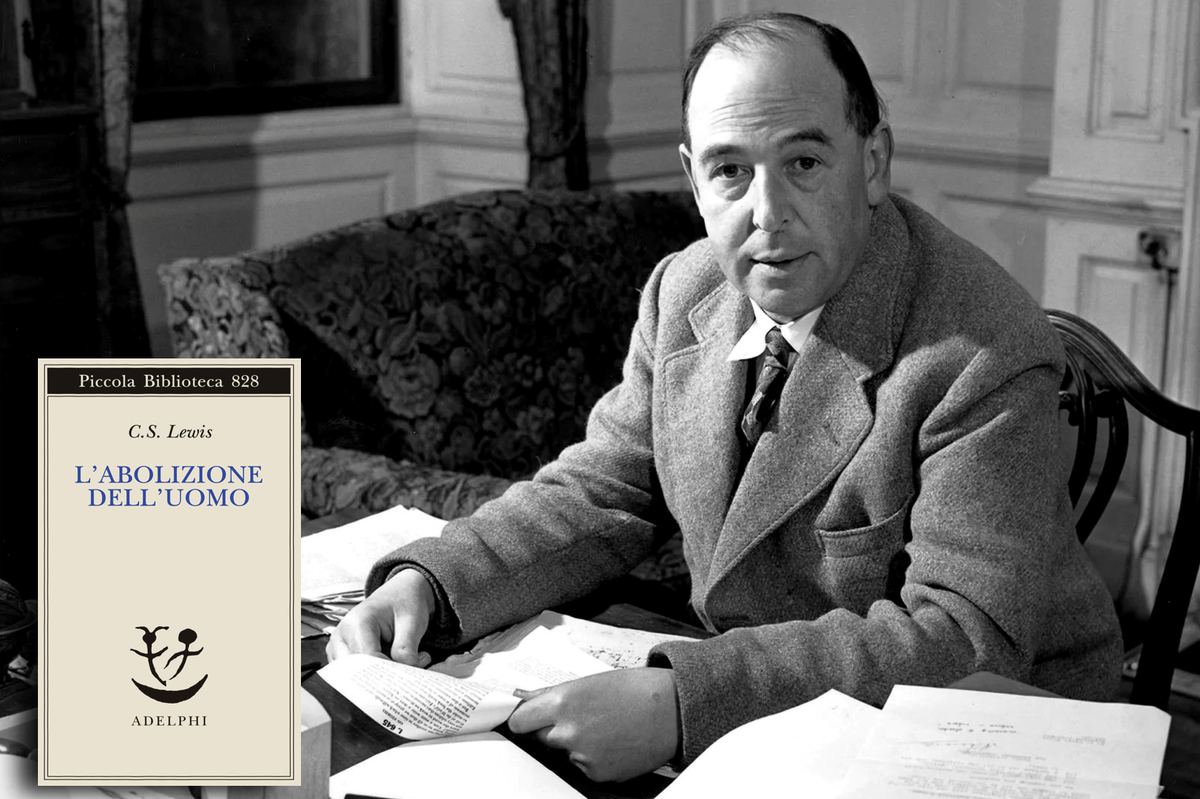«Domani compio quarant’anni», cantavano gli Squallor, «e la cambiale dei ricordi mi riporta al ’68 / Quando ero amico di Capanna / E avevo dato quattro esami con la media del 18» («Mi ha rovinato il ’68», album «Cielo duro»). Nella Milano di allora, e all’Università Cattolica, c’erano in effetti Mario Capanna «Domani compio quarant’anni», cantavano gli Squallor, «e la cambiale dei ricordi mi riporta al ’68 / Quando ero amico di Capanna / E avevo dato quattro esami con la media del 18» («Mi ha rovinato il ’68», album «Cielo duro»). Nella Milano di allora, e all’Università Cattolica, c’erano in effetti Mario Capannae don Luigi Giussani: a molti è toccato scegliere, e per alcuni non fu scontato. La storia racconta che quello fu un anno di crisi, per tutti e ovviamente anche per Gioventù studentesca, la sigla da cui sbozzò Comunione e liberazione dopo vari addii tra i giovani, diretti proprio verso il Movimento studentesco. Ma come avvenne?
Esce un libro che è - anche - un documento straordinario per iniziare a rispondere. «Una rivoluzione di sé» (Rizzoli, 17 euro, 290 pagine, a cura di Davide Prosperi) raccoglie per la prima volta le trascrizioni degli Esercizi spirituali del gruppo che, attorno al Centro culturale Charles Péguy, sarebbe diventato CL. La Verità ne anticipa i tratti salienti, per gentile concessione dell’editore.
Può sembrare strano, ma l’approccio del servo di Dio è laico. Parte da un impegno col vivere, dalla considerazione secondo cui «dovendo scegliere, uno che fa? Cerca di poggiare le sue energie su quello che più stima». Al cuore dei rapporti intorno a cui il prete brianzolo vede sorgere il Movimento, c’è un terreno sgombro dalla «impostazione politica», che sarebbe «in varia misura parziale». In una temperie in cui «tutto è politico» e sorgono i cosiddetti «preti del dissenso», Giussani viaggia nella direzione ostinata e contraria della fede. Pochi mesi dopo Valle Giulia, dice: «Viviamo in un’epoca dove l’ammirazione e la contemplazione sono raschiate via dalla sensibilità degli uomini, dall’animo degli uomini, come il senso della storia. Perciò profondità e gioia sono sradicate dall’animo della gente oggi, la storia e la contemplazione sono stupidamente opposte al presente o all’azione».
Il mondo crede di fare a pezzi per sempre l’autorità, e Giussani propone una comunione cristiana di gesti, di beni e di giudizio che ubbidisca a un’autorevolezza tesa alla conversione: «L’unica responsabilità è quella di aiutarci a incentivarci alla maturità cristiana, e basta». Il che coincide con il massimo di capacità di lettura dei «segni dei tempi» (il Concilio s’è chiuso da tre anni). Spiazzando una lettura «reazionaria» del fenomeno ciellino, il sacerdote di Desio spiega ai suoi: «La storia vive un momento in cui viene meno il senso della storia. […] Non può più essere né la storia, né la dottrina, né la tradizione, né il discorso a muovere l’uomo di oggi. Tradizione e filosofia cristiana, tradizione e discorso cristiano hanno creato e creano ancora la cristianità, non il cristianesimo. Il cristianesimo è ben altro, anche se comprende tutto questo. Fa sì che la tradizione sia realtà vivente. […] Il cristianesimo è un avvenimento. La cristianità sono forme articolate, ma il cristianesimo è un avvenimento».
forme da superare
La proposta cristiana necessita di una convenienza di vita documentabile: in questo Giussani valorizza l’urgenza di cambiamento e la ribellione al formalismo in cui i giovani vivono immersi («Finalmente è passato il tempo in cui il valore delle cose coincideva con la modalità con cui esse venivano comunicate»). Però indica la menzogna di un cambiamento che demandi alla politica, al progetto, all’idea, la felicità: «Ciò che tiene in piedi la vita cosciente in qualunque uomo è l’anelito, l’aspettativa, il desiderio, più o meno confessato, più o meno cosciente, di una salvezza». Sul tavolo cupo della cronaca Giussani sparge la poesia di un desiderio serio e profondo: «Salvezza vuol dire aspettare qualcosa di diverso da quello che siamo. Siamo fatti per un’altra cosa da quello che abbiamo in mano, siamo fatti per un’altra realtà da quella che adesso siamo». Ma il realismo impone di osservare che questa salvezza non è costruibile con mani umane: pensare il contrario è, per Giussani, l’origine del peccato. La pretesa umana di essere misura delle cose e dunque attori della propria salvezza è un’illusione che rende schiavi: «Forse il gioco amaro di questa pretesa alla nostra misura, il gioco amaro cui andiamo soggetti, questo amaro essere giocati, di cui neanche ci accorgiamo e che la Bibbia accusa, si capisce bene riflettendo un po’ sul paragone della Torre di Babele, cioè quello, in termini attuali, della pretesa dello scientismo o del socialismo di oggi. Tutti insieme siamo Dio, uniamoci, uniamo tutte le nostre forze e siamo Dio, mettiamo a posto il mondo. Dico che è una amarezza l’essere cosi banalmente giocati e non accorgerci che ciò significa: mettiamoci tutti insieme e “alcuni” di noi domineranno tutti noi e il mondo, attraverso noi come strumenti».
Ma il problema non è neppure tanto «perdere» sul piano numerico o sociopolitico (in quegli anni, è ciò che sta avvenendo); il rischio è non vedere che «se la giustizia si ottiene attraverso le nostre analisi e le nostre teorie, Cristo è morto invano». È infatti qui che Giussani sorprende la nascita della fede: riconoscimento di una umanità cambiata da Gesù morto e risorto, presente tra gli uomini, misterioso suscitatore di persone nuove perché in comunione dentro un luogo chiamato Chiesa: persone capaci di un giudizio diverso sul lavoro, sugli affetti, e certo anche sulla politica e sulla società, sul mondo. «Se manca il soggetto nuovo», scandirà anticipando l’ondata della secolarizzazione, compimento della modernità, «non sono cristiane neanche le cose più esteriormente battezzate del mondo».
Nella prosa appassionata e originalissima che diverrà suo tratto distintivo, Giussani di colpo piomba a terra. Questo cambiamento dell’io che la fede promette e suscita non è una chiacchiera, ma l’unico modo per prendersi sul serio e non giocare con la vita o col potere: «La logica della posizione contestataria o mondana è esattamente l’opposto: vogliono il cambiamento del mondo senza incominciare dalle loro mutande». Il superamento del ’68 è in fondo qui, e non in una contrapposizione ad esso: l’ideologia sempre indica un obiettivo e chiede sacrifici per ottenerlo, ma «di fronte al bisogno più radicale, quello da cui sprizzano tutte le azioni dell’uomo, il bisogno di vivere, tutte le ideologie si devono arrestare». La proposta di CL attende i ragazzi e gli adulti su questo limitare: «Non è sulle nostre forze di immaginazione, di pensiero, di dedizione, di sacrificio, di intelligenza e d’azione, che tutte le nostre azioni poggiano o poggeranno, ma è su un Altro, su un forte Amico che, dal profondo della storia di duemila anni fa, irresistibilmente viene, emerge dentro la nostra esistenza […] Non dobbiamo fare altro, amici miei, che ricuperare il tono cristiano, il contenuto e il tono cristiano nella sua originale nettezza».
l’autunno caldo
Nei primissimi giorni del novembre ’69, in pieno autunno caldo, Giussani tiene gli Esercizi spirituali del Centro Péguy a Riccione, e declina le conseguenze di tale nettezza nel rapporto tra Chiesa e mondo, secondo due fattori essenziali: l’essere nella comunione («Un avvenimento che prima dei nostri pensieri ci dà, ci offre un principio da cui si generano tutti i nostri giudizi») e il rimanere «dentro le esigenze, i bisogni dell’umanità, dell’uomo»: «Siamo tenuti a dire al mondo la Sua parola, ma continuamente tradotta secondo la mentalità, la capacità comprensiva, il linguaggio dell’epoca che viviamo. Il rapporto Chiesa-mondo e tutto, a mio avviso, riconducibile a questo rapporto fra la verità della nostra comunione cristiana e la lealtà cordiale, appassionata, con cui siamo dentro le esigenze e i bisogni dell’uomo».
Poco dopo, pone le condizioni di questa condivisione coi «fratelli uomini»: «è un orrore tragico e patetico - perché è nato o nasce magari da intenzioni terribilmente serie dal punto di vista morale - una collaborazione col mondo che non testimoni la diversità». È in queste lezioni che Giussani «battezza» Comunione e liberazione come «formula definitiva del nostro essere presenti nel mondo»: una presenza e una «diversità» che gli aderenti a CL avrebbero pagato con tentativi di eliminazione fisica nelle università nel decennio successivo.
Il fondatore di CL presentiva la violenza in arrivo? Possibile. Di certo non si mette nel recinto dei buoni. L’ultima delle lezioni raccolte nel volume a cura di Davide Prosperi, il professore milanese oggi guida del Movimento, è dedicata al male. Qui torna, ancora, sul peccato: mai qualcosa di cui accusare gli altri, ma l’«antitesi al mistero della libertà creata: il diavolo! Non per nulla», commenta, «è un termine che non si sente più predicare, perché mancano totalmente le categorie del fatto cristiano in tanta predicazione di oggi. Perché il mondo è il luogo geometrico di questo criterio d’antitesi a Dio. E il mondo ci ha investito, ci ha invaso: peccato originale».
Eppure, non è fosco l’ultimo orizzonte indicato in quegli anni da Giussani. Ciò che era Gs e diventa CL segue un sacerdote che, dentro i bagliori tenebrosi del ’68, è abilissimo a evitare di finire impacchettato in una corrente, ecclesiale o politica. A fondare le basi del Movimento, e in fondo a costituire la consegna più rilevante per chi lo vive oggi, è una «rivoluzione di sé» che insegue un bene cui tutti anelano: la consistenza delle cose, il senso dei giorni, la verità dell’affezione: cristianamente parlando, la salvezza. «Perché la salvezza, “la” salvezza, quella compiuta, quella in cui tutti saranno ricchi e carichi di una vista acuta, fin nelle più remote radici delle cose, e carichi d’un udito finissimo, per qualunque sfumatura di musica, della musica delle cose, e capaci di parlare come con la lingua degli angeli, e capaci di forza da trasportare le montagne e il mondo intero, questa salvezza ha il suo tempo, il tempo del Padre, che nessuno conosce. Ma a chi l’attende, già fin d’ora qualche barlume di quella fine, qualche anticipo di quel fine, l’eco di quel traguardo, di quel fondo delle cose, inizia a lievitare la vita, e uno sta meglio: “Chi mi segue avrà quella vita e il centuplo quaggiù”».