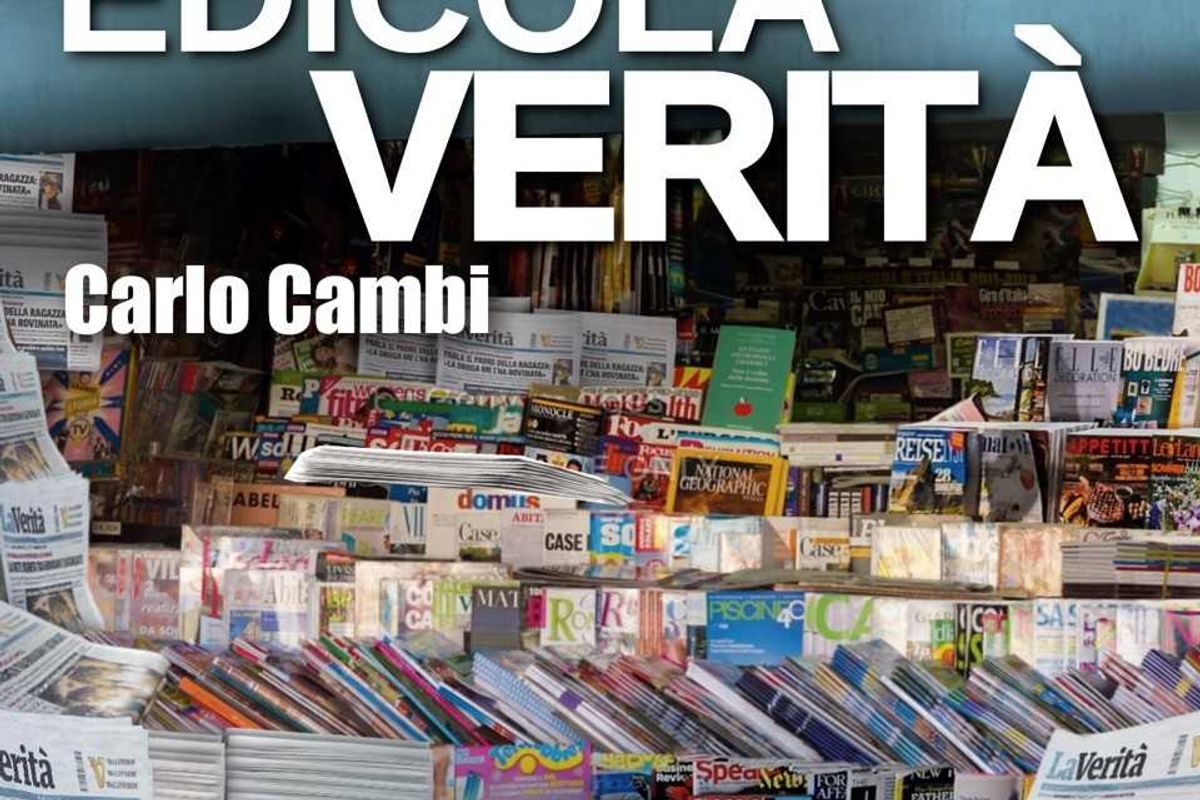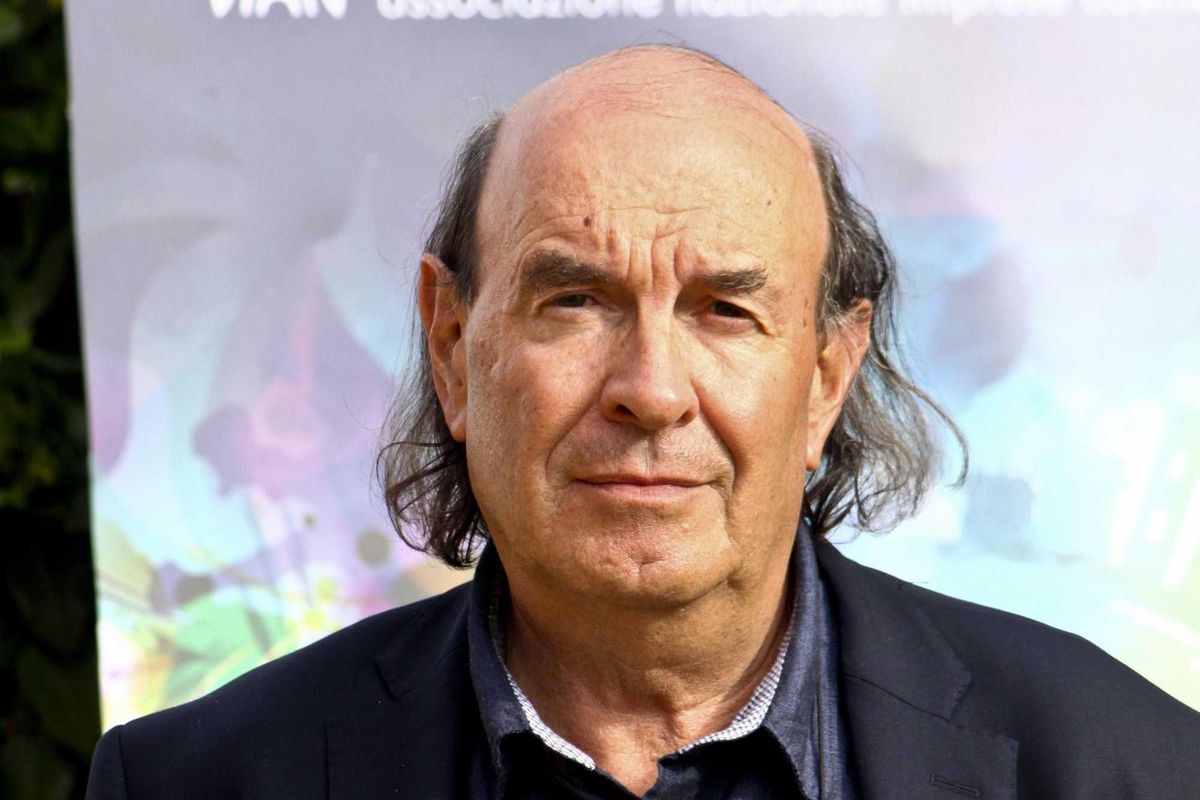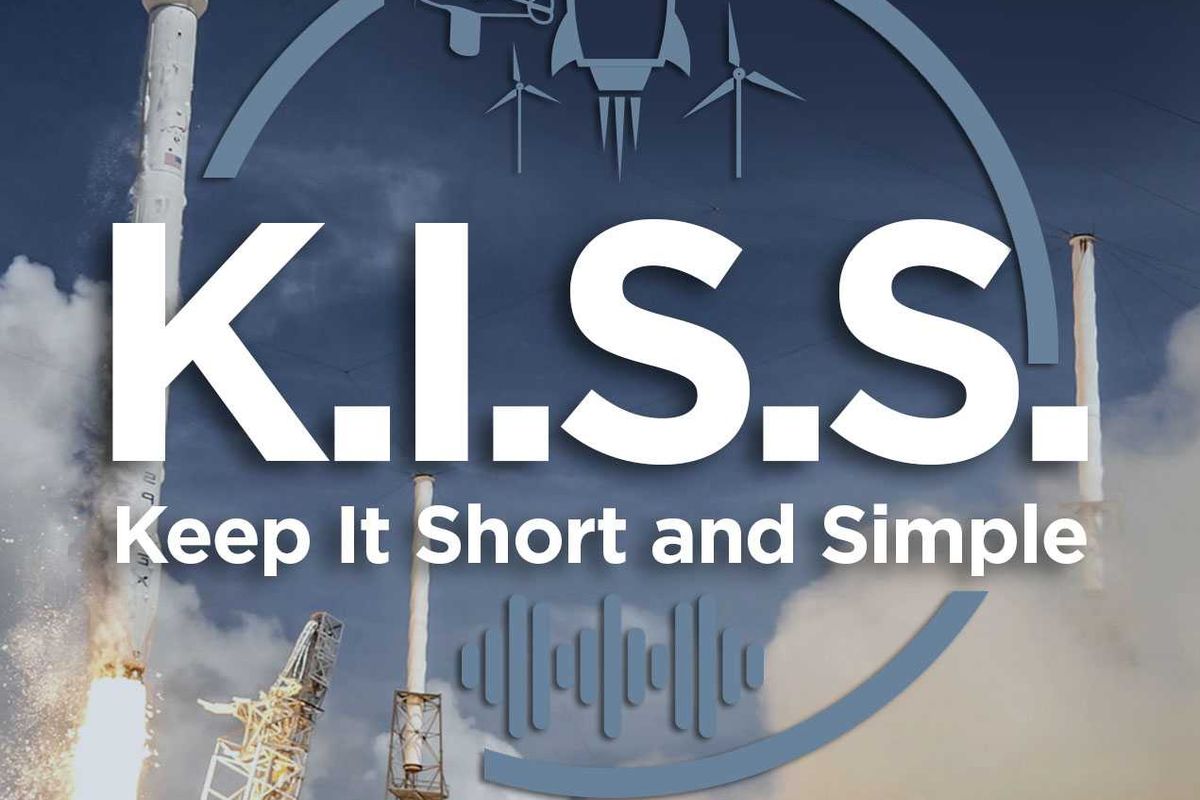I fatti. La procuratrice di Padova ha impugnato 33 atti di nascita relativi a bambini di coppie gay perché ha ritenuto che i sindaci siano andati al di là dei loro poteri regolati dalla legge. Ieri sulla Stampa la giudice della Cassazione Martina Flamini, dopo aver passato dieci anni al tribunale di Milano, nella sezione sui diritti fondamentali della persona, ha criticato palesemente l’operato della procuratrice di Padova entrando nel merito della questione.
Secondo me la questione fondamentale non è l’analisi del merito di quanto abbia detto la giudice della Cassazione - certamente esperta di diritti umani e quindi anche di diritti dei bambini -, si potrebbe arrivare anche a pronunciare un accordo su alcuni punti che ha elencato, il problema non sta qui, cioè nel merito, ma nella legittimità che una giudice di Cassazione, il tribunale dei tribunali, esprima, al di fuori del suo ambito naturale - cioè una sentenza della Corte di Cassazione -, un giudizio di merito sull’operato di un organo giurisdizionale come una Procura e, nel caso specifico, sull’operato di una procuratrice.
Tra l’altro è bene ricordare che in Italia la Corte Suprema di Cassazione, essendo al vertice della giurisdizione ordinaria, secondo la legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65), ha tra le funzioni fondamentali «L’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni». In altre parole, non giudica sul fatto accaduto, del quale si occupano la prima fase del processo e l’appello, ma è un giudice di legittimità: non riesamina le prove, cioè non entra nel merito del reato, bensì verifica che sia stata applicata correttamente la legge e che nei gradi precedenti il processo si sia svolto secondo le regole. In altre parole, le famiglie omogenitoriali ricorreranno, essendo una questione amministrativa, al Tar ed eventualmente al Consiglio di Stato e così potrà fare eventualmente il Comune. Molto difficile, se non impossibile, se la questione raggiunga la Cassazione. Ma questo è un particolare non rilevante ai fini del nostro ragionamento.
Il punto è che in un’ampia intervista di una giudice della Cassazione, non investita istituzionalmente del problema (e se lo fosse stata sarebbe anche più grave), non è opportuno che si pronunci su un provvedimento di una Procura inquanto l’opinione di un magistrato della Suprema Corte di Cassazione certamente può avere un effetto duplice, e negativo, su due soggetti. Il primo. È un soggetto della giurisdizione e cioè l’autonomia di giudizio della pm di Padova. Sicuramene la pm potrebbe essere anche influenzata da questo giudizio e non per debolezza o fragilità sua, ma dall’autorevolezza e l’autorità di chi ha espresso un giudizio negativo sul suo operato e cioè la giudice della Cassazione, tenendo conto anche delle sue pregresse mansioni presso il tribunale di Milano, e cioè i diritti dell’uomo che comprendono ovviamente, in questo caso, i diritti dei bambini oggetto di questo provvedimento. Il secondo. Questo pronunciamento proveniente dall’interno della Cassazione, pur non rispecchiando alcun parere della Cassazione stessa, potrà influire su una sfera che dovrebbe rimanere fortemente distinta e distante dalla magistratura e cioè il Parlamento, i partiti e il governo. Ma non finisce qui: potrebbe incidere sul dibattito pubblico e sull’opinione pubblica in modo inopportuno, fuori luogo, improprio, sconveniente e, alla fine, sbagliato. In altri termini, non è appropriato quello che la giudice ha fatto: non è il suo compito, non è il suo ruolo. È pur vero che l’articolo 21 della Costituzione sancisce «la libertà di manifestazione del pensiero», ma non significa un «liberi tutti di dire ciò che vogliono». Le funzioni, soprattutto pubbliche, impongono dei limiti a questa manifestazione del pensiero per la loro stessa natura e per il ruolo e le funzioni che svolgono.
In una conferenza svolta dal padre del diritto divile italiano, Piero Calamandrei, in Messico nel 1952, l’insigne giurista diceva: «La verità è che il giudice non è un meccanismo, non è una macchina calcolatrice, è un uomo vivo: e quella funzione di applicare la legge è in realtà un’operazione di sintesi che si compie a caldo, misteriosamente, nel crogiuolo sigillato dallo spirito, ove la saldatura tra la legge astratta e il fatto concreto ha bisogno, per compiersi, della intuizione del sentimento acceso in una coscienza operosa».
Ho citato Calamandrei non perché quanto scrive sia attinente in modo diretto a ciò che ho scritto precedentemente, ma per indicare un clima, un atteggiamento, un’attitudine del giudice che compie nel segreto della propria persona e che poi scrive in una sentenza. La delicatezza e la profondità delle parole di Calamandrei hanno un valore altissimo per un giusto comportamento dei giudici che dalla decisione passano alla sentenza, non passano - e non devono passare - dall’opinione alla divulgazione della stessa sulla stampa e sui media in generale.
Mi rendo conto che citare Calamandrei oggi, per questioni che concernono la giustizia, si mette in campo il pensiero di un autore, di un maestro del diritto che - visto come vanno le cose oggi in questo campo - potrebbe sembrare di parlare di un marziano sceso sulla Terra.