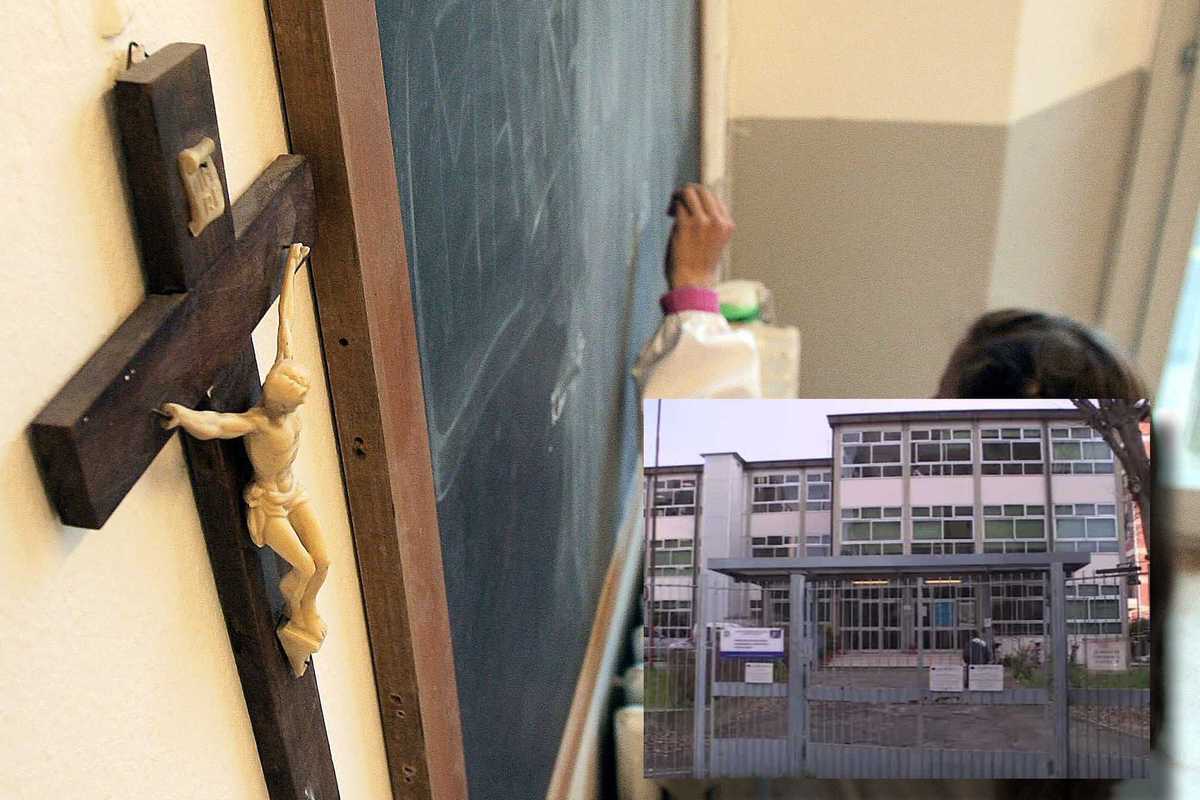La vittoria della rinuncia. Un gesto scolpito nella pietra angolare del tempo accompagna per sempre un grande Papa, tornato nel cuore dell’inverno alla casa del Padre. Joseph Ratzinger si è arreso all’eternità della polvere divina a 95 anni, sazio di giorni e di sofferenza. Aveva annunciato l’aggravarsi delle condizioni il suo successore Francesco, riservandogli una dolce carezza: «Benedetto è molto ammalato, nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa». Il Papa emerito aveva problemi respiratori da tempo, aggravatisi nei giorni precedenti il Natale. Secondo la sala stampa vaticana «l’aggravamento era dovuto all’avanzare dell’età».
Sembra strano, ma è una delle frasi chiave dell’intero pontificato. «Ingravescente aetate». L’ablativo più assoluto della storia della Chiesa, «per l’età che avanza». Le due parole che aleggiavano nel breve discorso d’addio pronunciato in latino l’11 febbraio 2013 continuano a racchiudere il mistero più grande, quello della rinuncia. Sintetizzata con un’immagine dal prepotente impatto emotivo: una sedia dorata imbottita di porpora improvvisamente vuota e, di spalle, non un principe ma un uomo ingobbito dal peso degli anni che si allontana avvolto nella veste bianca. È la resa di Ratzinger che davanti a Dio si era imposto il nome di Benedetto XVI. Ma quella foto che tutti al mondo abbiamo visto e tutti abbiamo pubblicato aveva un altro significato. Ce lo spiegò un giorno a Bergamo un prete di strada, di quelli che trascorrono le notti con gli ultimi: «È sbagliata perché trasmette tristezza, e invece lui è sereno. È sbagliata perché trasmette la sconfitta, e invece lui ha vinto».
La vittoria della rinuncia, quella del passo indietro che fa rumore e induce a riflettere. Per compiere un simile gesto ci vuole coraggio e ci vuole il salvagente della dottrina; solo sette volte era successo prima. Anche chi riteneva che Ratzinger fosse solo un pastore tedesco della fede (era il bersaglio preferito dell’ateo ridens, dal Manifesto a Charlie hebdo) ha cominciato a capire qualcosa della profondità e della determinazione di uno dei più importanti papi della modernità. Perché si alzò dal soglio di Pietro e se ne andò? Si è parlato di un tormento interiore, dell’avversione sfinente per gli intrighi vaticani da parte di un uomo schivo e profondamente umile, più avvezzo ai libri di teologia che agli affari di Stato, più incline a confrontarsi con le pagine di San Tommaso che a tenere a bada i dossier pronti per Vatileaks. E poi la solitudine, quel senso di impotenza che ti travolge quando davanti a te non hai più collaboratori, ma solo astanti che aspettano.
Lui quell’uscita di scena l’aveva spiegata così nel libro-intervista Ultime conversazioni con il suo biografo Peter Seewald: «Il governo pratico non è il mio forte e questa è certo una debolezza. Ma non riesco a vedermi come un fallito. Francesco è l’uomo della riforma pratica e ha anche l’animo per mettere mano ad azioni di carattere organizzativo. Non si è trattato di una ritirata sotto la pressione degli eventi o di una fuga per l’incapacità di farvi fronte. Nessuno ha cercato di ricattarmi. Non l’avrei nemmeno permesso. Se avessero provato a farlo non me ne sarei andato perché non bisogna lasciare quando si è sotto pressione. E non è nemmeno vero che ero deluso o cose simili. Anzi, grazie a Dio, ero nello stato d’animo pacifico di chi ha superato la difficoltà. Lo stato d’animo in cui si può passare tranquillamente il timone a chi viene dopo».
Non si giudica un Papa dalle scarpe che porta. Nei suoi gesti misurati, nel suo incedere felpato, Benedetto XVI ha caratterizzato un papato sobrio e riflessivo che può essere riassunto con una frase di Vaclav Havel: «La diffidenza verso le parole è meno dannosa dell’eccessiva fiducia per le stesse». Parlare tutti i giorni non significa necessariamente dire qualcosa. Ratzinger ha parlato poco, ma quando lo ha fatto ha scolpito i suoi concetti nella pietra. Nel 2006, nel mezzo di un viaggio nella memoria dei padri, all’Università di Ratisbona (Regensburg, praticamente Monaco di Baviera) dove aveva insegnato, in un memorabile discorso è stato il primo ad avvertire il mondo della deriva violenta della cultura islamica.
Gli attentati di Parigi, Bruxelles, Barcellona, Dacca, Nizza, Berlino, Tunisi, Sousse hanno avuto in lui una Cassandra disperata. Attraverso le parole antiche di Michele II Paleologo, criticò la direttiva di Maometto «di diffondere per mezzo della spada la fede. Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. Dio non si compiace del sangue. La fede è frutto dell’anima, non del corpo. Chi quindi vuole condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene e di ragionare correttamente, non invece della violenza e della minaccia». Il mondo laico e progressista lo attaccò, lo fecero passare per un matto teocon fermo a Lepanto sulla tolda della Galera Real. In un editoriale il New York Times, travolto da una certa isteria, gli chiese di scusarsi con i musulmani. La libertà di espressione - tra l’altro declinata con profetica saggezza - sembrava riguardare tutti, non il Papa.
Da quel momento il suo percorso è stato disseminato di ostacoli e di trappole per i quasi otto anni di pontificato. E utilizzando la più banale delle proprietà transitive, la sinistra che sfodera la penna ventilò che quel tedesco durante il nazismo era stato un soldato della Wermacht. In realtà il padre, commissario di polizia, non si allineò mai al pensiero dominante e per questo dovette più volte trasferirsi con la famiglia. Joseph toccò con mano la crudeltà del regime: nel 1941 un cugino con la sindrome di Down fu portato via per «un periodo di terapia» e non fece più ritorno a casa. Era stato sottoposto al programma di eutanasia dei portatori di handicap. Il futuro papa fu aggregato per un breve periodo a un reparto antiaereo a difesa degli stabilimenti Bmw di Monaco. Fece qualche guardia, qualche marcia, poi disertò rischiando la fucilazione. Per lui il Reich era in conflitto con la fede. Nonostante ciò, i detrattori di professione gli inventarono un saluto nazista tagliando ad arte una fotografia in cui stava praticando l’imposizione delle mani per invocare lo Spirito Santo. Insomma, un uso becero dell’informazione che lui sopportava con spirito di sacrificio. Anticipava i grandi temi, ne coglieva gli aspetti critici, sembrava avere un sesto senso nel comprendere l’evoluzione della società.
Più volte mise in guardia il gregge dai pericoli del modernismo a tutti i costi, della tecnocrazia che confonde i valori dell’uomo, del laicismo indiscriminato. «Quando vengono create nuove forme giuridiche che relativizzano il matrimonio» sosteneva Benedetto XVI «la rinuncia al legame definitivo ottiene anche un sigillo giuridico. In tal caso il decidersi, per chi già fa fatica, diventa ancora più difficile. Si aggiunge poi, per l’altra forma di coppie, la relativizzazione della differenza dei sessi. Diventa così uguale il mettersi insieme di un uomo e una donna o di due persone dello stesso sesso». Era il 2006, sembra oggi. Ma anche i cattolici lo ascoltavano con un orecchio solo.
L’umile servo nella vigna del Signore era un gigante del pensiero che vergognosamente non fu fatto entrare alla Sapienza per parlare agli studenti, macchia indelebile per l’ateneo. Durante il pontificato cominciò a chiedere trasparenza e rigore alla Curia. Come avrebbe chiosato Charles De Gaulle, vaste programme. Così, aderendo al vezzo di andare a riesumare parole dimenticate nell’antiquariato della lingua e in piena sintonia con il cardinal Carlo Maria Martini, invocò la «parresìa» esattamente come papa Francesco oggi invoca la resilienza. Molti preti dovettero cercarne il significato sullo Zingarelli anche perché, oltre a non conoscerla, difficilmente la praticavano. Schiettezza, franchezza, dire la verità. La libertà di chiamare le cose con il loro nome. Cominciava quella battaglia contro l’ipocrisia, contro il non detto, contro le penombre degli apparati che lo avrebbe sfinito. Chiedeva pulizia, si ritrovò circondato dall’omertà, dagli scandali a sfondo sessuale e dai dossier anonimi. Allora capì che non sarebbe bastato spiegare e convincere con il ragionamento; bisognava urlare e lui non ne era capace.
Colui che ci ha lasciato due volte (la prima sull’elicottero bianco il 28 febbraio 2013, la seconda due giorni fa), è stato il difensore d’una Chiesa dai principi saldi, in grado di dialogare senza indietreggiare con un mondo in piena deriva relativista, perfino nichilista. E di accompagnare il viandante sulla strada dell’eternità. Una Chiesa molto differente da quella dai principi più fluidi, scandita dagli annunci, dalle posizioni cangianti, dall’interventismo dialettico sui temi più disparati che è la cifra del pontificato di Jorge Bergoglio. Una Chiesa applaudita per interesse anche dall’ateo ridens e dai nemici di sempre.
Memorabile fu il discorso nell’ultima udienza generale in piazza San Pietro prima di diventare Papa emerito. «Il Signore ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza leggera, giorni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono stati anche momenti in cui le acque erano agitate e il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre saputo che in quella barca c’è Lui e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è Sua. Il Signore non la lascia affondare».
La necessità di approfondire, la capacità di distinguere; Joseph Ratzinger ci ha insegnato la fede che libera. C’è tutto nel suo libro preferito dopo il Vangelo: Notte inquieta di Albrecht Goes, tedesco come lui, che prima di lasciare il sacerdozio fu teologo e libero pensatore, ma soprattutto cappellano militare durante la Seconda guerra mondiale. Nel racconto, ad attendere due piccoli uomini in fondo alle tenebre ci sono la contraerea di Stalingrado e un plotone di esecuzione. Ma nella notte inquieta Dio renderà loro giustizia. Quell’uomo curvo e vestito di bianco che cominciò ad andarsene nove anni fa ha amato il suo popolo mantenendo la barca sulla rotta. Per questo ha vinto.