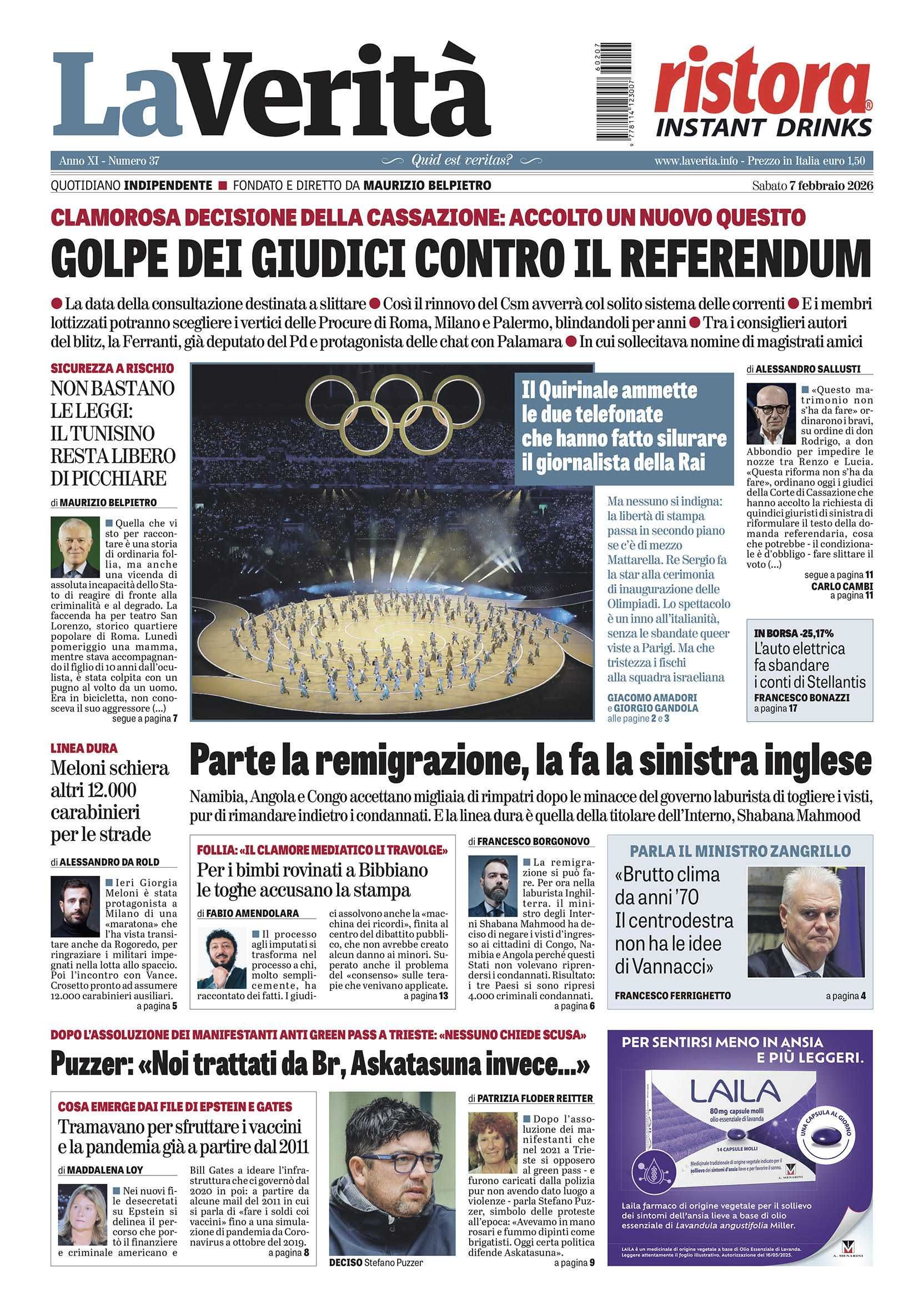- Su «Time» lo sconforto del presidente: «Impossibile dirgli che Kiev sta perdendo». Ma ora lo ammette pure il capo dell’esercito. Mosca accusa Giorgia Meloni dopo lo scherzo telefonico: «Glorifica i fascisti ucraini». I comici la elogiano: «Una donna piena di emozioni».
- Stop al trattato del 1996 per la messa al bando degli esperimenti nucleari, mai ratificato dall’America. Che prepara una nuova bomba.
Lo speciale contiene due articoli.
Il «dolcetto o scherzetto» a scoppio ritardato continua a far parlare il mondo politico e apre due scenari, uno folcloristico e l’altro di sostanza strategica: la vulnerabilità telefonica di Palazzo Chigi e l’effettiva stanchezza del mondo occidentale nei confronti della guerra in Ucraina. Sull’intervista rubata a Giorgia Meloni da parte dei comici russi Vovan e Lexus (i Ficarra e Picone della steppa) ieri è intervenuto Alfredo Mantovano per dire che «il presidente del Consiglio l’aveva capito subito» che trattavasi di scherzo. Subito? «E certo». Niente di più da parte del sottosegretario alla presidenza, neppure sui 44 giorni in cui la conversazione è rimasta a frollare dentro un registratore digitale senza un annuncio preventivo a disinnescare il petardo.
La vicenda ha creato il consueto temporale nell’opposizione, indignata perché due sconosciuti hanno potuto parlare con la premier spacciandosi per Moussa Faki (numero uno della commissione dell’Unione africana), esattamente com’è accaduto a Recep Tayyip Erdogan e Boris Johnson. E ha messo di cattivo umore anche qualche alleato in maggioranza, come il ministro degli Esteri Antonio Tajani che sottolinea: «C’è stata superficialità in chi ha organizzato la telefonata, e questo non deve più accadere». Sulla sceneggiata Lilli Gruber ha imbastito l’immancabile puntata di Otto e mezzo con Aleksei Stolyarov, uno dei comici felice del bagno di popolarità italiana. Restio a rivelare i dettagli dell’impresa, ha ricordato di aver già gabbato Jens Stoltenberg e Federica Mogherini. A Fanpage, lo stesso Lexus aveva spiegato: «La nostra arma, anche con Meloni, è stata la vanità dei vostri politici». Col premier, però, si è instaurata una certa «empatia. Aveva voglia di parlare, di confrontarsi. Di chiedere oltre che dichiarare. Una persona piena di emozioni. Cosa non comune, quando giochiamo con personaggi di spicco della politica». Nessun attrito governativo sui contenuti della conversazione con i due burloni, visto che Meloni ha descritto con trasparenza uno scenario realistico della situazione. Lo stesso Tajani commenta: «Le sue parole sono un chiaro segnale di conferma della linea politica del nostro Paese. Noi siamo dalla parte dell’Ucraina». Sintesi: se la chiamata era finta, le risposte erano vere e coerenti. Proprio le frasi della premier («C’è molta stanchezza da tutte le parti», «Serve una via d’uscita accettabile senza distruggere la legge internazionale») portano alla luce il tema chiave del momento: nessuno sembra più disposto a svenarsi per Kiev.
A cominciare dagli Stati Uniti, dove il consenso per l’invio delle armi agli ucraini è sceso dal 65% al 41% (sondaggio Reuters). Meloni ha messo il dito nella piaga e il primo a capire che il vento sta cambiando è proprio Volodymyr Zelensky che alla rivista americana Time ha detto: «Nessuno crede più alla nostra vittoria come ci credo io. Nessuno». Il magazine descrive il presidente come «sconfortato perché l’appoggio occidentale vacilla», «non fa più battute per stemperare la tensione nelle riunioni operative», «in lui è sparito l’ottimismo di sempre». A raccontarlo è Simon Shuster, inviato che 20 mesi fa dipinse dal palazzo presidenziale di Kiev il leader in mimetica come un nuovo Winston Churchill e oggi lo vede assediato e triste, praticamente nel bunker in preda ai fantasmi. Poco considerato dagli alleati distratti, mentre la guerra si è impantanata di nuovo nell’inverno napoleonico. Lo scenario è cambiato, la controffensiva langue, sembra passato un secolo dal treno con Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi (in Occidente le foto iconiche un tanto al chilo spopolano sempre). E i tank russi non si muovono di lì.
Time scrive che Zelensky «è depresso, arrabbiato con gli alleati perché si sente tradito». Citando un consigliere, Shuster scrive che «Zelensky ha una convinzione messianica nella vittoria, si illude. Non stiamo vincendo ma dirglielo è impossibile». Se la situazione psicologica è questa, la «stanchezza di tutti» evocata da Giorgia Meloni è realistica. Lo stesso Zelensky ammette: «La cosa più spaventosa è che una parte del mondo si è abituata alla guerra in Ucraina. La stanchezza scorre come un’onda, la vedi negli Stati Uniti e in Europa. E vediamo che non appena iniziano a stancarsi un po’, diventa come uno spettacolo». Lui di teatro se ne intende e chiude stancamente: «Come se dicessero tutti assieme, non posso guardare questa replica per la decima volta».
Il reportage è crepuscolare e illuminante, tocca con mano una realtà confermata dall’andamento della guerra stessa. Valery Zaluzhny, comandante in capo delle forze ucraine, ha rivelato all’Economist che «il conflitto sta diventando una guerra di posizione, di combattimento statico e di logoramento come accadde nella prima guerra mondiale. Niente più movimento e velocità. Ciò andrà a beneficio della Russia, permettendole di ricostruire la sua potenza militare, minacciando infine le forze armate ucraine e lo Stato stesso».
Mentre dalle parti di Kiev si parla di guerra vera, a Mosca continua quella della propaganda. E le parole di Giorgia Meloni («Gli ucraini stanno facendo ciò che devono e noi li stiamo aiutando»), distorte secondo le vecchie regole del Kgb, diventano un tema di polemica spicciola. Maria Zahkarova, portavoce del ministero degli Esteri, critica la premier italiana per non aver condannato il nazionalismo ucraino. «Sarebbe pronta a glorificare Achille Starace o Alessandro Pavolini?», si domanda Zahkarova con un’invettiva fuori contesto e fuori dal tempo. Dimentica il recente abbraccio del Cremlino ad Hamas. E curiosamente tralascia di ricordare che la punta di diamante dell’esercito russo era la brigata Wagner. Chiamata così non certo perché composta da amanti di lirica.
Putin rispolvera la minaccia atomica. Cancellato il divieto di test nucleari
Nel momento in cui l’asse del conflitto globale si è spostato dall’Ucraina alla Striscia di Gaza, Vladimir Putin torna a far discutere e a mettere paura all’Occidente. Ieri, infatti, lo zar ha firmato il decreto di uscita della Russia dal Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (Ctbt). Non si tratta, peraltro, di un fulmine a ciel sereno: già a fine ottobre la Duma, la Camera bassa, aveva annunciato la ratifica della decisione presa dal Cremlino.
Il trattato Ctbt, che ha avuto una gestazione di tre anni nell’ambito della Conferenza del disarmo, era stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996. Tuttavia, non è mai entrato in vigore. Il motivo? Molte nazioni non lo hanno ratificato, rendendo impossibile raggiungere il quorum previsto dal trattato stesso. Tra i Paesi che hanno firmato l’accordo senza ratificarlo, ci sono anche gli Stati Uniti d’America (la Russia, al contrario, lo ha sia firmato che ratificato). Non a caso, sono stati proprio i tentennamenti di Washington che hanno spinto Putin ad abbandonare il trattato.
Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, ha dichiarato che la decisione è «la chiara risposta a un atteggiamento odioso da parte degli Stati Uniti» per quel che riguarda la sicurezza globale. Putin, però, ha voluto far intendere che il provvedimento di Mosca non avrà effetti immediati: «Non posso dire ora se riprenderemo i test», ha affermato lo zar a proposito dello sviluppo di progetti su nuovi missili in grado di trasportare testate nucleari. In ogni caso, è da specificare che la dottrina russa prevede che l’uso di armi atomiche sia «strettamente difensivo». In sostanza, solo in caso di attacco alla Russia con armi di distruzione di massa o, in alternativa, in presenza di aggressioni con armi convenzionali «che minacciano l’esistenza stessa dello Stato».
Con questa mossa del Cremlino, quindi, proseguono le tensioni tra Russia e Stati Uniti, che si sono acuite con l’invasione dell’Ucraina. Sempre in tema di armi nucleari, del resto, lo scorso febbraio Putin aveva annunciato la sospensione del trattato Start (Strategic arms reduction treaty), siglato per la prima volta nel 1991, al termine della guerra fredda, e poi rivisto nel 2010 (nella versione cosiddetta New Start). Questo accordo bilaterale prevedeva una riduzione del 60% nel numero di testate nucleari in dotazione a Stati Uniti e Federazione russa (che da sole posseggono il 90% delle armi nucleari a livello mondiale). La decisione dello zar si era resa necessaria a causa delle reciproche ispezioni previste dal trattato. Un’eventualità (ispettori statunitensi in visita in Russia) che, in tempo di guerra in Ucraina, Putin aveva definito «assurda».
Se Mosca si riarma, anche Washington non è da meno. Solo pochi giorni fa, in effetti, il Dipartimento della difesa americano (Dod) ha annunciato di voler far approvare al Congresso la produzione di una nuova bomba nucleare. Si tratta, nello specifico, della B61-13. Un ordigno che avrà la potenza di 350 chilotoni: in pratica, sarà 24 volte più devastante di «Little Boy», la bomba che fu sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945, la quale conteneva circa 15 chilotoni. In proposito, il presidente del Comitato per le forze armate della Camera, Mike Rogers, e il senatore Roger Wicker hanno affermato che «Cina e Russia si stanno riarmando e gli Stati Uniti devono rimanere al passo. Per affrontare questa minaccia, è necessaria una trasformazione radicale del nostro atteggiamento deterrente».