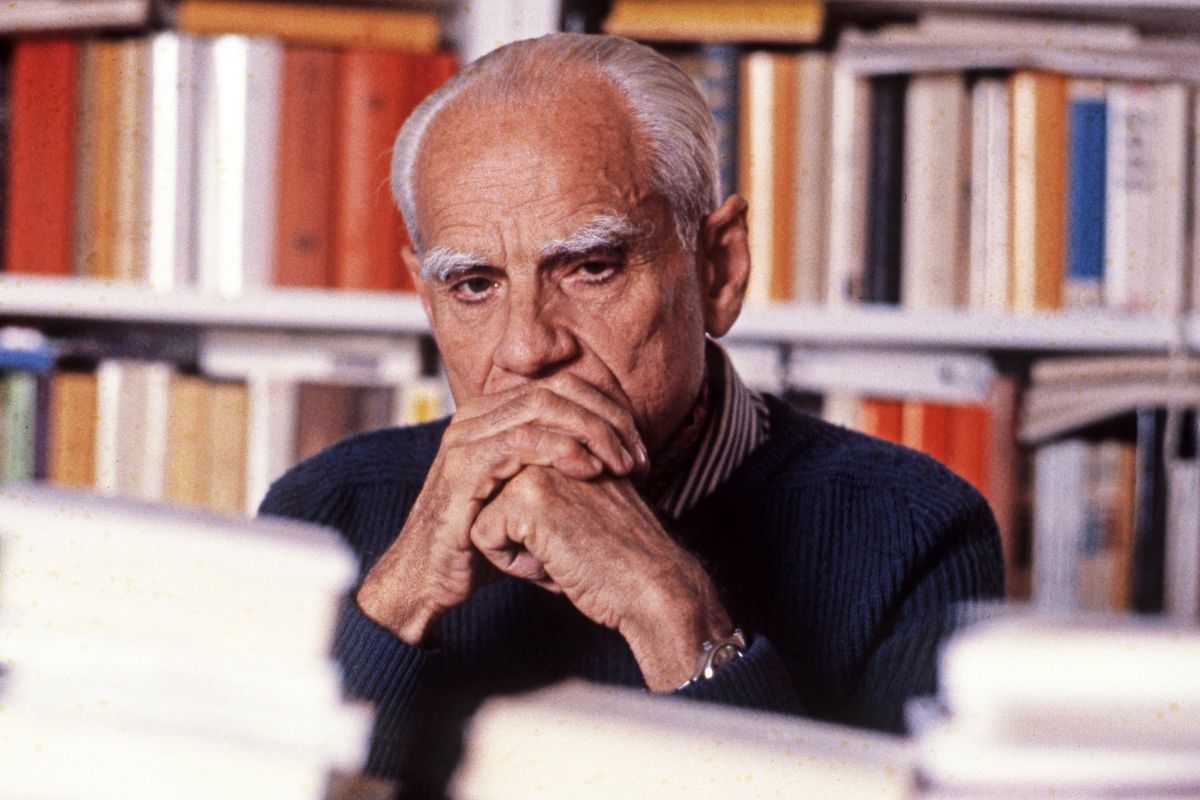True
2025-02-10
Senza trascendenza il mondo perde senso. Così ogni azione diventa indifferente
Alberto Moravia (Getty Images)
È il 1925 quando Alberto Moravia, nemmeno diciottenne, inizia a scrivere Gli Indifferenti, completato nel 1929. Opera d’esordio e caso letterario, negli anni ispirerà film e infinite interpretazioni. Particolarmente efficace fu la lettura che ne diede a caldo Benito Mussolini: «Un romanzo oscenamente borghese e antiborghese al medesimo tempo». E in effetti borghese e antiborghese era Moravia: più che benestante, parente di alti papaveri fascisti e al contempo di grossi nomi dell’antifascismo, egli sentiva sulla pelle l’appartenenza al tinello buono romano e, insieme, la dolorosa alienazione che quell’ambiente gli provocava.
Un senso di ansia e di soffocamento si respira fin dalle prime pagine, da cui trasuda l’atroce ipocrisia in cui i protagonisti sono immersi. C’è Leo Merumeci, affarista senza scrupoli, uomo senza valori determinato a soddisfare i propri bisogni incurante delle conseguenze. È l’amante di Mariagrazia, drammatica figura di donna borghese sospesa sul baratro della rovina, indebitata e dunque sotto ricatto dello stesso Merumeci, pateticamente appesa a consuetudini e apparenze che si sgretolano. Poi i figli ventenni di lei: Carla e Michele Ardengo. Il secondo detesta Merumeci, la condizione in cui ha costretto sua madre, l’impotenza in cui tutta la famiglia è relegata. Ma è incapace di una vera reazione. La prima, Carla, è nauseata dallo scorrere piatto dei giorni, dall’idea che nulla possa cambiare in meglio nella sua esistenza. Così rassegnata dall’abbandonarsi alla libidine di Merumeci, che va a letto con Mariagrazia ma comunque ne concupisce la figlia. Un quadro nel complesso spaventoso, una sorta di ritratto funebre di una generazione la cui caratteristica è appunto l’indifferenza: la morale è assente, la prospettiva di un cambiamento non esiste, l’intera quotidianità è cristallizzata, bloccata ed esangue. Ma ai personaggi non sembra importare: si fanno vivere, trascinare.
Ed è esattamente qui che sta la potenza (e con essa l’attualità) del romanzo. Gli Indifferenti va letto in parallelo alla Noia, che Moravia darà alle stampe nel 1960, e pure a Il conformista, del 1951. Perché ovunque prevale una sorta di inabilità dei protagonisti, una incapacità di prendere posizione rispetto alla vita, un tremendo senso di inutilità e insensatezza. L’indifferente, annoiato, si conforma. Siamo, con tutta evidenza, nell'universo della melanconia a cui Jean Paul Sartre dedicherà il capolavoro La Nausea (inizialmente intitolato appunto Melancholia). Non si tratta di tristezza e nemmeno di semplice rassegnazione, bensì propriamente di accidia, perdita di forza e iniziativa. «Per molti la noia è il contrario del divertimento; e divertimento è distrazione, dimenticanza», scrive Moravia nel prologo de La Noia. «Per me, invece, la noia non è il contrario del divertimento; potrei dire, anzi, addirittura, che per certi aspetti essa rassomiglia al divertimento in quanto, appunto, provoca distrazione e dimenticanza, sia pure di un genere molto particolare. La noia, per me, è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. Per adoperare una metafora, la realtà, quando mi annoio, mi ha sempre fatto l’effetto sconcertante che fa una coperta troppo corta, ad un dormiente, in una notte d’inverno: la tira sui piedi e ha freddo al petto, la tira sul petto e ha freddo ai piedi; e così non riesce mai a prender sonno veramente. Oppure, altro paragone, la mia noia rassomiglia all’interruzione frequente e misteriosa della corrente elettrica in una casa: un momento tutto è chiaro ed evidente, qui sono le poltrone, lì i divani, più in là gli armadi, le consolle, i quadri, i tendaggi, i tappeti, le finestre, le porte; un momento dopo non c’è più che buio e vuoto. Oppure, terzo paragone, la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina; come a vedere in pochi secondi, per trasformazioni successive e rapidissime, un fiore passare dal boccio all’appassimento e alla polvere. Il sentimento della noia nasce in me da quello dell’assurdità di una realtà, come ho detto, insufficiente ossia incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza».
Ecco la descrizione di una malattia dell’anima che è anche la nostra, e forse quella dell’intera modernità, come già Charles Baudelaire aveva intuito e come Byung-chul Han ribadisce nei suoi scritti attorno alla società della stanchezza. Come per i personaggi di Moravia le cose stesse perdono consistenza, così per noi, dice Han, le cose si fanno «non cose»: «Ogni cosa svanisce, si disfa pian piano. Scompaiono anche le parti del corpo, e alla fine restano solo voci incorporee, vagabonde, senza meta. [...] Oggi il mondo si svuota riducendosi a informazioni spettrali quanto quelle voci incorporee. La digitalizzazione derealizza, disincarna il mondo». Potremmo dire che la realtà ridotta ad artificio del digitale sia il compimento dello svuotamento iniziato con la modernità, l’apice della melanconia che rapisce i personaggi di Moravia quanto i nostri contemporanei.
È la stessa melanconia di cui parla il filosofo Paolo Godani nel recentissimo Melanconia e fine del mondo (Feltrinelli). Una condizione «che si definisce per il sentimento della radicale insensatezza del mondo e della vita, per il senso di colpa altrettanto radicale che ne consegue e per la prostrazione e l’inibizione all’azione che ne costituiscono l’inevitabile corollario. E si è visto sino a che punto il melanconico condivida, e insieme contesti, la struttura metafisica che è a tutti gli effetti quella dominante nella nostra cultura. Questa struttura melanconica implica l’esigenza etica di trascendere l’insensatezza del mondo sottoponendo quest’ultimo all’effetto di una legge, di un valore, di una forma, ma in tal modo conferma nella maniera più decisa possibile che in effetti questo mondo, lasciato a sé stesso, è del tutto insensato. Il melanconico non fa che tenersi a questa conferma, abbandonando l’illusione di ogni fede e di ogni trascendimento. Sarà una sorta di nichilista passivo».
L’indifferenza di Moravia è dunque insieme causa e sintomo. L’indifferenza a ogni sistema valoriale, l’estraneità percepita rispetto a ogni ordine trascendente producono alienazione dalla vita, uccidono il desiderio di andare oltre, di costruire qualcosa di nuovo e migliore, provare un sentimento che non sia pura rassegnazione. La speranza, in questo ordine mondiale, non ha cittadinanza. Perché agire, perché spendersi, perché sacrificarsi se non esistono ideali sensati, se ogni cosa è priva di realtà, se tutto è destinato a rimanere identico a sé stesso? Lo spegnimento di cui tratta Moravia è il nostro: una paralisi angosciata, un panico paralizzante che si manifesta come disinteresse, esaurimento delle passioni creative, persino dell’eros. Gli Indifferenti siamo noi, ancora.
Dalla società dell’angoscia non ci salverà la scienza
P. D. James ci rese partecipi del suo incubo nel 1992, dando alle stampe I figli degli uomini. Il romanzo è ambientato nel 2021, subito dopo la morte dell’ultimo essere umano nato sulla terra. Un ragazzo di venticinque anni ucciso in una rissa. Con lui si spegne l’ultimo barlume di vitalità di un pianeta su cui, da un quarto di secolo, non nasce più nessuno. Theodore Faron, professore di Storia a Oxford e voce narrante, rovescia in un diario il suo sconforto: «L’incombente estinzione della nostra specie e l’impossibilità di evitarla ci offendono e demoralizzano meno della nostra incapacità di scoprirne la causa», scrive. «La scienza e la medicina occidentali non ci hanno preparati all’enormità e all’umiliazione di questo smacco. Vi sono state malattie difficili sia da diagnosticare sia da curare, una delle quali ha quasi spopolato due continenti prima di essere debellata, ma alla fine siamo sempre riusciti a spiegarne le cause. Abbiamo dato un nome ai virus e ai germi che tuttora ci affliggono, con grande mortificazione da parte nostra, dal momento che sembra un affronto personale che ci debbano colpire ancora oggi, come antichi nemici che tengono viva la battaglia e di tanto in tanto uccidono anche quando la loro vittoria è ormai assicurata. La scienza occidentale è stata il nostro dio. [...] La scienza non è mai stata il mio pane: ne capivo poco a scuola e continuo a capirne poco adesso che ho cinquant’anni. Ma è stata un dio anche per me, che pure non ne ho mai compreso appieno le conquiste, e provo anch’io la disillusione universale di chi assiste alla morte del proprio dio». Il potere della tecnica non basta a scongiurare la catastrofe, ad arrestare l’interminabile e mortifero inverno demografico.
Secondo il filosofo Byung-chul Han, il racconto della James e il film che ne ha tratto nel 2006 Alfonso Cuarón fornisce una fondamentale chiave di lettura del presente. «I figli degli uomini», spiega, «ci restituisce una rappresentazione della società odierna dominata dalla depressione e diventata completamente priva di speranza. Nella pellicola l’umanità procede verso la propria fine e rischia l’estinzione. [...]. Se le parole della buona novella contenute nell’omelia di Natale: “un bambino è nato per noi” annunciano la speranza, allora la sterilità dell’umanità rappresenta l’assoluta mancanza di ogni speranza».
Secondo Han, «ne I figli degli uomini l’umanità cade in una depressione collettiva. L’esperienza della nascita, che vale come sinonimo del futuro e che dovrebbe portare con sé il nuovo, non si verifica più. A essere completamente annullato è il venire-al-mondo inteso come nascita. Il mondo si identifica con l’inferno dell’Uguale. La depressione priva l’umanità di ogni speranza. Depresso ed esausto, il futuro è una permanente ripetizione dell’Uguale. Il futuro non si apre più. Niente di nuovo nasce. Il futuro che rivitalizza, mette le ali, ispira, in altre parole l’avvenire, è completamente assente. Non sembra più possibile nessuna partenza, nessun domani, nessun incipit vita nova, nessuna dipartita dall’Uguale, da ciò che è già stato. La depressione si contrappone radicalmente alla speranza in quanto passione per il nuovo. La speranza è il salto, lo slancio che ci libera dalla depressione, da un futuro esausto».
Di questo salto, dice Han, la società contemporanea sembra non essere più capace. Nel saggio appena pubblicato da Einaudi (Contro la società dell'angoscia), il pensatore di origini coreane ci consegna la radiografia terrificante di un mondo in cui l’angoscia si aggira come uno spettro. Angoscia come senso di fine incombente, come chiusura di ogni prospettiva sull’avvenire. «Il termine “angoscia” (medio alto tedesco: “angest”; antico alto tedesco: “angust”) significa originariamente: “strettezza”», scrive Han. «Essa soffoca ogni ampiezza, riduce ogni prospettiva nella misura in cui restringe il campo visivo e sbarra la vista. Chi prova angoscia si sente spinto in una strettoia. L’angoscia va di pari passo con la sensazione di essere preso, imprigionato, rinchiuso. Nell’angoscia il mondo ci appare come una prigione. Tutte le porte che conducono fuori, all’aperto, sono serrate. Essa preclude, ostruisce il futuro poiché rende inaccessibile il possibile, il nuovo».
L’angoscia e l’ansia da una parte ci paralizzano, dall’altra ci spingono a un attivismo frenetico e insensato. In ogni caso ci costringono in un presente senza uscita: «Tutti noi ci troviamo permanentemente faccia a faccia con scenari apocalittici: una pandemia, una guerra mondiale, una catastrofe climatica. La fine del mondo o della civiltà umana viene sempre più spesso evocata come un qualcosa di incombente, imminente».
Poco cambia che a imprigionarci sia il terrore scatenato da una pandemia o da un incipiente disastro ambientale: l’apocalisse è all’ordine del giorno. Solo una via di uscita resta, ammonisce Han: la speranza, lo slancio verso l’alto e verso il nuovo. Esattamente ciò che ogni giorno il potere attualmente dominante tenta di sopprimere.
Continua a leggereRiduci
I romanzi di Moravia sulla noia erano profetici. Oggi abbiamo perso i criteri oggettivi per capire ciò per cui val la pena batterci.Il filosofo Byung-chul Han illustra il legame tra depressione e denatalità. Evocando pandemie, guerre e catastrofi climatiche il potere congiura contro la speranza.Lo speciale contiene due articoli.È il 1925 quando Alberto Moravia, nemmeno diciottenne, inizia a scrivere Gli Indifferenti, completato nel 1929. Opera d’esordio e caso letterario, negli anni ispirerà film e infinite interpretazioni. Particolarmente efficace fu la lettura che ne diede a caldo Benito Mussolini: «Un romanzo oscenamente borghese e antiborghese al medesimo tempo». E in effetti borghese e antiborghese era Moravia: più che benestante, parente di alti papaveri fascisti e al contempo di grossi nomi dell’antifascismo, egli sentiva sulla pelle l’appartenenza al tinello buono romano e, insieme, la dolorosa alienazione che quell’ambiente gli provocava. Un senso di ansia e di soffocamento si respira fin dalle prime pagine, da cui trasuda l’atroce ipocrisia in cui i protagonisti sono immersi. C’è Leo Merumeci, affarista senza scrupoli, uomo senza valori determinato a soddisfare i propri bisogni incurante delle conseguenze. È l’amante di Mariagrazia, drammatica figura di donna borghese sospesa sul baratro della rovina, indebitata e dunque sotto ricatto dello stesso Merumeci, pateticamente appesa a consuetudini e apparenze che si sgretolano. Poi i figli ventenni di lei: Carla e Michele Ardengo. Il secondo detesta Merumeci, la condizione in cui ha costretto sua madre, l’impotenza in cui tutta la famiglia è relegata. Ma è incapace di una vera reazione. La prima, Carla, è nauseata dallo scorrere piatto dei giorni, dall’idea che nulla possa cambiare in meglio nella sua esistenza. Così rassegnata dall’abbandonarsi alla libidine di Merumeci, che va a letto con Mariagrazia ma comunque ne concupisce la figlia. Un quadro nel complesso spaventoso, una sorta di ritratto funebre di una generazione la cui caratteristica è appunto l’indifferenza: la morale è assente, la prospettiva di un cambiamento non esiste, l’intera quotidianità è cristallizzata, bloccata ed esangue. Ma ai personaggi non sembra importare: si fanno vivere, trascinare. Ed è esattamente qui che sta la potenza (e con essa l’attualità) del romanzo. Gli Indifferenti va letto in parallelo alla Noia, che Moravia darà alle stampe nel 1960, e pure a Il conformista, del 1951. Perché ovunque prevale una sorta di inabilità dei protagonisti, una incapacità di prendere posizione rispetto alla vita, un tremendo senso di inutilità e insensatezza. L’indifferente, annoiato, si conforma. Siamo, con tutta evidenza, nell'universo della melanconia a cui Jean Paul Sartre dedicherà il capolavoro La Nausea (inizialmente intitolato appunto Melancholia). Non si tratta di tristezza e nemmeno di semplice rassegnazione, bensì propriamente di accidia, perdita di forza e iniziativa. «Per molti la noia è il contrario del divertimento; e divertimento è distrazione, dimenticanza», scrive Moravia nel prologo de La Noia. «Per me, invece, la noia non è il contrario del divertimento; potrei dire, anzi, addirittura, che per certi aspetti essa rassomiglia al divertimento in quanto, appunto, provoca distrazione e dimenticanza, sia pure di un genere molto particolare. La noia, per me, è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. Per adoperare una metafora, la realtà, quando mi annoio, mi ha sempre fatto l’effetto sconcertante che fa una coperta troppo corta, ad un dormiente, in una notte d’inverno: la tira sui piedi e ha freddo al petto, la tira sul petto e ha freddo ai piedi; e così non riesce mai a prender sonno veramente. Oppure, altro paragone, la mia noia rassomiglia all’interruzione frequente e misteriosa della corrente elettrica in una casa: un momento tutto è chiaro ed evidente, qui sono le poltrone, lì i divani, più in là gli armadi, le consolle, i quadri, i tendaggi, i tappeti, le finestre, le porte; un momento dopo non c’è più che buio e vuoto. Oppure, terzo paragone, la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina; come a vedere in pochi secondi, per trasformazioni successive e rapidissime, un fiore passare dal boccio all’appassimento e alla polvere. Il sentimento della noia nasce in me da quello dell’assurdità di una realtà, come ho detto, insufficiente ossia incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza».Ecco la descrizione di una malattia dell’anima che è anche la nostra, e forse quella dell’intera modernità, come già Charles Baudelaire aveva intuito e come Byung-chul Han ribadisce nei suoi scritti attorno alla società della stanchezza. Come per i personaggi di Moravia le cose stesse perdono consistenza, così per noi, dice Han, le cose si fanno «non cose»: «Ogni cosa svanisce, si disfa pian piano. Scompaiono anche le parti del corpo, e alla fine restano solo voci incorporee, vagabonde, senza meta. [...] Oggi il mondo si svuota riducendosi a informazioni spettrali quanto quelle voci incorporee. La digitalizzazione derealizza, disincarna il mondo». Potremmo dire che la realtà ridotta ad artificio del digitale sia il compimento dello svuotamento iniziato con la modernità, l’apice della melanconia che rapisce i personaggi di Moravia quanto i nostri contemporanei. È la stessa melanconia di cui parla il filosofo Paolo Godani nel recentissimo Melanconia e fine del mondo (Feltrinelli). Una condizione «che si definisce per il sentimento della radicale insensatezza del mondo e della vita, per il senso di colpa altrettanto radicale che ne consegue e per la prostrazione e l’inibizione all’azione che ne costituiscono l’inevitabile corollario. E si è visto sino a che punto il melanconico condivida, e insieme contesti, la struttura metafisica che è a tutti gli effetti quella dominante nella nostra cultura. Questa struttura melanconica implica l’esigenza etica di trascendere l’insensatezza del mondo sottoponendo quest’ultimo all’effetto di una legge, di un valore, di una forma, ma in tal modo conferma nella maniera più decisa possibile che in effetti questo mondo, lasciato a sé stesso, è del tutto insensato. Il melanconico non fa che tenersi a questa conferma, abbandonando l’illusione di ogni fede e di ogni trascendimento. Sarà una sorta di nichilista passivo».L’indifferenza di Moravia è dunque insieme causa e sintomo. L’indifferenza a ogni sistema valoriale, l’estraneità percepita rispetto a ogni ordine trascendente producono alienazione dalla vita, uccidono il desiderio di andare oltre, di costruire qualcosa di nuovo e migliore, provare un sentimento che non sia pura rassegnazione. La speranza, in questo ordine mondiale, non ha cittadinanza. Perché agire, perché spendersi, perché sacrificarsi se non esistono ideali sensati, se ogni cosa è priva di realtà, se tutto è destinato a rimanere identico a sé stesso? Lo spegnimento di cui tratta Moravia è il nostro: una paralisi angosciata, un panico paralizzante che si manifesta come disinteresse, esaurimento delle passioni creative, persino dell’eros. Gli Indifferenti siamo noi, ancora.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/trascendenza-moravia-2671126583.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="dalla-societa-dellangoscia-non-ci-salvera-la-scienza" data-post-id="2671126583" data-published-at="1739192637" data-use-pagination="False"> Dalla società dell’angoscia non ci salverà la scienza P. D. James ci rese partecipi del suo incubo nel 1992, dando alle stampe I figli degli uomini. Il romanzo è ambientato nel 2021, subito dopo la morte dell’ultimo essere umano nato sulla terra. Un ragazzo di venticinque anni ucciso in una rissa. Con lui si spegne l’ultimo barlume di vitalità di un pianeta su cui, da un quarto di secolo, non nasce più nessuno. Theodore Faron, professore di Storia a Oxford e voce narrante, rovescia in un diario il suo sconforto: «L’incombente estinzione della nostra specie e l’impossibilità di evitarla ci offendono e demoralizzano meno della nostra incapacità di scoprirne la causa», scrive. «La scienza e la medicina occidentali non ci hanno preparati all’enormità e all’umiliazione di questo smacco. Vi sono state malattie difficili sia da diagnosticare sia da curare, una delle quali ha quasi spopolato due continenti prima di essere debellata, ma alla fine siamo sempre riusciti a spiegarne le cause. Abbiamo dato un nome ai virus e ai germi che tuttora ci affliggono, con grande mortificazione da parte nostra, dal momento che sembra un affronto personale che ci debbano colpire ancora oggi, come antichi nemici che tengono viva la battaglia e di tanto in tanto uccidono anche quando la loro vittoria è ormai assicurata. La scienza occidentale è stata il nostro dio. [...] La scienza non è mai stata il mio pane: ne capivo poco a scuola e continuo a capirne poco adesso che ho cinquant’anni. Ma è stata un dio anche per me, che pure non ne ho mai compreso appieno le conquiste, e provo anch’io la disillusione universale di chi assiste alla morte del proprio dio». Il potere della tecnica non basta a scongiurare la catastrofe, ad arrestare l’interminabile e mortifero inverno demografico. Secondo il filosofo Byung-chul Han, il racconto della James e il film che ne ha tratto nel 2006 Alfonso Cuarón fornisce una fondamentale chiave di lettura del presente. «I figli degli uomini», spiega, «ci restituisce una rappresentazione della società odierna dominata dalla depressione e diventata completamente priva di speranza. Nella pellicola l’umanità procede verso la propria fine e rischia l’estinzione. [...]. Se le parole della buona novella contenute nell’omelia di Natale: “un bambino è nato per noi” annunciano la speranza, allora la sterilità dell’umanità rappresenta l’assoluta mancanza di ogni speranza». Secondo Han, «ne I figli degli uomini l’umanità cade in una depressione collettiva. L’esperienza della nascita, che vale come sinonimo del futuro e che dovrebbe portare con sé il nuovo, non si verifica più. A essere completamente annullato è il venire-al-mondo inteso come nascita. Il mondo si identifica con l’inferno dell’Uguale. La depressione priva l’umanità di ogni speranza. Depresso ed esausto, il futuro è una permanente ripetizione dell’Uguale. Il futuro non si apre più. Niente di nuovo nasce. Il futuro che rivitalizza, mette le ali, ispira, in altre parole l’avvenire, è completamente assente. Non sembra più possibile nessuna partenza, nessun domani, nessun incipit vita nova, nessuna dipartita dall’Uguale, da ciò che è già stato. La depressione si contrappone radicalmente alla speranza in quanto passione per il nuovo. La speranza è il salto, lo slancio che ci libera dalla depressione, da un futuro esausto». Di questo salto, dice Han, la società contemporanea sembra non essere più capace. Nel saggio appena pubblicato da Einaudi (Contro la società dell'angoscia), il pensatore di origini coreane ci consegna la radiografia terrificante di un mondo in cui l’angoscia si aggira come uno spettro. Angoscia come senso di fine incombente, come chiusura di ogni prospettiva sull’avvenire. «Il termine “angoscia” (medio alto tedesco: “angest”; antico alto tedesco: “angust”) significa originariamente: “strettezza”», scrive Han. «Essa soffoca ogni ampiezza, riduce ogni prospettiva nella misura in cui restringe il campo visivo e sbarra la vista. Chi prova angoscia si sente spinto in una strettoia. L’angoscia va di pari passo con la sensazione di essere preso, imprigionato, rinchiuso. Nell’angoscia il mondo ci appare come una prigione. Tutte le porte che conducono fuori, all’aperto, sono serrate. Essa preclude, ostruisce il futuro poiché rende inaccessibile il possibile, il nuovo». L’angoscia e l’ansia da una parte ci paralizzano, dall’altra ci spingono a un attivismo frenetico e insensato. In ogni caso ci costringono in un presente senza uscita: «Tutti noi ci troviamo permanentemente faccia a faccia con scenari apocalittici: una pandemia, una guerra mondiale, una catastrofe climatica. La fine del mondo o della civiltà umana viene sempre più spesso evocata come un qualcosa di incombente, imminente». Poco cambia che a imprigionarci sia il terrore scatenato da una pandemia o da un incipiente disastro ambientale: l’apocalisse è all’ordine del giorno. Solo una via di uscita resta, ammonisce Han: la speranza, lo slancio verso l’alto e verso il nuovo. Esattamente ciò che ogni giorno il potere attualmente dominante tenta di sopprimere.
Arianna Fontana medaglia d'argento nei 500 metri femminili di pattinaggio di velocità su pista corta ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)
Con ridicolo zelo woke, Cio e Rai avranno pure tagliato i genitali all’Uomo Vitruviano, ma quanto a «huevos» (i puristi lo chiamino pure carattere) atlete e atleti azzurri non sono secondi neppure a Leonardo da Vinci. Nel sesto giorno di Giochi la grande messe continua: un oro e un bronzo oltre l’impresa di Federica Brignone. E un medagliere stratosferico con 17 podi (6 ori, 3 argenti, 8 bronzi), a un tiro di schioppo dal record delle 20 medaglie di Lillehammer. Sulla spinta della formidabile sciatrice rinata, sale su tetto del mondo anche Francesca Lollobrigida, lo sfiora Arianna Fontana con l’argento, mentre la staffetta mista di slittino agguanta la terza piazza dietro Germania e Austria. Non siamo ancora a metà strada e l’Olimpiade italiana è già uno storico trionfo.
La metà femminile del cielo è quella vincente. E Arianna Fontana prova a completare l’opera: questa volta è argento, ecco un’altra donna italiana con lo sguardo da tigre nell’Ice skating arena di Milano. Tredici medaglie vinte. Nei 500 la campionessa valtellinese deve lasciare il passo all’olandese Xandra Velzeboer, primatista del mondo, inavvicinabile. Nei 1000 maschili squalificato Pietro Sighel, il favorito già oro in staffetta, che preferisce guardare avanti: «È andata, ma c’è ancora parecchio lavoro da fare». Era stato lui a rivelare una curiosità in modo un po’ ruvido: «Arianna Fontana, chi la conosce? Lei si allena sempre all’estero, ci vediamo solo in gara». Con questi risultati meglio sconosciuti che compagnoni.
La mamma volante ha fatto il bis. Francesca Lollobrigida plana sul secondo oro e si gode il giro d’onore avvolta nella bandiera tricolore dentro la voliera di Rho Fiera impazzita di italianità. Non c’è niente di meglio per scacciare le gastriti dei contestatori, per zittire chi non voleva le Olimpiadi e stoltamente continua a boicottarle con infantilismo criminale. Nel Pattinaggio di velocità siamo meglio degli olandesi, incredibile solo a immaginarlo qualche mese fa. Merito di questa signora di Frascati di 35 anni che nei 5000 metri ha raddoppiato il metallo prezioso dei 3000; velocissima e determinata in una gara mozzafiato, più forte dell’orange Merel Conijn (2ª a un solo decimo) e della norvegese Ragne Wiklund (3ª).
La pronipote della Bersagliera Lollo è di nuovo sul gradino più alto «grazie al pubblico che mi ha spinto», ha migliorato l’argento conquistato a Pechino, questa volta senza il piccolo Tommaso in tribuna. Lo ha salutato via smartphone. Lui, tre anni, è rimasto a casa con papà Matteo, che ha promesso di riportarlo a bordo pista per le prossime sfide iridate, domani i 1500 e dopodomani la Start. Se il livello è questo, all’orizzonte c’è la leggenda. Nella storia Francesca c’è già, ha contribuito con il secondo exploit a eguagliare il primato di Torino che resisteva da 20 anni grazie a Enrico Fabris e ai suoi boys. E allora è bello pensare a quando lei si allenava con il pancione: «Partorivo il venerdì e il lunedì seguente ero già di nuovo in pista».
Determinazione, fatica, programmi studiati al millimetro. E il bonus mamme voluto dal ministro dello Sport, Andrea Abodi; un contributo di 1000 euro al mese per un anno. Perché la maternità è un valore sempre e la parità di genere non è solo una chiacchiera femminista. Così Lollobrigida sprintava sul ghiaccio con Tommaso nella carrozzina a qualche metro, per consentirle di cogliere il primo accenno di pianto. Un esempio per chi ritiene che i figli siano una palla al piede, un accessorio che deprime le carriere.
Se c’era un giorno sbagliato per prendere un bronzo era proprio questo. Ma nessuno può dimenticare il sacrificio e la felicità dei sei azzurri della staffetta mista sullo slittino col turbo. I doppi Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner, i singoli Dominik Fischnaller e Verena Hofer sono nomi da scandire piano e con ammirazione: sulla storica pista di Cortina riescono nell’impresa di rimanere in scia agli assi tedeschi e austriaci. Dopo gli ori di mercoledì, il bronzo è il punto esclamativo di una specialità che fa sempre la differenza.
Come è destinato a farla, quanto a spettacolo, il torneo di hockey su ghiaccio partito oggi al Forum di Milano con un testa a testa Stati Uniti-Canada destinato a risolversi in finale. Ruggiti e scontri in balaustra, tecnica da supermen e cambi volanti: ci sono i fuoriclasse della NHL a illuminare i Giochi da guerrieri. Oggi l’Italia ha fatto tremare la fortissima Svezia per poi crollare e perdere 5-2. Niente di male, a quei livelli possiamo starci solo per un tempo.
Domani è venerdì, pausa di magro? Non è detto perché nella sprint del Biathlon Tommaso Giacomel ha i numeri per stupire e nel Pattinaggio velocità ormai ci siamo presi l’abitudine al podio. E Davide Ghiotto è lì per questo con i favori del pronostico. Uno spavento nello snowboard: Michela Moioli è caduta in allenamento e ha riportato un trauma facciale. È in dubbio per la gara che comincia stamane ma c’è speranza. Di questi tempi, ragazze azzurre che rinunciano alla lotta non se ne vedono.
Brignone SuperGold. Dal letto di ospedale alla gloria di Cortina

Federica Brignone festeggia dopo la vittoria nel Super G femminile ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)
«È già tanto se torno a camminare». E invece decolla dalla pista di Cortina mentre il monte Cristallo osserva. Vola nell’universo parallelo e rarefatto dei fuoriclasse, accarezza l’impresa della vita e alla fine Federica Brignone danza. Danza, bellissima, sul traguardo come non ha mai danzato. Dieci mesi dopo il dramma, tibia e perone tornano di tungsteno, in armonia col resto. E il mondo è ai piedi di questa fenomenale atleta di 35 anni che in un magico mattino abbraccia l’oro più luminoso perché insperato, miracoloso delle Olimpiadi italiane.
L’anatema dei giorni della disperazione si sgretola davanti alla resurrezione sportiva: pettorale numero 6, SuperG perfetto, 1’23’’41 il tempo. Federica osserva il tabellone come a dire alle altre: «Adesso battetelo». Non ci riesce nessuno. Non la ruggente austriaca Cornelia Hutter (3ª), non la dolce francese Romane Miradoli (2ª). Non la wonder woman americana Breezy Johnson e le tostissime tedesche Emma Aicher e Kira Weidle, che cadono. Anche Sofia Goggia salta a metà gara quando è velocissima (7 decimi di vantaggio), con la grinta della tigre; destino amaro per lei ma meraviglioso per l’epica della rivale azzurra di sempre. Allora Brignone si copre il volto con i guanti, non c’è più bisogno di vedere. Ora quel battito bisogna solo sentirlo.
Il resto si coglie dal pubblico sulle Tofane: i boati scandiscono i tempi più alti delle altre. Lei ride e piange, poi torna sulla terra per andare oltre le emozioni. «In partenza ho detto: o la va o la spacca. Non pensavo di poter vincere l’oro. Non me lo sarei aspettata, mai nella vita. Forse ce l’ho fatta oggi perché questo oro non mi mancava. Sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un’outsider. È incredibile, sento l’adrenalina scorrere nelle vene». È la forza della leggerezza, la socratica serenità di chi non ha mai nulla da dimostrare. Niente sovrastrutture, solo il vento che spazza via la nebbia e il rumore degli sci in derapata sulla neve.
Mentre lo dice, Federica un po’ mente a se stessa. Non c’è niente di casuale in ciò che è accaduto. Domenica aveva partecipato alla discesa libera proprio per testare se stessa, le articolazioni, i legamenti: decimo posto e check up positivo confermato da quel sorriso disarmante, allora inspiegabile, per un piazzamento modesto. Good sensations, la prova generale era riuscita, dopo 315 giorni di calvario la regina sapeva di essere tornata. E allora vale la pena ricordare, ora che tutto è più facile: 3 aprile 2025, Val di Fassa, campionati italiani. Prima manche del gigante, curva verso destra: Brignone infila un braccio nella porta (dinamica simile a quella della caduta di Lindsey Vonn) e si rompe.
La diagnosi è una Caporetto fisica: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Ma non è finita: salta anche il crociato anteriore della stessa gamba. Due interventi chirurgici, una rieducazione tutta da inventare, una carriera spezzata. Lei sembra arrendersi: «Devo pensare alla salute. Vediamo se tornerò a camminare bene, mi sono procurata un danno permanente, non recupererò mai la piena funzionalità del ginocchio». Invece ha scalato la montagna, centimetro dopo centimetro, dolore dopo dolore, fatica dopo fatica, per tornare a vedere il cielo e a toccare l’oro.
È tempo di ricapitolare. Giù dal podio le altre azzurre, quinta Laura Pirovano, settima Elena Curtoni. Sofia Goggia s’è rialzata, pensa al futuro, il bronzo nella libera non le basta. «Sono dispiaciuta. Sapevo che bisognava fare attenzione tra la Grande Curva e lo Scarpadon. Ho sciato fortissimo e non pensavo di essere davanti, ma le gare vanno portate in fondo. Per Federica, con tutto quello che ha passato, non era facile tornare così. Questo SuperG è nelle sue corde, onore e merito a lei». Onesta, misurata, sa che tutti stanno pensando alle loro diatribe passate, a una rivalità spesso sconfinata nella rissa verbale. Un dualismo qualche volta tossico, una competitività che ha comunque contribuito a costruire due carriere eccezionali.
Federica Brignone scruta i volti di parenti e amici. Piangono tutti, anche il fratello Davide, ex sciatore e suo allenatore. Mamma Ninna Quario, fenomenale slalomista della valanga rosa e giornalista, ha la voce che trema: «È fantastica. Credevo che sarebbe tornata ma vincere l’oro in SuperG è incredibile. Grazie a tutti quelli che ci sono stati vicini in questo periodo, spero che oggi siano felici come noi». Poi dipinge una frase da donna di montagna con i valori non negoziabili in tasca. «Come festeggiamo? Come sempre, a dirle brava quando è brava e sbagli quando sbaglia». La famiglia è stata il segreto di una carriera da sogno per la valdostana di La Salle: argento in gigante e bronzo in combinata ai Giochi di Pechino, bronzo in gigante a quelli di PyeongChang. Più due ori e tre argenti mondiali, due Coppe del Mondo, 37 successi. Un monolocale di cimeli.
Quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le stringe la mano, lei vacilla. Non sciogliersi adesso è più difficile che affrontare le Tofane. Ancora Federica, ancora dettagli mentre fuori è il delirio: «Sembra impossibile, con quello che ho passato in questi 10 mesi. Ho camminato dopo tre mesi, ho combattuto ogni mattina per tornare me stessa. Due giorni fa sono andata a Pozza in elicottero, mi sono messa gli scarponi ed era impossibile sciare. Avevo male alla gamba, peggio del solito. Ma bisognava stringere i denti. Dopo l’infortunio il momento più bello è stato quando ho rimesso gli sci da gigante: ho capito che riuscivo a fare le curve e ad appoggiare la gamba».
Ora Federica ha un pensiero anche per la sua splendida famiglia. «Sono orgogliosa di avere un fratello e una famiglia così. Abbiamo fatto qualcosa di speciale. Ripenso a mio fratello da bambini, ci siamo sempre divertiti e continuiamo a farlo. È la cosa più bella». Arrivano i complimenti della Vonn, dall’ospedale: «Grande, che incredibile ritorno». Nessuno osa ricordare alla Brignone risorta che le Olimpiadi continuano. Ci pensa lei. «Arriverò al gigante più leggera, ma non ci ho ancora messo la testa. Spero di riuscire ad appoggiarmi bene alla gamba, ho le mie chance. È la gara di un giorno, tutto può succedere». La regina è già lassù, davanti al cancelletto.
Continua a leggereRiduci
A sorpresa, i dati diffusi martedì da Kering hanno dato una scossa al mercato. Nonostante un calo delle vendite del 10%, il risultato è stato accolto con un balzo del titolo dell’11% a Parigi: un paradosso solo apparente, spiegato dal fatto che gli analisti temevano un tracollo ben peggiore. «Kering ha sorpreso il mercato con risultati migliori delle attese, confermando che il turnaround di Gucci, seppur fragile, sta iniziando a muovere i primi passi», spiega Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert Scf. «Il miglioramento nell’area Asia-Pacifico è un segnale incoraggiante dopo dieci trimestri consecutivi di calo. Tuttavia, la redditività di Gucci, oggi al 16%, resta lontana dai fasti del passato. La strategia di Luca de Meo di pulire i bilanci e chiudere decine di boutique è una “cura da cavallo” necessaria, ma la vera sfida per il 2026 sarà trasformare questi segnali di stabilizzazione in crescita reale dei margini».
Se Kering prova a risalire la china, il leader mondiale Lvmh sceglie la via del rigore estremo. Bernard Arnault ha descritto il 2025 come un anno «solido in un contesto turbolento», ma ha già avvertito che il 2026 non sarà una passeggiata. Un elemento tecnico, spesso trascurato, sta infatti pesando enormemente sui profitti: la valuta.
«Il dato più eclatante emerso dai conti di Lvmh riguarda l’impatto dei tassi di cambio», osserva lo strategist di SoldiExpert Scf e co-autore di LetteraSettimanale.it. «Degli 1,8 miliardi di euro di calo dell’utile operativo, ben un miliardo è imputabile alle fluttuazioni valutarie. Senza questo effetto, la discesa sarebbe stata solo del 4%. Questo ci dice che la capacità di gestire il rischio di cambio è oggi determinante quanto il lancio di una nuova collezione».
Il problema strutturale che le Maison devono affrontare è però più profondo di un semplice ciclo economico negativo. Si chiama «luxury fatigue» (stanchezza da lusso), ma nasconde una crisi di fiducia del consumatore. Dal 2019 a oggi, i prezzi di molti beni di lusso sono saliti del 40-50%, spesso senza un corrispondente aumento della qualità o dell’esclusività. «Il settore si trova in una trappola autoinflitta: i prezzi eccessivi hanno allontanato la classe media, che costituiva la base delle vendite», continua l’esperto. Oggi i consumatori, specialmente i più giovani della Gen Z, cercano autenticità e valore reale, non più solo un logo che funga da status symbol. Il 2026 sarà l’anno in cui i brand dovranno riconnettersi con i propri codici originali, offrendo qualcosa che giustifichi i listini attuali, altrimenti il divario tra marchi resilienti e marchi in declino continuerà ad ampliarsi».
Continua a leggereRiduci
iStock
Presentato il Disegno di legge sull’illuminazione pubblica intelligente. I dati Assil-Politecnico parlano chiaro: milioni di impianti da aggiornare e risparmi possibili fino all’80%, con benefici su costi, consumi ed emissioni.
Al Senato si è tornato a parlare di luce, ma non solo in senso figurato. Al centro del confronto, questa volta, c’è l’illuminazione pubblica e il suo possibile ruolo nella transizione energetica e digitale del Paese. Nella Sala Caduti di Nassirya si è tenuta la conferenza stampa dedicata allo «smart lighting», promossa dalla senatrice Clotilde Minasi, partendo dai dati di uno studio di Assil, l’associazione dei produttori di illuminazione, realizzato con il Politecnico di Milano.
Il tema è tutt’altro che tecnico per addetti ai lavori. In Italia ci sono circa 10 milioni di punti luce pubblici e, anche se il 65% è già passato al LED, restano ancora circa 3,5 milioni di impianti da aggiornare. Ed è proprio su questo fronte che si gioca una partita importante, sia in termini di risparmio energetico sia di modernizzazione delle città.
In questo contesto si inserisce il Disegno di legge n. 1700, depositato in Senato, che punta a dare un quadro di riferimento per rendere più efficienti l’illuminazione pubblica e quella degli edifici pubblici attraverso sistemi digitalizzati di ultima generazione. L’obiettivo è chiaro: ridurre consumi ed emissioni, ma anche migliorare la gestione degli impianti, la sicurezza e la qualità del servizio.
La proposta guarda a soluzioni basate su Led, sensori di luminosità e piattaforme di gestione da remoto, capaci di integrare funzioni di monitoraggio, automazione e manutenzione predittiva. In pratica, un’illuminazione che non si limita ad accendersi e spegnersi, ma che può essere controllata in modo intelligente e centralizzato, con benefici anche sui costi di gestione per le amministrazioni.
Lo studio di Assil e Politecnico di Milano disegna tre possibili scenari. Il più prudente prevede la semplice sostituzione degli impianti obsoleti con corpi illuminanti a Led. Quello più avanzato, invece, immagina una vera evoluzione tecnologica, con una diffusione capillare di sistemi intelligenti in linea con l’idea di smart city e con gli obiettivi della direttiva europea Epbd.
I numeri danno la misura dell’impatto. Nello scenario base, il risparmio energetico stimato è di 1,7 GWh, pari a circa 11.950 alberi «equivalenti» piantati ogni anno e a una riduzione di 424 tonnellate di CO2. Nello scenario più avanzato si arriverebbe a 2,4 GWh, con l’equivalente di 17.435 alberi e 619 tonnellate di CO2 in meno.
E non si parla solo di lampioni. L’illuminazione pubblica esterna è un esempio di un approccio che potrebbe estendersi anche alla gestione del patrimonio pubblico. Secondo i dati, l’introduzione di sistemi di smart lighting può portare a risparmi energetici fino al 70-80% rispetto agli impianti tradizionali, a seconda dei contesti.
Il disegno di legge viene presentato come a costo zero per le finanze pubbliche e inserito nel percorso di transizione digitale ed ecologica delle infrastrutture urbane. L’idea è costruire una rete nazionale di illuminazione «intelligente», in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che punta a una forte riduzione delle emissioni entro il 2030. Se il testo verrà approvato, entro sei mesi la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida nazionali, che saranno poi aggiornate ogni tre anni per restare al passo con l’evoluzione tecnologica e le pratiche europee.
Per il settore, si tratta di un passaggio considerato decisivo. «La presentazione di questo Disegno di Legge rappresenta un punto importante per la diffusione delle tecnologie di illuminazione di qualità», ha detto Carlo Comandini, presidente di Assil, sottolineando come il provvedimento possa trasformare l’illuminazione pubblica da semplice voce di spesa a leva strategica per la transizione digitale ed ecologica del Paese.
Continua a leggereRiduci
Imagoeconomica
È stato confermato che sono in corso le operazioni preliminari per la ripartenza dell’altoforno 2 dopo importanti lavori di ripristino partiti ad agosto e conclusi nei giorni scorsi. L’altoforno 2 dovrebbe riavviarsi intorno al 20 febbraio dopo essere stato fermo due anni e con la sua stabilizzazione, si provvederà a fermare il 4 per lavori di manutenzione che si protrarranno sino a fine aprile. Al termine di questo mese saranno riattivate anche le batterie delle cokerie che intorno al 20 gennaio l’azienda ha bloccato mettendole in preriscaldo, dovendo intervenire sull’impianto di trattamento del gas della cokeria con l’installazione di un nuovo reattore catalitico. In sostanza con le batterie riaccese e due altiforni su tre operativi, da maggio l’azienda raggiungerà una conduzione produttiva migliore. Infine si attende la decisione del Gip di Taranto sulla istanza di dissequestro dell'altoforno 1 presentata dall’azienda. Dall’incidente dello scorso maggio ad Afo1 la Procura non ha ancora assunto una decisione sul dissequestro ma i commissari hanno già acquistato i pezzi necessari per la ripartenza, operazione che potrebbe essere completata in 8-9 mesi (qualche mese in più rispetto al tempo necessario per far ripartire Afo2, danneggiato dalla precedente gestione ArcelorMittal/Morselli).
I commissari straordinari hanno trovato, al loro arrivo, un solo altoforno funzionante e 7 miliardi di danni documentati e periziati, causati dalla precedente gestione.
A partire da febbraio 2024 sono stati destinati oltre 997 milioni alla manutenzione e agli investimenti industriali, a conferma dell’impegno dell’amministrazione straordinaria nel garantire la piena funzionalità degli impianti. Difficile sostenere quindi che non abbia rappresentato una svolta nel corso di questa azienda, fondamentale per l’industria nazionale.
Nel 2025 inoltre il sito industriale ha registrato il più alto numero di ore lavorate negli ultimi anni, sia da parte del personale diretto sia delle imprese terze. Quindi nessuna chiusura imminente, nessuna fine dell’Ilva, come paventato dai sindacati.
Eppure proprio qualche mese fa, a novembre scorso, dopo un vertice a Roma, il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, dichiarando la rottura delle trattative, affermava che il piano presentato dal governo avrebbe portato alla «chiusura definitiva» di tutti gli stabilimenti entro il marzo successivo, con la cassa integrazione di migliaia di lavoratori. Poi criticava il cosiddetto «piano corto» del governo, sostenendo che fosse «corto» non per la durata temporale ma perché «il tempo che rimane alla chiusura totale è molto breve».
Invece il «piano corto» del governo è servito a consentire le necessarie manutenzioni (investimenti da un miliardo nella manutenzioni) per tornare a produrre acciaio, come era sempre stato chiarito dai commissari.
Palombella poi diceva che senza una seria decarbonizzazione, ovvero il passaggio ai forni elettrici, l’azienda sarebbe destinata a sparire, definendo la situazione una «tragedia industriale e umana».
Non meno fosco lo scenario prospettato dalla Cgil, sia a livello nazionale che territoriale. Per Giovanni D’Arcangelo della Cgil Taranto, il governo Meloni era responsabile di «una lenta agonia».
Il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha più volte denunciato la mancanza di una strategia pubblica chiara e il rischio di «spezzatino», ovvero la vendita separata dei siti. In generale la Cgil aveva chiesto la nazionalizzazione, unica formula, diceva per garantire la continuità produttiva e la tutela ambientale.
C’è da aprire il capitolo Flacks: il fondo che sta trattando con le amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d’Italia l’acquisto dell’intera azienda con tutti i suoi stabilimenti, dopo che l’offerta presentata nelle scorse settimane è stata reputata, sia dai commissari che dai comitati di sorveglianza, la migliore.
Continua a leggereRiduci