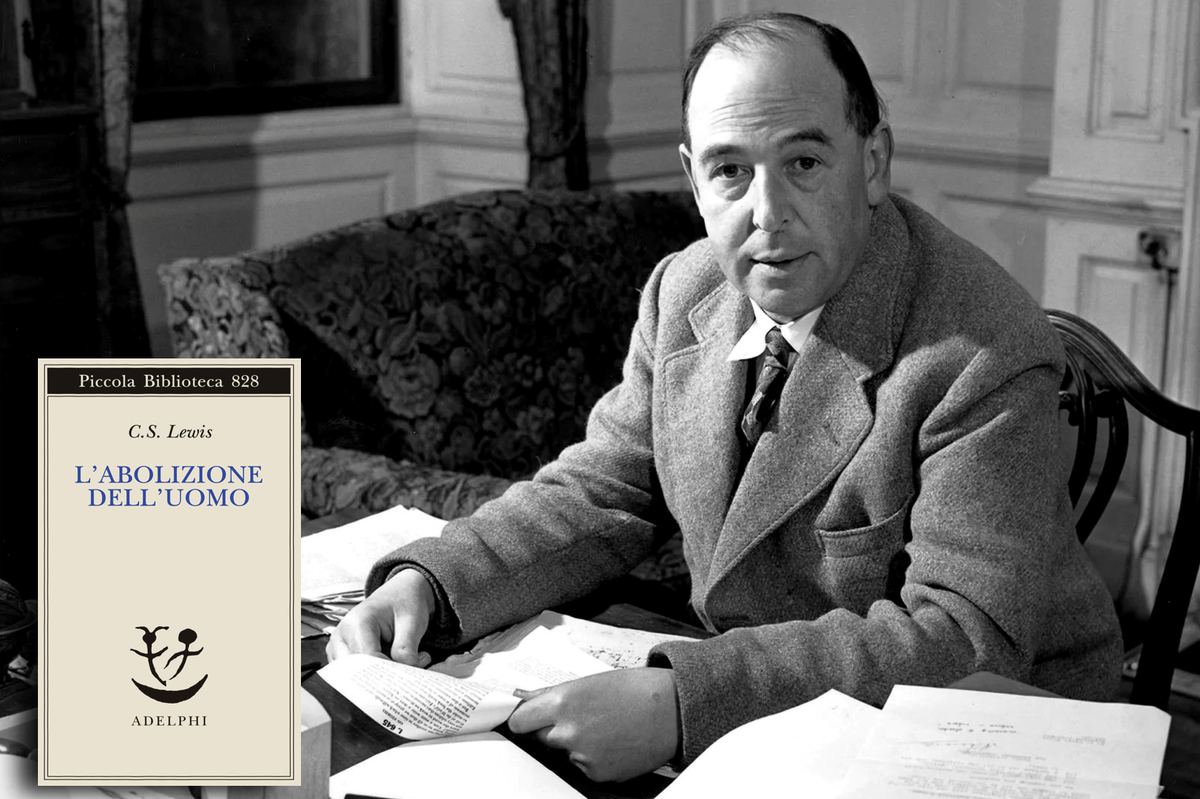True
2024-08-22
Il tifo ipocrita di Obama per la Harris cela i timori dem sui veri sondaggi
Barack e Michelle Obama (Ansa)
Le celebrazioni a reti unificate della Convention dem non si fermano. Tutti in sollucchero per i discorsi tenuti, martedì sera, dai coniugi Obama. Tutti a parlare di un Partito democratico unito attorno a una candidata formidabile, quale sarebbe Kamala Harris. Addirittura, c’è chi si è spinto a parlare di «spirito del 2008», lasciando intendere che la vicepresidente potrebbe ripercorrere le orme della storica campagna elettorale che portò proprio Barack Obama, quell’anno, alla Casa Bianca. Bene, cerchiamo di andare un po’ oltre questa stucchevole melassa mediatica.
Innanzitutto, lo «spirito del 2008» non c’entra nulla con la Harris. Nel 2008, Obama condusse una campagna antisistema, correndo contro l’establishment dem, rappresentato da Hillary Clinton, e contro quello di Washington, capitanato all’epoca dal repubblicano John McCain. Oggi accade invece l’esatto opposto: lo stesso establishment dem (da cui Obama, negli anni, si è lasciato man mano assorbire, fino a divenirne in buona sostanza il dominus) ha silurato opacamente un presidente, che aveva ottenuto 14 milioni di voti alle primarie, sostituendolo meccanicamente con la sua vice e bypassando così del tutto la volontà popolare. Senza dimenticare che l’attuale vicepresidente ha sempre puntato le sue carte elettorali sull’ «identity politics»: il contrario di quanto fatto, proprio nel 2008, da Obama, che volle evitare di ripetere gli errori della fallimentare «Rainbow Coalition», messa in piedi dal reverendo Jesse Jackson nel 1984.
In secondo luogo, non si può non scorgere una certa ipocrisia da parte dell’ex presidente dem. Certo, a lui tutto viene perdonato. Persino se scade nel sessismo, quando, con un gesto, parlando della «strana ossessione di Trump per la dimensione delle folle», allude alla scarsa virilità dello sfidante del Gop. Dopodiché, martedì Obama ha definito Joe Biden un «fratello» dopo averlo messo sotto pressione per spingerlo al ritiro. Anche il suo sperticato elogio della Harris cela qualche contraddizione. «L’America è pronta per un nuovo capitolo. L’America è pronta per una storia migliore. Siamo pronti per una presidente Kamala Harris», ha affermato. Eppure, dopo aver manovrato con successo per silurare Biden, Obama non voleva che fosse rimpiazzato dalla sua vice. Le carte su cui puntava erano altre, a partire probabilmente dal governatore della California, Gavin Newsom. Non dimentichiamo che Obama ha atteso molti giorni prima di dare il proprio endorsement alla Harris. Senza trascurare che, il giorno successivo all’annuncio dell’addio elettorale di Biden, l’ex senior advisor dello stesso Obama, David Axelrod, si oppose a una successione meccanica, invocando un «processo aperto» per selezionare il nuovo candidato. Una richiesta simile era arrivata, poco prima, anche da Nancy Pelosi: segno quindi che, in origine, né Obama né l’ex Speaker nutrivano simpatia per un’eventuale discesa in campo della Harris. Inoltre, a destare perplessità è anche un passaggio, mediaticamente assai enfatizzato, dell’intervento di Michelle Obama. «La speranza sta tornando», ha detto, tessendo le lodi della candidata dem. Peccato che la Harris sia in carica da quasi quattro anni. E che, ancora oggi, abbia un grado di approvazione, come numero due della Casa Bianca, di appena il 41% a fronte di un grado di disapprovazione del 49%.
Un terzo elemento da sottolineare è che la Convention in corso a Chicago appare quasi completamente fondata sull’antitrumpismo. «L’opposizione a Trump è la forza unificante della Convention nazionale dem», ha scritto ieri Politico. Basta ascoltare la maggior parte degli interventi finora tenutisi, soprattutto quelli di Obama e della Clinton. «Trump vede il potere come nient’altro che un mezzo per raggiungere i suoi fini», ha tuonato l’ex presidente dem, mentre la Clinton, lunedì, aveva bollato il tycoon come un pericolo per lo Stato di diritto. L’apoteosi è stata poi rappresentata dal fatto che, a esultare alla Convention, c’era anche Letitia James: la procuratrice generale di New York, che intentò una causa civile contro la Trump Organization. Sia chiaro: è normale che alla Convention dem si critichi il candidato repubblicano e lo stesso Trump non è uno che risparmia strali all’avversaria. Il punto è che, oltre all’antitrumpismo, non si capisce quali siano gli altri fattori coesivi in seno all’Asinello. I dem centristi restano irritati per il fatto che la Harris abbia scelto Tim Walz, anziché Josh Shapiro, come proprio vice. I fedelissimi di Biden hanno storto il naso dopo che il discorso del presidente, lunedì, è stato fatto slittare a tarda notte. Infine, nonostante le numerose concessioni che la Harris ha fatto loro, i manifestanti dell’estrema sinistra pro Palestina continuano a essere sul piede di guerra. Oltre alle proteste che hanno organizzato a Chicago domenica e lunedì, l’altro ieri hanno anche interrotto un evento del Women's Caucus, a cui stava parlando Walz.
Insomma, di unità vera ce n’è poca. E qui emerge un passaggio significativo del discorso di Obama. «Questa sarà comunque una gara serrata in un Paese diviso in due», ha detto. Parole molto indicative, che stridono con l’euforia mediatica, costruita negli scorsi giorni attorno alla candidata dem. D’altronde, lunedì, Chauncey McLean, presidente del Super Pac pro Harris Future Forward, ha affermato che, per la Harris, i sondaggi riservati risulterebbero «molto meno rosei» di quelli pubblicati nelle ultime settimane. Tra divisioni interne e timori sondaggistici, la panna montata mediatica, che circonda la candidata dem, rischia quindi di sgonfiarsi a breve.
Trump aspetta l’assist di Kennedy
Durante la Convention nazionale dem di Chicago, Donald Trump non è rimasto con le mani in mano. Il tycoon ha infatti scelto di dare battaglia negli Stati chiave, a partire da quelli della Rust Belt: l’area in cui probabilmente saranno decise le elezioni di novembre. Lunedì ha tenuto un comizio in Pennsylvania, mentre martedì si è recato in Michigan. Il suo candidato vice, JD Vance, ha invece partecipato a un evento elettorale in Wisconsin. Ieri, entrambi hanno inoltre visitato il North Carolina. Un tour de force significativo, che la campagna di Kamala Harris ha cercato di mettere nel mirino. In particolare, la candidata dem ha criticato il rivale per essersi recato a Howell: cittadina del Michigan, storicamente collegata al Ku Klux Klan, in cui, a fine luglio, una dozzina di suprematisti bianchi aveva inscenato una manifestazione. La campagna del tycoon ha replicato, ricordando che anche Joe Biden, a ottobre 2021, visitò Howell, per presentare il proprio piano infrastrutturale.
Come che sia, al di là delle polemiche, i colletti blu della Rust Belt restano centrali. La media sondaggistica di Real Clear Politics mostra come la Harris - in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin - abbia al momento un vantaggio assai inferiore rispetto a quello detenuto da Biden e Hillary Clinton rispettivamente ad agosto 2020 e ad agosto 2016. Non solo. Chauncey McLean, presidente del Super Pac pro Harris Future Forward, ha ammesso che, per la candidata dem, i sondaggi riservati «sono molto meno rosei» di quelli pubblici. Senza poi trascurare che il sito di scommesse in criptovalute, Polymarket, è tornato a dare in vantaggio Trump negli ultimi giorni. Questo poi ovviamente non significa che per l’ex presidente la situazione sia tutta rose e fiori. Non solo la Harris ha finora raccolto 500 milioni di dollari in fondi elettorali, ma Trump deve fare anche attenzione in North Carolina, dove ha pericolosamente perso terreno. La partita, insomma, è aperta, come lo è sempre stata (sì, anche quando il candidato dem era Biden, almeno fino al disastroso dibattito televisivo del 27 giugno).
Ma la campagna del tycoon non sta soltanto battendo palmo a palmo gli Stati chiave. È anche probabilmente in trattative per ottenere l’endorsement di Robert Kennedy jr, che sta attualmente correndo da indipendente. Martedì, la candidata vice di Kennedy, Nicole Shanahan, ha rivelato che il diretto interessato starebbe valutando di fare un passo indietro e di dare l’appoggio al candidato repubblicano. Trump, dal canto suo, ha colto subito la palla al balzo, dicendosi aperto alla possibilità di riservare al figlio di Bob Kennedy un ruolo in una sua futura amministrazione. Del resto, che i due si stessero avvicinando, non era esattamente un mistero. A luglio, fu diffuso il video di una telefonata tra lo stesso Kennedy, noto antivaccinista, e Trump, in cui quest’ultimo esprimeva proprio dei dubbi sui vaccini. Va anche detto che, alcuni giorni fa, il Washington Post ha riportato che il candidato indipendente avrebbe cercato di mettersi in contatto con il team della Harris per ottenere un incarico in un’eventuale nuova amministrazione dem. D’altronde, la campagna di Kennedy è ormai in forte difficoltà, avendo meno di quattro milioni di dollari in cassa.
Ma che cosa accadrebbe se Kennedy, attualmente dato da Fivethirtyeight al 5% a livello nazionale, si ritirasse e sostenesse Trump? Alcuni ritengono che un simile scenario favorirebbe la Harris, visto che il nome Kennedy è ancora di richiamo per una parte della sinistra americana: sinistra che, tra le altre cose, è piuttosto vicina al figlio di Bob soprattutto sull’ambientalismo. Se quindi lui restasse in campo, ragiona questa scuola di pensiero, rosicchierebbe voti alla vicepresidente. Ciò detto, attenzione: lo scorso 10 agosto, The Hill ha riferito di sondaggi secondo cui, con l’uscita di scena di Biden, la presenza di Kennedy nella corsa danneggerebbe più Trump che la Harris. Nelle ultime tre settimane, l’ex presidente ha registrato performance sondaggistiche migliori, sia a livello nazionale sia a livello statale, in assenza di Kennedy. Secondo The Hill, senza di lui, il tycoon guadagnerebbe oggi quasi quattro punti in Michigan. Certo, qualora il candidato indipendente si unisse a Trump, a quest’ultimo verrà chiesto conto di quando, alcuni mesi fa, lo bollava come un radicale di estrema sinistra. Tuttavia il pur non enorme pacchetto di voti detenuto da Kennedy non può non far gola all’ex presidente.
Non è neppure escluso, da questo punto di vista, che l’avvicinamento tra i due sia stato mediato da Elon Musk, che intrattiene buoni rapporti con entrambi. Tra l’altro, Trump ha di recente aperto all’ipotesi di offrire anche al Ceo di Tesla un incarico nella propria amministrazione. E lui si è già detto disponibile.
Continua a leggereRiduci
Alla Convention, l’ex presidente e la moglie lodano la candidata, di cui hanno ostacolato la nomina. Evocano lo «spirito del 2008», come se ora a tirare le fila non sia l’establishment. Unito soltanto dall’anti trumpismo.Tour negli Stati chiave di JD Vance e del tycoon, che confida nel ritiro dell’indipendente e gli offre un posto nell’amministrazione. Nella sua squadra entrerebbe anche Elon Musk.Lo speciale contiene due articoli.Le celebrazioni a reti unificate della Convention dem non si fermano. Tutti in sollucchero per i discorsi tenuti, martedì sera, dai coniugi Obama. Tutti a parlare di un Partito democratico unito attorno a una candidata formidabile, quale sarebbe Kamala Harris. Addirittura, c’è chi si è spinto a parlare di «spirito del 2008», lasciando intendere che la vicepresidente potrebbe ripercorrere le orme della storica campagna elettorale che portò proprio Barack Obama, quell’anno, alla Casa Bianca. Bene, cerchiamo di andare un po’ oltre questa stucchevole melassa mediatica.Innanzitutto, lo «spirito del 2008» non c’entra nulla con la Harris. Nel 2008, Obama condusse una campagna antisistema, correndo contro l’establishment dem, rappresentato da Hillary Clinton, e contro quello di Washington, capitanato all’epoca dal repubblicano John McCain. Oggi accade invece l’esatto opposto: lo stesso establishment dem (da cui Obama, negli anni, si è lasciato man mano assorbire, fino a divenirne in buona sostanza il dominus) ha silurato opacamente un presidente, che aveva ottenuto 14 milioni di voti alle primarie, sostituendolo meccanicamente con la sua vice e bypassando così del tutto la volontà popolare. Senza dimenticare che l’attuale vicepresidente ha sempre puntato le sue carte elettorali sull’ «identity politics»: il contrario di quanto fatto, proprio nel 2008, da Obama, che volle evitare di ripetere gli errori della fallimentare «Rainbow Coalition», messa in piedi dal reverendo Jesse Jackson nel 1984.In secondo luogo, non si può non scorgere una certa ipocrisia da parte dell’ex presidente dem. Certo, a lui tutto viene perdonato. Persino se scade nel sessismo, quando, con un gesto, parlando della «strana ossessione di Trump per la dimensione delle folle», allude alla scarsa virilità dello sfidante del Gop. Dopodiché, martedì Obama ha definito Joe Biden un «fratello» dopo averlo messo sotto pressione per spingerlo al ritiro. Anche il suo sperticato elogio della Harris cela qualche contraddizione. «L’America è pronta per un nuovo capitolo. L’America è pronta per una storia migliore. Siamo pronti per una presidente Kamala Harris», ha affermato. Eppure, dopo aver manovrato con successo per silurare Biden, Obama non voleva che fosse rimpiazzato dalla sua vice. Le carte su cui puntava erano altre, a partire probabilmente dal governatore della California, Gavin Newsom. Non dimentichiamo che Obama ha atteso molti giorni prima di dare il proprio endorsement alla Harris. Senza trascurare che, il giorno successivo all’annuncio dell’addio elettorale di Biden, l’ex senior advisor dello stesso Obama, David Axelrod, si oppose a una successione meccanica, invocando un «processo aperto» per selezionare il nuovo candidato. Una richiesta simile era arrivata, poco prima, anche da Nancy Pelosi: segno quindi che, in origine, né Obama né l’ex Speaker nutrivano simpatia per un’eventuale discesa in campo della Harris. Inoltre, a destare perplessità è anche un passaggio, mediaticamente assai enfatizzato, dell’intervento di Michelle Obama. «La speranza sta tornando», ha detto, tessendo le lodi della candidata dem. Peccato che la Harris sia in carica da quasi quattro anni. E che, ancora oggi, abbia un grado di approvazione, come numero due della Casa Bianca, di appena il 41% a fronte di un grado di disapprovazione del 49%.Un terzo elemento da sottolineare è che la Convention in corso a Chicago appare quasi completamente fondata sull’antitrumpismo. «L’opposizione a Trump è la forza unificante della Convention nazionale dem», ha scritto ieri Politico. Basta ascoltare la maggior parte degli interventi finora tenutisi, soprattutto quelli di Obama e della Clinton. «Trump vede il potere come nient’altro che un mezzo per raggiungere i suoi fini», ha tuonato l’ex presidente dem, mentre la Clinton, lunedì, aveva bollato il tycoon come un pericolo per lo Stato di diritto. L’apoteosi è stata poi rappresentata dal fatto che, a esultare alla Convention, c’era anche Letitia James: la procuratrice generale di New York, che intentò una causa civile contro la Trump Organization. Sia chiaro: è normale che alla Convention dem si critichi il candidato repubblicano e lo stesso Trump non è uno che risparmia strali all’avversaria. Il punto è che, oltre all’antitrumpismo, non si capisce quali siano gli altri fattori coesivi in seno all’Asinello. I dem centristi restano irritati per il fatto che la Harris abbia scelto Tim Walz, anziché Josh Shapiro, come proprio vice. I fedelissimi di Biden hanno storto il naso dopo che il discorso del presidente, lunedì, è stato fatto slittare a tarda notte. Infine, nonostante le numerose concessioni che la Harris ha fatto loro, i manifestanti dell’estrema sinistra pro Palestina continuano a essere sul piede di guerra. Oltre alle proteste che hanno organizzato a Chicago domenica e lunedì, l’altro ieri hanno anche interrotto un evento del Women's Caucus, a cui stava parlando Walz.Insomma, di unità vera ce n’è poca. E qui emerge un passaggio significativo del discorso di Obama. «Questa sarà comunque una gara serrata in un Paese diviso in due», ha detto. Parole molto indicative, che stridono con l’euforia mediatica, costruita negli scorsi giorni attorno alla candidata dem. D’altronde, lunedì, Chauncey McLean, presidente del Super Pac pro Harris Future Forward, ha affermato che, per la Harris, i sondaggi riservati risulterebbero «molto meno rosei» di quelli pubblicati nelle ultime settimane. Tra divisioni interne e timori sondaggistici, la panna montata mediatica, che circonda la candidata dem, rischia quindi di sgonfiarsi a breve.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/tifo-ipocrita-obama-per-harris-2669002168.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="trump-aspetta-lassist-di-kennedy" data-post-id="2669002168" data-published-at="1724264609" data-use-pagination="False"> Trump aspetta l’assist di Kennedy Durante la Convention nazionale dem di Chicago, Donald Trump non è rimasto con le mani in mano. Il tycoon ha infatti scelto di dare battaglia negli Stati chiave, a partire da quelli della Rust Belt: l’area in cui probabilmente saranno decise le elezioni di novembre. Lunedì ha tenuto un comizio in Pennsylvania, mentre martedì si è recato in Michigan. Il suo candidato vice, JD Vance, ha invece partecipato a un evento elettorale in Wisconsin. Ieri, entrambi hanno inoltre visitato il North Carolina. Un tour de force significativo, che la campagna di Kamala Harris ha cercato di mettere nel mirino. In particolare, la candidata dem ha criticato il rivale per essersi recato a Howell: cittadina del Michigan, storicamente collegata al Ku Klux Klan, in cui, a fine luglio, una dozzina di suprematisti bianchi aveva inscenato una manifestazione. La campagna del tycoon ha replicato, ricordando che anche Joe Biden, a ottobre 2021, visitò Howell, per presentare il proprio piano infrastrutturale. Come che sia, al di là delle polemiche, i colletti blu della Rust Belt restano centrali. La media sondaggistica di Real Clear Politics mostra come la Harris - in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin - abbia al momento un vantaggio assai inferiore rispetto a quello detenuto da Biden e Hillary Clinton rispettivamente ad agosto 2020 e ad agosto 2016. Non solo. Chauncey McLean, presidente del Super Pac pro Harris Future Forward, ha ammesso che, per la candidata dem, i sondaggi riservati «sono molto meno rosei» di quelli pubblici. Senza poi trascurare che il sito di scommesse in criptovalute, Polymarket, è tornato a dare in vantaggio Trump negli ultimi giorni. Questo poi ovviamente non significa che per l’ex presidente la situazione sia tutta rose e fiori. Non solo la Harris ha finora raccolto 500 milioni di dollari in fondi elettorali, ma Trump deve fare anche attenzione in North Carolina, dove ha pericolosamente perso terreno. La partita, insomma, è aperta, come lo è sempre stata (sì, anche quando il candidato dem era Biden, almeno fino al disastroso dibattito televisivo del 27 giugno). Ma la campagna del tycoon non sta soltanto battendo palmo a palmo gli Stati chiave. È anche probabilmente in trattative per ottenere l’endorsement di Robert Kennedy jr, che sta attualmente correndo da indipendente. Martedì, la candidata vice di Kennedy, Nicole Shanahan, ha rivelato che il diretto interessato starebbe valutando di fare un passo indietro e di dare l’appoggio al candidato repubblicano. Trump, dal canto suo, ha colto subito la palla al balzo, dicendosi aperto alla possibilità di riservare al figlio di Bob Kennedy un ruolo in una sua futura amministrazione. Del resto, che i due si stessero avvicinando, non era esattamente un mistero. A luglio, fu diffuso il video di una telefonata tra lo stesso Kennedy, noto antivaccinista, e Trump, in cui quest’ultimo esprimeva proprio dei dubbi sui vaccini. Va anche detto che, alcuni giorni fa, il Washington Post ha riportato che il candidato indipendente avrebbe cercato di mettersi in contatto con il team della Harris per ottenere un incarico in un’eventuale nuova amministrazione dem. D’altronde, la campagna di Kennedy è ormai in forte difficoltà, avendo meno di quattro milioni di dollari in cassa. Ma che cosa accadrebbe se Kennedy, attualmente dato da Fivethirtyeight al 5% a livello nazionale, si ritirasse e sostenesse Trump? Alcuni ritengono che un simile scenario favorirebbe la Harris, visto che il nome Kennedy è ancora di richiamo per una parte della sinistra americana: sinistra che, tra le altre cose, è piuttosto vicina al figlio di Bob soprattutto sull’ambientalismo. Se quindi lui restasse in campo, ragiona questa scuola di pensiero, rosicchierebbe voti alla vicepresidente. Ciò detto, attenzione: lo scorso 10 agosto, The Hill ha riferito di sondaggi secondo cui, con l’uscita di scena di Biden, la presenza di Kennedy nella corsa danneggerebbe più Trump che la Harris. Nelle ultime tre settimane, l’ex presidente ha registrato performance sondaggistiche migliori, sia a livello nazionale sia a livello statale, in assenza di Kennedy. Secondo The Hill, senza di lui, il tycoon guadagnerebbe oggi quasi quattro punti in Michigan. Certo, qualora il candidato indipendente si unisse a Trump, a quest’ultimo verrà chiesto conto di quando, alcuni mesi fa, lo bollava come un radicale di estrema sinistra. Tuttavia il pur non enorme pacchetto di voti detenuto da Kennedy non può non far gola all’ex presidente. Non è neppure escluso, da questo punto di vista, che l’avvicinamento tra i due sia stato mediato da Elon Musk, che intrattiene buoni rapporti con entrambi. Tra l’altro, Trump ha di recente aperto all’ipotesi di offrire anche al Ceo di Tesla un incarico nella propria amministrazione. E lui si è già detto disponibile.
(Arma dei Carabinieri)
Il sequestro è avvenuto nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, in un’area particolarmente isolata e difficilmente accessibile.
L’ operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata ed è stata resa possibile grazie all’apporto altamente specialistico dei militari dello Squadrone Eliportato «Cacciatori di Calabria», reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri specializzato nelle attività di ricerca in ambienti difficilmente accessibili. Proprio durante una perlustrazione accurata del territorio, i militari hanno individuato un fusto in plastica nascosto tra le pietre di un muro di contenimento, molto bene mimetizzato per sfuggire a eventuali controlli.
All’interno del contenitore è stato trovato un vero e proprio arsenale: un fucile d’assalto tipo Kalashnikov, completo di caricatore e munizioni calibro 7.62 x 39, un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa, una doppietta dello stesso calibro, tre bombe anticarro di tipo M-60 e altri tre razzi anticarro. Un quantitativo e una tipologia di armi che fanno presumere una destinazione ad attività criminali di elevata pericolosità.
Considerata l’estrema minaccia alla sicurezza rappresentata dall'esplosivo rinvenuto, i Carabinieri hanno immediatamente richiesto l’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Reggio Calabria. L’area è stata prontamente isolata e messa in sicurezza attraverso un’accurata cinturazione per tutelare l’incolumità degli operatori e prevenire rischi per la popolazione. In seguito, gli ordigni sono stati fatti brillare sul posto secondo le procedure previste. L’intervento degli specialisti è durato diverse ore, a conferma della complessità e delicatezza delle operazioni.
Le attività di controllo non si sono fermate al primo ritrovamento. Nel proseguimento delle perlustrazioni, i militari dell’Arma hanno esteso le ricerche anche a strutture rurali e fabbricati dismessi della zona. All’interno di un casolare abbandonato sono stati così ritrovati altri quattro fucili e una pistola Smith & Wesson, assieme a diverse munizioni di vario calibro poste sotto sequestro con il resto delle armi.
Il consistente sequestro ha consentito di sottrarre alla disponibilità della criminalità un ingente quantitativo di armi e materiale esplodente, che avrebbe potuto essere impiegato per compiere gravi fatti di sangue o azioni intimidatorie.
L’operazione rappresenta un ulteriore segnale della costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, capace di intervenire con prontezza anche in contesti operativi complessi.
Continua a leggereRiduci