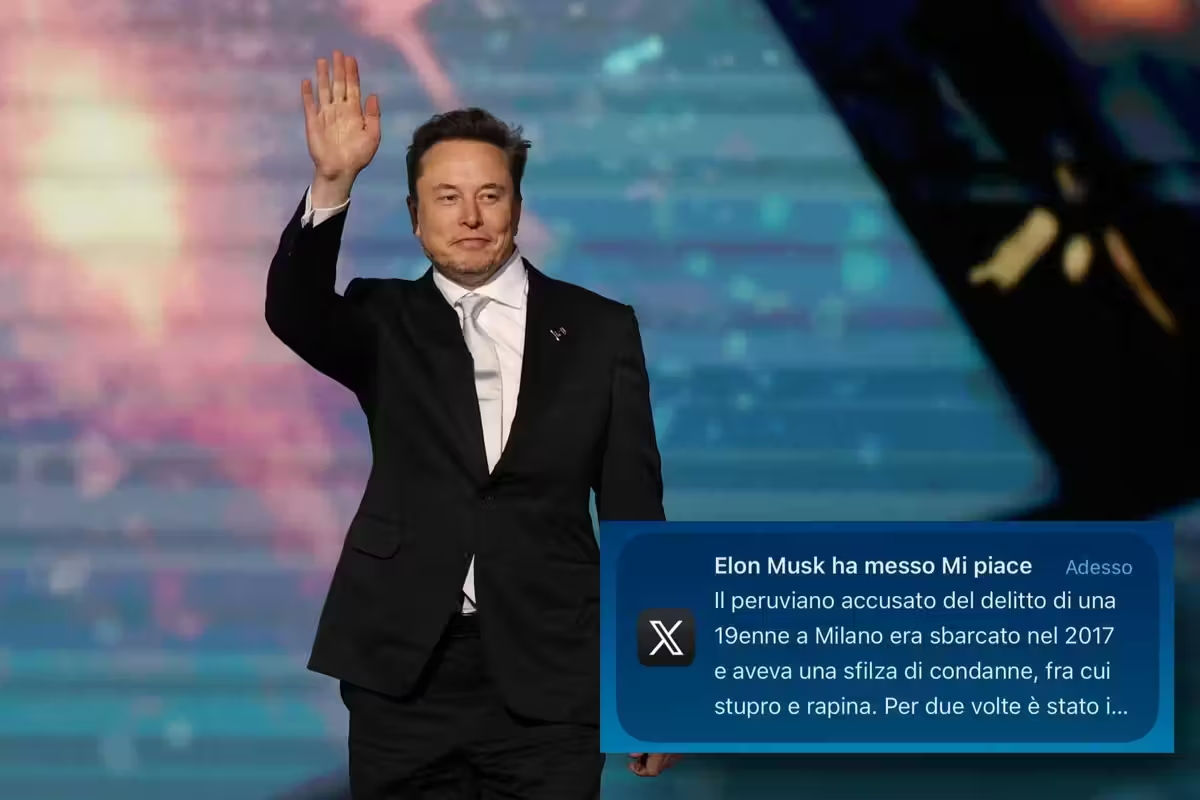Nessuna sorpresa, la Bce ieri ha lasciato i tassi di interesse fermi per la terza volta di fila dopo dieci rialzi. I tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono invariati rispettivamente al 4,5%, al 4,75% e al 4%. Nessun nuovo indizio sui futuri cambiamenti di politica: si tratta quasi di una copia alla lettera della dichiarazione di dicembre. Il taglio potrebbe non arrivare prima dell’estate (se va bene alla riunione del 6 giugno, al più tardi il 18 luglio), ma la direzione si intuirà meglio con le proiezioni di marzo. Vestita di bianco come le colombe alla conferenza stampa dopo la riunione del consiglio direttivo, Christine Lagarde affila le forbici ma ha ribadito che all’interno del Consiglio direttivo c’è consenso sul fatto che sia «prematuro parlare di tagli» e che le decisioni continuano a dipendere dai dati macroeconomici che vengono esaminati di volta in volta: «non guarderemo il calendario», ha puntualizzato.
Nella cornice del World Economic Forum della scorsa settimana il numero uno della Bce aveva definito «probabile» che un taglio ai tassi possa arrivare in estate, «ma dobbiamo essere cauti, perché continuiamo a dipendere dai dati e ci sono alcuni indicatori che non sono ancorati al livello in cui vorremmo vederli», aveva precisato. E ieri ha fatto un passo indietro. Anche nel comunicato dell’istituto di Francoforte non ci sono novità: «Le nuove informazioni hanno confermato sostanzialmente la sua valutazione precedente circa le prospettive di inflazione a medio termine», si legge nella nota di fine vertice. Dove si aggiunge che «le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di riferimento siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario».
Il confronto di Lagarde con i giornalisti è però partito dallo scenario di fondo: l’economia della zona euro ha probabilmente ristagnato negli ultimi mesi del 2023 e guardando al breve termine persistono segnali di debolezza per il tessuto economico del blocco. Poi ha detto che «i rischi per la crescita economica restano orientati al ribasso» e che si prevede che la ripresa «comincerà nel corso del 2024».
Le ultime indicazioni segnalano come i salari stiano già rallentando lievemente e che l’aumento dei salari sia assorbito dalle aziende e non «scaricato» sui prezzi finali. Ma con la guerra in Medio Oriente e i timori che la situazione nel Mar Rosso possano spingere al rialzo l’inflazione, ha aggiunto, i rischi al rialzo per il carovita includono l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche. In particolare, sulla chiusura del Canale di Suez per gli attacchi degli Houthi, la presidente ha spiegato che «la Bce monitora con attenzione l’aumento dei costi di spedizione». Per Lagarde, «se il conflitto si sviluppasse ulteriormente, questo rappresenterebbe un rischio». Dunque, «la guerra della Russia contro l’Ucraina e il tragico conflitto in Medio Oriente costituiscono le principali fonti di rischio geopolitico». Nonostante questo, la numero uno dell’Eurotower ha detto che «l’inflazione dovrebbe rallentare ulteriormente nel corso di quest’anno, man mano che si attenueranno gli effetti dei passati shock energetici, delle interruzioni delle forniture e della ripartenza dell'economia dopo la pandemia, mentre la politica monetaria restrittiva continuerà a frenare la domanda». Le misure delle aspettative di inflazione a breve termine «si sono notevolmente ridotte, mentre quelle a più lungo termine si attestano per lo più intorno al 2%».
Attenzione, però. Così si avvia una coazione a ripetere. Perché già nei mesi scorsi la Bce aveva ammesso che si era sbagliata, che ad alimentare la fiammata dei prezzi negli ultimi anni è stata solo in parte la bolletta energetica e che la vera responsabilità era da attribuire ai famigerati colli di bottiglia lungo la filiera dell’offerta emersi dopo i lockdown. I colli di bottiglia e i rincari delle bollette hanno generato la greedflation, ovvero la cosiddetta avidità di profitti che ha spinto le aziende ad alzare i prezzi finali per mantenere o aumentare i margini. Una sorta di legittima difesa da parte delle imprese che si tutelano dai rincari che a loro volta subiscono riversando l’aumento dei costi sugli utenti. Una corsa dei prezzi che la Bce non aveva visto, tanto che ha iniziato ad alzare i tassi solo a luglio del 2022. Fino a quel momento aveva sostenuto che il rialzo dei prezzi era solo un fenomeno transitorio destinato a rientrare presto. Ora ci risiamo. Con Lagarde che sta ferma, e aspetta i problemi.
Intanto, come hanno reagito i mercati? Le Borse europee hanno chiuso miste: Francoforte e Parigi sono salite dello 0,11%, Londra ha archiviato la seduta sopra la parità (+0,02%), in calo Madrid (-0,58%) e anche Milano con un -0,59%. Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi è sceso a 153,4 punti, a fronte dei 155,3 punti della chiusura di mercoledì. Il rendimento scende al 3,82 per cento. «Il mercato sta già anticipando una riduzione dei tassi di interesse», ha commentato il presidente dell’Abi (l’associazione dei banchieri), Antonio Patuelli a Sky tg24. E ha fatto l’esempio del tasso più usato per i mutui, ovvero l’Irs a dieci anni: «A ottobre era del 3,52%, ieri il 2,73% circa 80 punti base, una riduzione rilevante».