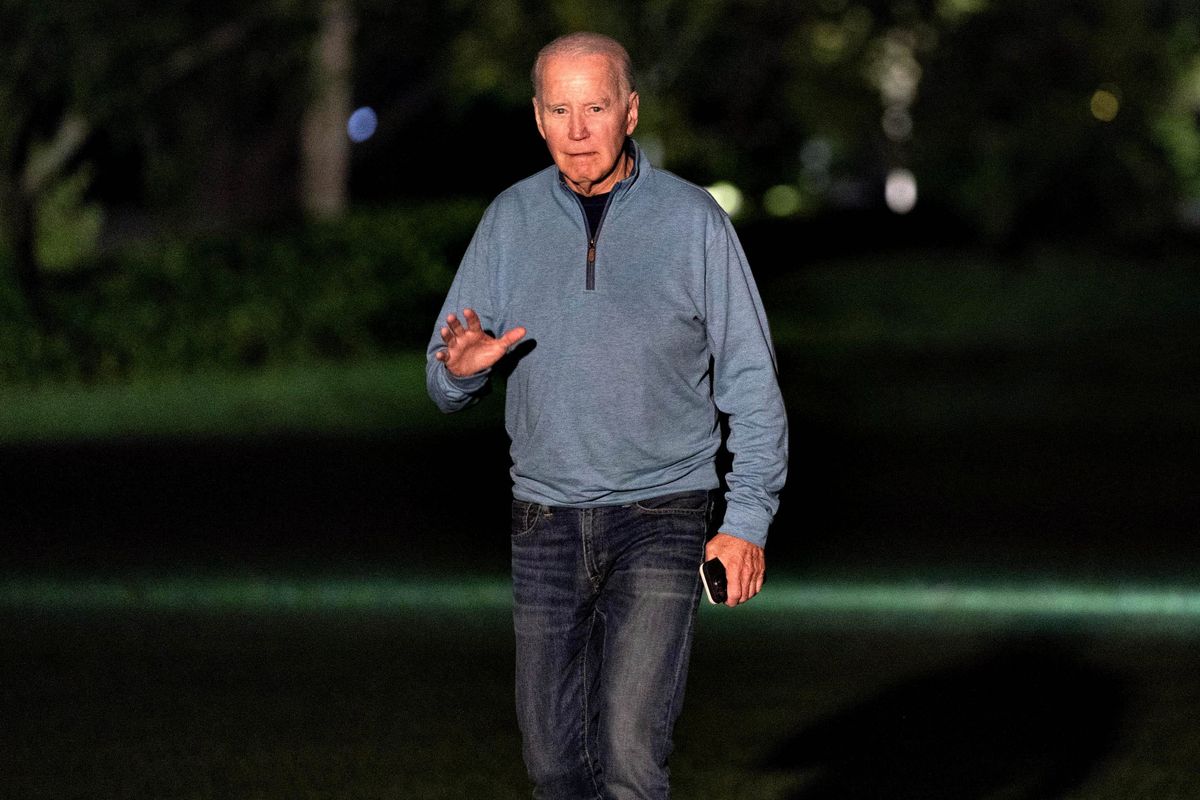Il quadro politico siriano continua a rivelarsi denso d’incertezza. E anche nel mondo arabo si registra meno unità di quanto possa sembrare a prima vista. Ieri, ad Aqaba si è riunito il Gruppo di contatto ministeriale arabo sulla Siria. Al tavolo erano rappresentati Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Libano, Iraq, Qatar, Emirati, Bahrein e Lega araba. Non solo. A prendere parte al consesso sono stati anche il segretario di Stato americano, Tony Blinken, il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, e l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas. Al termine del summit, i Paesi arabi hanno emesso un comunicato in cui «sostengono un processo di transizione politica siriana pacifico e inclusivo patrocinato dall’Onu e dalla Lega araba, in cui siano rappresentate, con giustizia, tutte le forze politiche e sociali siriane, comprese le donne, i giovani e la società civile». Nel documento, viene anche invocata la «cessazione immediata di tutte le operazioni militari», oltre a degli «sforzi per combattere il terrorismo».
La sensazione è tuttavia che questo comunicato sia rimasto piuttosto vago, senza entrare eccessivamente in dettagli concreti. Il che potrebbe essere stato un modo per coprire le divisioni tra i partecipanti. Secondo Al Jazeera, sembra proprio che a rappresentare ufficiosamente le istanze del nuovo regime siriano siano stati la Turchia, che ieri ha riaperto l’ambasciata a Damasco dopo dodici anni, e il Qatar: non è d’altronde un mistero che entrambi questi Paesi intrattengano storicamente ambigui legami con l’organizzazione islamista di Mohammad al Jolani, Tahrir al-Sham. Il crollo del brutale regime di Bashar al Assad rappresenta del resto una vittoria per la Fratellanza musulmana, che è storicamente spalleggiata da Doha e Ankara: quella stessa Fratellanza che è, al contrario, fortemente temuta dai governi di Arabia Saudita, Egitto ed Emirati. Guarda caso, proprio ieri, il consigliere presidenziale emiratino, Anwar Gargash, ha espresso preoccupazione per i legami dei nuovi leader siriani con Al Qaeda e con la Fratellanza. Non solo. Per quanto il summit di Aqaba si sia dimostrato critico nei confronti dello Stato ebraico, è verosimile ritenere che, sotto sotto, Riad condivida alcune delle preoccupazioni nutrite da Gerusalemme verso Jolani. Lo Stato ebraico non si fida del capo di Tahrir al-Sham: prova ne sono i recenti bombardamenti israeliani ai siti militari di Assad per evitare che i loro armamenti finiscano nelle mani del nuovo leader siriano, irritatosi ieri per questi attacchi. Inoltre, sempre ieri, Axios ha rivelato che, venerdì, la Giordania ha avuto colloqui segreti con Israele sulla Siria.
Un ulteriore punto di attrito è poi rappresentato dalla questione curda. Venerdì, Fidan ha usato parole molto dure su questo tema. «L’eliminazione dell’Ypg è l’obiettivo strategico della Turchia», ha detto, sottolineando che i gruppi legati al Pkk non dovrebbero avere posto nella nuova Siria. Del resto, più o meno nelle stesse ore, l’Esercito nazionale siriano, storicamente spalleggiato da Ankara, sottraeva all’Ypg una diga strategica sull’Eufrate. Un atteggiamento, quello turco sui curdi, che, oltre a preoccupare Washington, sta irritando gli israeliani. Gerusalemme auspicherebbe infatti che la Siria diventi «una federazione di regioni etniche autonome». Non a caso, a inizio settimana, il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, aveva criticato gli attacchi delle forze filo-turche ai curdi.
Per ora, l’unico vero collante tra turchi, americani, israeliani e arabi resta l’indebolimento dell’Iran. Nonostante avessero rafforzato i rapporti con Teheran negli scorsi anni, Doha e Ankara non hanno esitato a colpirla tramite l’abbattimento di Assad, approfittando del momento favorevole sul piano internazionale. Israele, dal canto suo, è un acerrimo nemico degli ayatollah, mentre Donald Trump ha bisogno di un regime khomeinista debole, per rilanciare sia gli Accordi di Abramo sia il piano di pace israelo-palestinese che aveva approntato durante il primo mandato. Forse non a caso, ieri le forze dell’Anp hanno ucciso a Jenin un comandante della Jihad islamica: gruppo terroristico che, in questi anni, è stato foraggiato anche da Teheran. È alla luce di tutto questo che Jolani, oltre alla carta del «moderatismo», si sta giocando scaltramente anche quella di «mastino anti-iraniano» in territorio siriano. «Siamo stati in grado di porre fine alla presenza iraniana in Siria», ha rivendicato ieri, annunciando inoltre che il prossimo governo prevederà lo svolgimento di elezioni, spiegando che verranno formati comitati e consigli per riesaminare la Costituzione, e che la forma dell'autorità sarà lasciata alle decisioni di esperti, giuristi e del popolo siriano.
Tuttavia, come abbiamo visto, il collante anti-iraniano potrebbe non bastare. Anche perché è tutto da dimostrare che Doha e Ankara saranno in grado di controllare pienamente Jolani. Blinken, dal canto suo, ha confermato ieri l’esistenza di contatti diretti tra l’amministrazione Biden e Tahrir al-Sham, specificando di auspicare il «successo» del popolo siriano.
Un po’ sarà per motivi «esplorativi», un po’ non va trascurato che storicamente i dem americani sono assai più bendisposti verso la Fratellanza musulmana rispetto ai repubblicani. Fu del resto l’amministrazione Obama, di cui Biden e Blinken facevano parte, a dare la propria benedizione, nel 2011, alle cosiddette «primavere arabe»: una politica che venne successivamente cassata da Trump. Non solo. Tali contatti diretti potrebbero inoltre significare che Washington non si fida dell’intermediazione di Ankara, temendo forse che Jolani possa ritagliarsi un ruolo più autonomo (e più pericoloso) del previsto. Si tratta di un timore che probabilmente sta attanagliando anche la Russia. Secondo Reuters, Mosca dovrebbe riuscire a mantenere il controllo delle sue basi siriane, ma intanto sta trasferendo alcuni cargo in Libia.