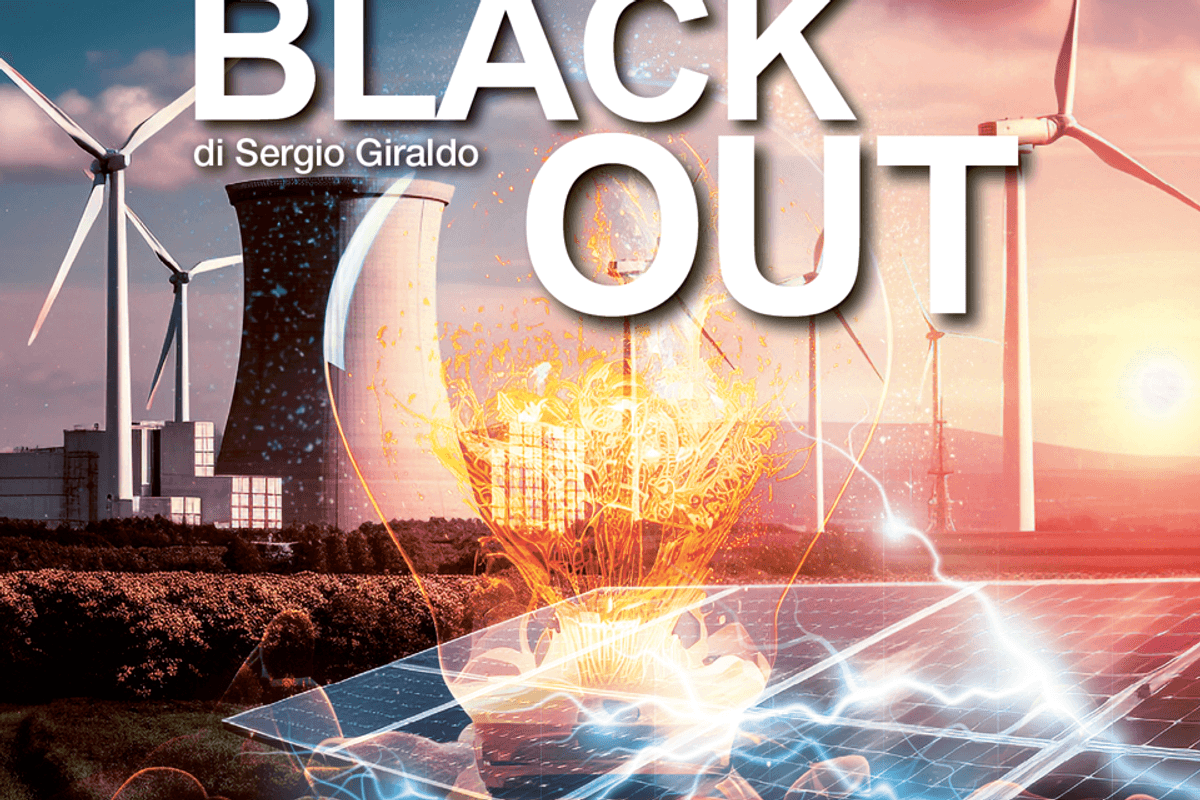2022-06-09
True
2026-03-08
Proteste contro i giudici. Le assistenti sociali tramano: spostare i piccoli Trevallion
I manifesti appesi in solidarietà alla cosiddetta famiglia del bosco fuori dalla casa famiglia di assegnazione a Vasto (Ansa)
L’avvocato della famiglia del bosco: «Vogliono evitare i giornalisti». Ieri fiaccolata di solidarietà davanti alla struttura che li ospita. Preoccupa la mamma: è sotto choc.
In tre ore, si è consumato il vergognoso strappo dai suoi figli. L’allontanamento dalla struttura di Vasto di Catherine Birmingham Trevallion è avvenuto senza rispetto, umanità. Nessuna attenzione a preparare i piccoli per l’ulteriore distacco. Via dalla casa nel bosco, via dalla famiglia, ora la separazione violenta dalla mamma.
Sì, perché malgrado il tempo ci fosse, venerdì, per spiegare alle tre creature che cosa stava per succedere, senza metterle davanti alla scena tremenda della mamma che deve andarsene con la valigia in mano, le modalità sono state di assoluta indifferenza per i sentimenti, la psiche di tre piccini.
«L’assistente sociale Veruska D’Angelo e una coordinatrice che non avevamo mai visto sono state chiuse tutto il giorno in ufficio e quando, verso le 18.30, ho chiesto loro quando intendevano eseguire il provvedimento di allontanamento della madre, mi hanno detto “oggi, adesso”. “I bambini sono stati informati?”, è stata la mia preoccupazione. Non si erano poste il problema». Così l’avvocato Danila Solinas, uno dei legali dei coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, descrive la disumana applicazione dell’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell’Aquila.
Catherine non vuole andarsene, rifiuta di lasciare i figli, alla fine va a fare i bagagli. Quando i bambini capiscono quello che sta succedendo, reagiscono piangendo o chiudendosi in un tremendo mutismo. Alla più grande sale la febbre, le sue urla sono lancinanti. Alle 21.20 Nathan è arrivato, fa salire la moglie in auto, si allontanano dalla struttura. «I bambini hanno scoperto casualmente e drammaticamente la realtà del distacco e hanno avuto reazioni strazianti», dichiara sdegnato lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente della difesa dei coniugi anglo-australiani.
Sottolinea: «Queste sono scene che generano danni enormi, la cosa che mi sorprende è la modalità non empatica, priva di mediazione, con la quale dei professionisti hanno deciso di espellere la madre, senza valutare minimamente la ricaduta traumatica sui bambini. Le uniche persone capaci di consolare questi piccoli sono state la nonna Pauline di 81 anni, mamma di Catherine, e la zia Rachel che si sono prodigate in modo incisivo». «Catherine adesso è a Palmoli, ancora sotto choc», precisa l’avvocato. «Venerdì aveva avuto la forza di rispondere a più di 500 test, pur sapendo dell’ordinanza notificata il giorno della perizia, e di lasciare la struttura come le è stato chiesto. Altro che riottosa, non so come mi sarei comportata io al suo posto, con un trattamento così vergognoso», esclama Solinas. «La D’Angelo ha minacciato anche di chiamare le forze dell’ordine se la signora non lasciava la struttura spontaneamente».
Ci mancava anche una simile scena, per quei poveri piccoli. L’incognita è quando sposteranno i bambini, come disposto nell’ordinanza. Pare vadano in una struttura a Scerne di Pineto e auguriamoci che non li separino. «Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) mi hanno assicurato che i piccoli non venivano mossi da Vasto ma la preoccupazione delle assistenti sociali è di evitare giornalisti e riprese video, quindi temo che non si muoveranno di giorno», aggiunge il legale. Se la nuova casa famiglia fosse davvero nella frazione costiera più vicina a Teramo, papà Trevallion dovrà sostenere due ore di andata e due ore di ritorno sulla sua vecchia auto per andare a trovare i figli. E mamma Catherine? Nell’ordinanza «censurabile sotto tutti profili, giuridici, fattuali, ricostruttivi» sottolinea l’avvocato, non si fa cenno alle modalità previste per gli incontri della madre. La vogliono allontanare definitivamente? Solinas, assieme all’avvocato Marco Femminella, presenterà lunedì un reclamo alla Corte d’appello dell’Aquila per una sospensione del provvedimento di allontanamento della madre, perché Catherine possa tornare a stare con i propri figli nell’attesa che siano concluse tutte le perizie richieste.
Ieri, tante persone hanno risposto all’appello per una fiaccolata silenziosa fuori dalla casa accoglienza Genova Rulli di Vasto, che ospita i tre bambini dal novembre scorso. Portavano peluche e dolci in dono, regali che sono stati rifiutati dai responsabili della struttura. Numerosi cartelli riportavano parole di sdegno, di condanna per quello che risulta un accanimento nei confronti della «famiglia nel bosco». Sugli striscioni, scritte come «I bambini a casa con i loro genitori. Stop agli abusi sui minori di 6 anni. Vergogna». Carola Profeta, responsabile del dipartimento Famiglia della Lega in Abruzzo, presente anche lei alla fiaccolata, ha scritto sui social: «La casa famiglia dove stavano i bambini e la madre è di proprietà della diocesi di Chieti-Vasto, da cristiana chiedo al vescovo, monsignor Bruno Forte, di esprimersi sulla vicenda e gli chiedo se sia normale che una proprietà della Chiesa venga usata per sfasciare le famiglie».
L’allontanamento di Catherine Birmingham dai suoi figli è stato definito da Profeta «l’ennesimo crimine di Stato. Ennesimo perché è dal 2020 che denuncio la Bibbiano D’Abruzzo. Il modus operandi del Tribunale minorile dell’Aquila è assolutamente inaccettabile e indegno di un Paese civile». Secondo l’esponente della Lega, «il presidente Cecilia Angrisano, iscritta al Cismai, il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia, ha messo in piedi un sistema di continua sottrazione di minori ai danni di genitori che potevano anche avere delle difficoltà, ma la famiglia va aiutata e non smembrata come è avvenuto con i Trevallion».
Profeta ha annunciato: «Domani (oggi per chi legge, ndr) andrò a Palmoli e chiederò a Nathan e Catherine di fare un appello con me al presidente Sergio Mattarella, che come capo del Consiglio superiore della magistratura, anche se non può revocare l’ordinanza, può però fare una moral suasion suggerendo ai magistrati a fare un passo indietro». La responsabile del dipartimento Famiglia si augura che il tentativo vada a buon fine anche se è la prima a dubitarne «vista la concomitanza con il referendum sulla giustizia. Che messaggio sarebbe se il presidente del Csm chiedesse a un giudice di fare un passo indietro?».
Continua a leggereRiduci
Ansa
L’azienda che controlla l’ospedale di Napoli chiede ai romani di mandare suoi esperti al fine (ufficialmente) di «rafforzare la qualità delle cure». Di fatto per sollevare un reparto ormai marchiato dal cuore bruciato.
Sono passate già due settimane dalla morte del piccolo Domenico Caliendo e le ombre sul caso del trapianto di cuore fallito diventano sempre più fitte. La famiglia del piccolo prosegue la sua lotta alla ricerca della verità affinché si faccia giustizia e soprattutto affinché nessun bambino possa morire così tragicamente.
Nell’ospedale Monaldi di Napoli il clima che si respira è sempre più teso, i ricoveri sono diminuiti ma quello che si scopre, mettendo insieme i pezzi di un puzzle complesso, è che il reparto di Cardiochirurgia pediatrica è fermo e chiede «aiuto» al Bambino Gesù di Roma. Infatti, per «rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi» l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale, ha deciso di siglare una convenzione con l’ospedale pediatrico di Roma. L’accordo è stato richiesto dall’azienda proprio dopo la tragica scomparsa del piccolo Domenico ed è stato così motivato: «Un passo concreto e immediato per garantire continuità assistenziale e rafforzare ulteriormente la qualità delle cure offerte ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, che non hanno mai smesso di credere nel Monaldi».
Che cosa succederà in pratica? In base all’accordo, per i prossimi tre mesi un’equipe altamente specializzata del Bambino Gesù opererà stabilmente a Napoli. Saranno infatti distaccati al Monaldi quattro professionisti, ovvero un cardiochirurgo, un anestesista, un infermiere ferrista e un perfusionista, figure fondamentali per garantire la gestione dei casi più complessi e delle procedure cardiochirurgiche più avanzate. L’equipe lavorerà in stretta «integrazione con i professionisti dell’Azienda ospedaliera dei Colli, contribuendo al consolidamento delle attività cliniche e al trasferimento di competenze. In caso di necessità, la collaborazione potrà essere ulteriormente rafforzata con il supporto aggiuntivo di altri specialisti, tra cui un ulteriore cardiochirurgo e un anestesista».
Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico, ha sempre sottolineato di non voler demonizzare tutto il Monaldi, ospedale che il piccolo ha frequentato spesso nei suoi due anni di vita perché soffriva di un problema al cuore. Eppure lì più di qualcosa non ha funzionato. Gli inquirenti parlano di «negligenza» e «imperizia» dei medici, nel provvedimento che vede sette specialisti indagati. L’inchiesta della Procura di Napoli sta cercando di fare chiarezza sia sul trasporto del nuovo organo da Bolzano a Napoli (contenitore, tempistiche e procedure di espianto) sia su quello che è accaduto nella sala operatoria del Monaldi dove è stato espiantato il cuore malato del piccolo Domenico.
Dalla relazione degli ispettori del ministero della Salute e del Cnt, redatta dopo i sopralluoghi al Monaldi e all’ospedale di Bolzano, emerge un altro particolare inquietante: il dosaggio sbagliato di un farmaco somministrato da un’anestesista dell’ospedale di Bolzano potrebbe aver danneggiato il cuore destinato a Domenico prima che questo venisse espiantato e congelato erroneamente col ghiaccio secco. Ma su questo elemento il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi, sentito dall’Ansa, ha precisato: «Questo verrà accertato dall’autopsia con l’esame sui tessuti, comunque ciò non muta il quadro delle responsabilità dell’equipe del Monaldi. Dalle prime indagini è emerso che il team di Napoli era partito senza un perfusionista e che la dottoressa Farina (uno degli indagati) abbia chiesto che l’infusione del liquido venisse effettuata da un’altra persona. Ma emerge anche che sarebbe stata la stessa dottoressa del Monaldi a indicare quanto liquido infondere e in quanto tempo. È stato inoltre riferito che l’infusione non è stata portata a termine perché il chirurgo di Innsbruck ha richiamato l’attenzione per un rigonfiamento del fegato e del cuore. Sarebbe stato poi lo stesso chirurgo a intervenire per risolvere la situazione». Intanto, con una lettera 186 genitori di bambini cardiopatici difendono il Monaldi e, in particolare, il primario Guido Oppido, il cardiochirurgo indagato: «Molti dei nostri bambini oggi respirano, sorridono e vivono grazie alla Cardiochirurgia pediatrica, grazie a medici che ogni giorno combattono una battaglia silenziosa contro il tempo e contro la morte. Tra quei medici, per anni, c’è stato il professor Oppido. Oggi assistiamo a un processo mediatico feroce, spietato, che rischia di travolgere tutto: una persona, una struttura, un reparto, un’intera rete di cura da cui dipende la vita dei nostri figli».
Il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera dei Colli, Alberto Pagliafora, aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali, ma dopo qualche ora le ha ritirate. In una nota, si precisa che «la decisione di proseguire nel proprio incarico è maturata a seguito di una riflessione personale, nella consapevolezza della delicatezza della fase che l’ospedale sta attraversando e dell’importanza di garantire continuità amministrativa e organizzativa alle attività dell’ente. L’azienda prosegue con determinazione nel suo lavoro».
Continua a leggereRiduci
Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere. Salgono i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio. Gnl dal Qatar fermo, i produttori di petrolio del Golfo frenano l’estrazione in cerca di stoccaggi.
Ansa
Se avessero coraggio, oggi sarebbero in piazza per Catherine, allontanata dalla prole non da maschi feroci ma da altre donne. Ed è tempo anche di una presa di posizione forte da parte delle gerarchie ecclesiastiche.
Nel mare di retorica che sentiremo oggi in occasione della Festa della donna, sarebbe di conforto udire - tra le tante banalità - anche qualche parola un filo coraggiosa su una fetta di popolazione che è realmente discriminata e i cui diritti sono regolarmente calpestati. Sono le madri a cui lo Stato italiano toglie i figli, talvolta con l’uso della forza bruta talaltra con mezzi più subdoli.
E qui non c’entrano la mascolinità tossica e il patriarcato che vengono costantemente evocati quali mali profondi della nostra società. No, semmai qui c’entra uno Stato che - come tante istituzioni contemporanee - punta a farsi unica, grande madre pretendendo di educare i figli-cittadini in nome di un bene superiore noto a esso soltanto. Si separano madri e figli con la scusa del «superiore interesse del minore», cioè si sostiene che sia meglio per un bambino uniformarsi alle indicazioni di esperti di varia natura, della società di medicina e psicologia e delle organizzazioni internazionali piuttosto che essere amato ed educato dai suoi genitori, per quanto imperfetti possano essere.
Se avessero un poco di coraggio, oggi tutte le femministe del reame dovrebbero scendere in piazza a sostegno di Catherine Trevallion, simbolo di tutte queste madri separate a forza dalla loro prole. È una donna forte e tenace, con convinzioni robuste e il Tribunale dei minori dell’Aquila la punisce per questo. L’intera ordinanza che venerdì ha disposto il suo allontanamento dalla casa protetta di Vasto in cui da novembre è rimasta assieme ai suoi tre figli è un gigantesco atto di accusa contro di lei. Le rimproverano di essere rigida, di non aver obbedito alle indicazioni dei responsabili della struttura, di avere risposto male alle assistenti sociali. Le rinfacciano di voler vedere i suoi figli e di non volersi piegare dinnanzi alle istituzioni che - a differenza di lei - saprebbero che cosa è meglio per i suoi bambini. Sembra anche che cerchino di mettere suo marito contro di lei, e infatti ieri alcuni quotidiani insistevano sulla differenza di approccio fra Catherine e Nathan e addirittura parlavano di screzi nella coppia. Dopo aver separato genitori e figli, ora tentano di dividere mamma e papà.
Di fronte a questo scempio, dove sono tutte le eroiche paladine dell’indipendenza e della libertà? Dove sono le attiviste che si offendono se un uomo «spiega loro le cose» (è il temibile mansplaining) o se dimostra troppa affettata cavalleria? Tacciono, ovviamente. E, di nuovo, non sono maschi feroci a imporre tutto ciò a una donna coriacea: sono altre donne, giudici e assistenti sociali, curatrici e tutrici.
Se qualcuna parla, fra le varie attiviste e politiche che hanno fatto dell’orgoglio femminile una bandiera, è per lo più per rintracciare a Giorgia Meloni di occuparsi della famiglia nel bosco invece che di chissà che altro, come se questo caso e, più in generale, la giustizia minorile non fossero argomenti pregnanti. La verità è che a queste vestali della correttezza politica interessa un solo tipo di donna: quella che combatte il maschio e lotta a favore dell’aborto, e che magari rifiuta la maternità per principio. Catherine Trevallion è, invece, una donna d’un altro tempo, attaccata alla sua spiritualità e alla sua terra, capace di rinunciare alle lusinghe della modernità per curare la sua famiglia in un ambiente più sano. Scelte che, per la massa, sono sostanzialmente incomprensibili. Chissà, forse se si battesse contro il riscaldamento globale e la tirannia patriarcale può darsi che la sosterrebbero di più. Invece la abbandonano al suo destino.
A manifestare a favore della famiglia nel bosco davanti alla casa protetta di Vasto ieri c’erano donne di destra, persone comuni. Italiane e italiani indignati come i tantissimi che in questi giorni hanno commentato i nostri video e i nostri articoli. Non c’erano le sfegatate di Non una di meno e simili: quelle hanno altre meno nobili cause di cui occuparsi.
A dire il vero, la loro assenza non è l’unica che si nota. Si sente anche, e tanto, la mancanza di una presa di posizione forte da parte delle gerarchie ecclesiastiche. Basterebbe notare che la casa di accoglienza che ha ospitato la madre e i bambini e i cui operatori hanno, poi, insistito per allontanarli è legata alla diocesi. L’arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto è Bruno Forte, un intellettuale e una figura molto autorevole. Diverse settimane fa aveva espresso qualche pacato invito alla riflessione, aveva ricordato che le istituzioni hanno il compito di proteggere le famiglie e di non vessarle. Ebbene, sarebbe opportuno e molto utile che il monsignore ora prendesse posizione con toni decisi. La casa protetta e i suoi operatori non hanno difeso la famiglia, anzi sono andati allo scontro con Catherine, hanno inviato al tribunale le loro rimostranze, in parte francamente molto discutibili.
Oggi saranno in tanti a celebrare le donne, ma coloro che dovrebbero difendere la donna e la famiglia su questa vicenda appaiono piuttosto timidi. Cercano scappatoie, non vogliono inimicarsi le istituzioni, contribuiscono alla mostrificazione di Catherine. Ma basta leggere le carte e ripercorrere con un filo di onestà intellettuale tutto il percorso della famiglia nel bosco per comprendere che nel torto, qui, sono le istituzioni italiane. Ma manifestare contro il patriarcato, purtroppo, è più facile e richiede meno coraggio che manifestare contro un tribunale che distrugge una madre e una famiglia.
Continua a leggereRiduci