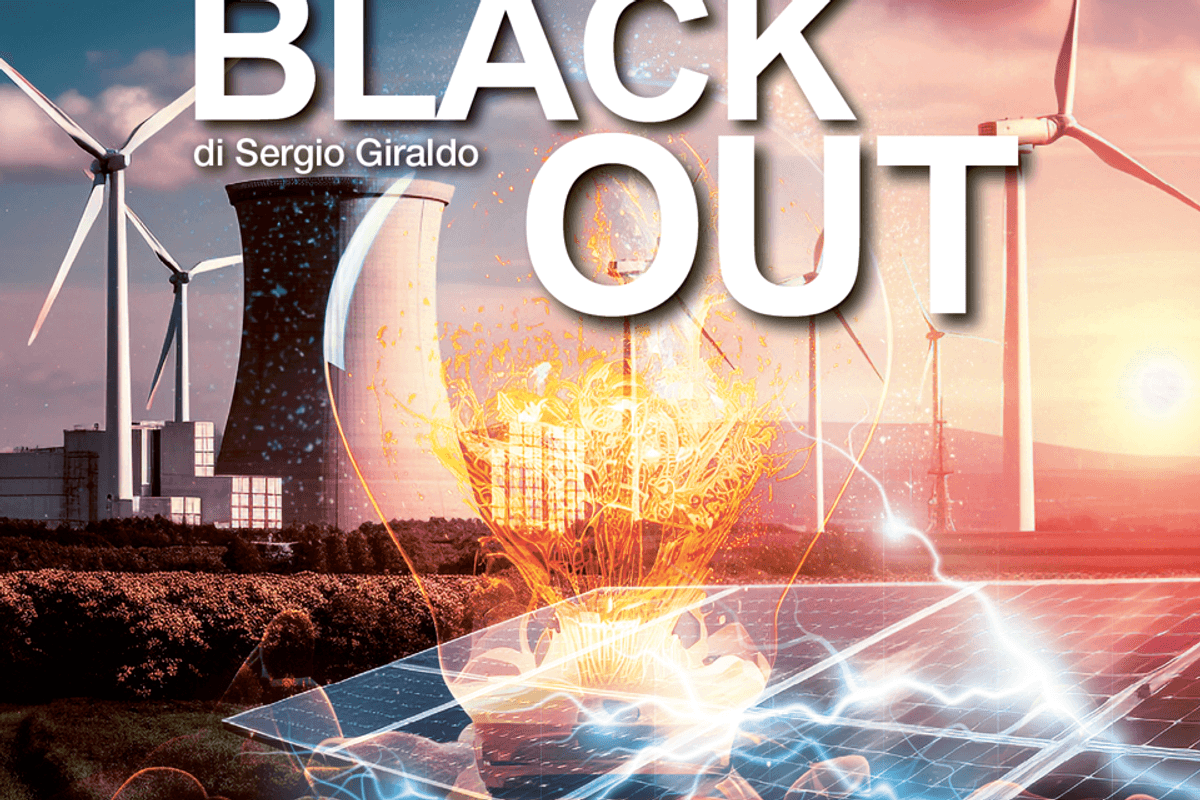Le vie del pellegrinaggio sono infinite. Ma tutte portano a un piatto di zuppa

Iniziamo con una magia gastro-temporale: serviamo in tavola una minestra di 600 anni fa. Non ci vuole molto per gustare questo sapore antico, dimenticato.
Bastano tre cose: qualche grammo di fantasia, un paio di etti di buona volontà e la ricetta di un illustre cuoco al servizio di un Papa nella prima metà del Quattrocento: Johannes Bockenheim. Il master chef del tardo Medioevo - oggi sarebbe un tristellato come Giancarlo Perbellini e Massimo Bottura - era un tedesco al servizio di papa Martino V, il Pontefice che riportò definitivamente la sede papale a Roma dopo la lunga parentesi di Avignone e che indisse nel 1423 l’Anno Santo, il quinto nella storia dei giubilei universali ordinari. L’attuale Giubileo indetto da papa Francesco, è il venticinquesimo. Non c’è da meravigliarsi se Martino V si serviva di un cuoco tedesco. Basti pensare che il più grande cuoco precolombiano, Maestro Martino, prima al servizio di Francesco Sforza poi, pure lui, di Papi e cardinali, era nato in un villaggio svizzero. A quei tempi gli italiani stavano affilando i coltelli per entrare nelle cucine rinascimentali e diventare i migliori d’Europa. I francesi? Erano di là da venire.
Ma torniamo a Bockenheim e alla sua ricetta. È facilissima da eseguire e regalerà a chi la preparerà sui fornelli di casa la soddisfazione di gustare un sapore medioevale, una zuppa di legumi che andava di moda nella prima metà del Quattrocento. Fu pensando alle migliaia di pellegrini che stavano percorrendo le vie romee, le strade, cioè, che portavano a Roma per il Giubileo (la Francigena, la Germanica, la Nonantolana, l’antica via Flaminia…), che Johannes Bockenheim abbandonò momentaneamente mestoli, schiumarole e fuochi papali per suggerire questa ricetta semplice e povera - a parte un paio di ingredienti che proprio poveri non erano - per aiutare chi si era messo in cammino con mille dubbi e paure (prima di partire ci si confessava e i più ricchi facevano anche testamento), ma con il cuore traboccante di fede. La ricetta verrà riportata qualche anno dopo nel libro che il cuoco tedesco scrisse in latino nel 1430: il Registrum coquine, ovvero il Giornale di cucina: «Prendi le fave, lavale bene in acqua calda e lasciale così tutta una notte. Poi falle bollire in acqua fresca, tritale bene e aggiungi vino bianco. Condisci con cipolla, olio di oliva o burro, e un po’ di zafferano». La ricetta si conclude con la dedica: «Sarà buono (il piatto) per i chierici vaganti e per i pellegrini».
La conclusione dell’anno giubilare 1423 non fermò i pellegrinaggi alle tombe dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dei martiri, alla Terra Santa (da Roma, la via Francigena continuava fino ai porti pugliesi), a San Giacomo di Compostela. Come abbiamo visto sul numero della Verità del 29 marzo scorso, chierici e pellegrini erano tutti uguali nelle intenzioni del Papa giubilare, ma anche tra loro, direbbe George Orwell, c’era chi era più uguale degli altri. C’era chi portava nella bisaccia cipolle, aglio, erbe dei campi e il pane nero della penitenza, fatto con farine di cereali di basso apporto nutritivo, e chi invece aveva a disposizione carne secca, formaggi e pane bianco di farina di frumento. C’era chi andava a cavallo con tanto di sella sotto l’aristocratico deretano e chi aveva a disposizione il cosiddetto cavallo di San Francesco, cioè le gambe, e il bordone, il bastone con la punta di ferro cui appoggiarsi nei tratti più difficili della strada o per difendersi in qualche modo dagli animali selvatici.
Poveri o ricchi, i viveri che i pellegrini portavano nel tascapane avevano lo stesso compito: dovevano durare più a lungo possibile. Anche settimane. La pagnotta s’induriva come un sasso, ma bastava ammollarla nell’acqua o nel vino per renderla masticabile. Il vino, conservato nella cosiddetta «bottiglia del pellegrino», la zucca a due globi svuotata e trasformata in borraccia, era molto importante anche se scadente: grazie all’alcool diventava un disinfettante, serviva per «sterilizzare» l’acqua che si guastava in poco tempo provocando seri disturbi intestinali. Quindi all’osteria come in viaggio il vino, sia pure mediocre o di scarsa qualità, diventava un dissetante perfetto mescolato all’acqua.
La differenza sociale balzava ancor più all’occhio quando i viatores chiedevano ospitalità in uno dei luoghi di ristoro, a pagamento, disseminati lungo le strade dei pellegrinaggi. Le cose andavano bene per i pellegrini poveri quando bussavano ai portoni di monasteri e conventi dove veniva loro offerto un pasto caldo, zuppe, minestre, brodi di verdure o di erbe dei campi conditi in vario modo, proprio come la zuppa suggerita da Johannes Bockenheim. Le regole di molte comunità monastiche contemplavano il dovere dell’accoglienza tanto che, accanto a conventi e abbazie, furono costruiti, nel tempo, edifici per ospitare i pellegrini, i xenodochia, case per ospiti dove i pellegrini venivano accolti e ristorati. Le cose in senso economico andavano altrettanto bene per i viandanti della fede quando trovavano persone caritatevoli che aprivano loro le porte di casa. Quando un pellegrino bussava a queste porte e dentro c’era già un collega con la scodella vuota in mano in attesa della minestra, il buon padrone di casa non si scoraggiava: allungava con l’acqua il brodo che già cuoceva nella marmitta sul fuoco. È nato in questi tempi un simpatico modo di dire: «È arrivato un altro frate, brodo lungo e seguitate».
Ma nel corso dei secoli sulle strade romee e sulle altre vie di pellegrinaggio si diffuse l’ospitalità a pagamento. La domanda creò l’offerta favorendo la nascita di osterie, locande, ostelli, dove venivano serviti piatti diversi dalle solite minestre (per chi aveva la borsa dei denari ben fornita), ma dove, accanto al locandiere onesto, si poteva incappare nell’oste furbetto che approfittava dei pellegrini, anime semplici, ricchi di fede ma sprovveduti.
Qual era, nelle locande, il menù del pellegrino con pochi mezzi? Se non era zuppa, era pan bagnato. Tra i piatti offerti c’era un minestrone, il pulmentum, strettamente legato alle «offerte» di stagione: erbe, verdure, cereali, legumi. Il tutto condito con lardo. L’enciclopedia Treccani insegna che la parola deriva dal latino puls, una pappetta di frumento, una polentina che nei più antichi tempi di Roma sostituiva il pane. Col nome di pulmentum era indicata anche la polenta di farina di fave.
Altro piatto del menù pellegrino era la paniccia, una zuppa a base di legumi e cereali. Questo piatto, almeno come nome, è ancora presente in Piemonte dove troviamo la panissa valsesiana che è un risotto fatto con carne di manzo, lardo e fagioli. Non è molto diversa la paniscia novarese, risotto arricchito con verze. La panissa ligure è tutt’altra cosa: una farinata di ceci che, una volta raffreddata, si può gettare nell’olio bollente e friggere o, ancora calda, condire con olio d’oliva (rigorosamente ligure) e succo di limone.
Altro piatto nel menù del pellegrino era il macco, antica zuppa medioevale, fatta con fave e altre verdure, che ancora oggi viene proposta in qualche agriturismo toscano sulla via Francigena. Il sito della Cia, Confederazione italiana agricoltori, informa che all’agriturismo il Castagnolino a pochi chilometri da San Gimignano, il macco è nel menù del pellegrino d’oggi. «La zuppa», dicono, «è un alimento consolatorio al quale venivano aggiunte erbe officinali spontanee e, a San Gimignano, spezie come lo zafferano, utilizzate nella medicina popolare». Questa la ricetta: cuocere le fave in un brodo vegetale di sedano carote e cipolle. Una volta cotte, vanno passate e messe in una pentola con lo zafferano dopo averne pestato gli stigmi in un mortaio. Aggiustare con sale e pepe. In una padella tostare il pane di segale con l’olio. Saltare le erbe di campo con aglio in camicia. Impiattare a zuppa in una scodella, aggiungendo le erbe saltate, il pane tostato e l’olio. Buon cammino.