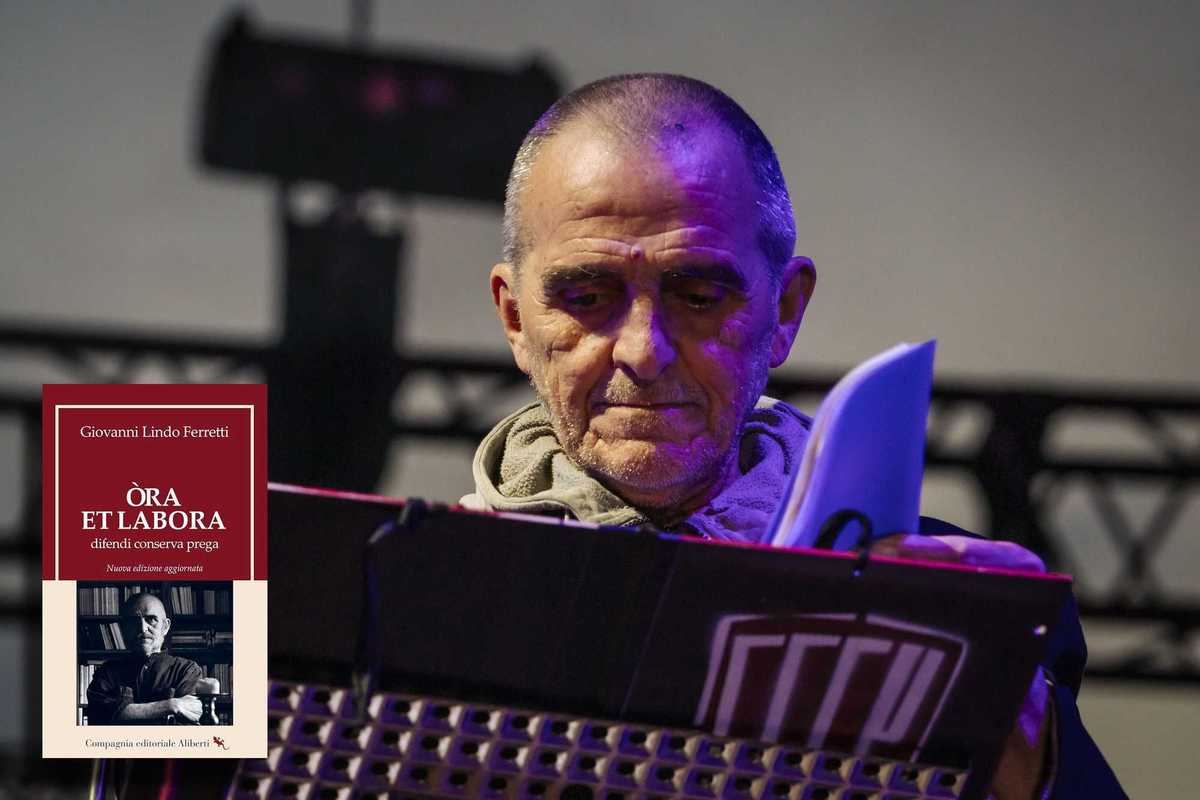«Ormai viviamo nel culto delle regole. Che funzionino o meno non conta più»

Paolo Musso è professore di Filosofia della scienza all’università dell’Insubria e autore di uno splendido libro intitolato La scienza e l’idea di ragione (Mimesis), da cui ha tratto alcuni concetti espressi in un articolo appena pubblicato sul sito della Fondazione Hume di Luca Ricolfi. Uno scritto che contiene alcune analisi fondamentali sulla gestione della pandemia.
Il suo articolo prende le mosse da una domanda importante: perché così tanti, nella gestione della pandemia, hanno agito in modo così assurdo?
«Non ho una risposta esauriente, perché i fattori sono tanti: la tendenza dell’uomo all’autoinganno, la difficoltà di ammettere i propri errori, il fatto contingente di esserci trovati con un governo abbastanza squinternato... Ma, al di là di questo, c’è a mio parere una questione culturale importante, che sto studiando già da tempo».
Quale?
«Nella nostra cultura non c’è una sola idea di modernità, ma due, fra loro opposte. Una, nata con Galileo, sta alla base della scienza e dice che ragione ed esperienza devono collaborare. L’altra, nata con Cartesio, sta alla base della filosofia moderna e parte da una negazione aprioristica del valore dell’esperienza. Questa seconda visione si è diffusa sempre più negli ultimi decenni, causando uno scollamento fra ragione ed esperienza».
Provo a semplificare. Lo scollamento di cui lei parla si traduce nella tendenza a stabilire regole, categorie preconcette in cui ci si rinchiude. E l’esperienza, ovvero il confronto con la realtà, non basta a scalfirle, neanche se non funzionano. Proprio quello che sta succedendo con la gestione della pandemia.
«Sì. Il rifiuto del valore dell’esperienza nasce da un sospetto nei confronti della realtà, che viene percepita come qualcosa di cui non possiamo fidarci. Da qui il desiderio di controllarla anziché di conoscerla. È così che sono nate le ideologie totalitarie. Oggi siamo in un’era di relativismo, ma rimane sempre l’idea che alla fine a contare davvero siano sempre le regole».
Insomma, tendiamo a rinchiuderci in una prigione burocratica fatta di norme con cui pretendiamo di imbrigliare la realtà.
«La burocrazia alla lunga diviene ideologia. Anzi, in un certo senso ne è l’essenza ultima. Infatti, se il cuore dell’ideologia è la mania del controllo attraverso le regole, la burocrazia è mania di controllo allo stato puro. Non importa se le regole funzionino o no, l’importante è che ci siano, perché la loro funzione principale è quella di rassicurarci. Così diventa difficile metterle in discussione, perché sarebbe psicologicamente destabilizzante».
Qui entra in gioco un tema che si è rivelato centrale nell’approccio alla pandemia, ovvero l’idea del «rischio zero». Invece di affrontare la possibilità del rischio ci ingabbiamo dentro regole che magari non funzionano, ma ci fanno sentire rassicurati.
«Questo atteggiamento è diventato comune solo negli ultimi decenni, ma ha radici antiche. La mania del controllo nasce dalla paura di rischiare. Non si vuole più correre rischi, neanche minimi. Ma è una pretesa irrealizzabile, perché la vita è di per sé un rischio. La cosa più rischiosa è nascere, perché chi nasce prima o poi muore. Non è una battuta: pensiamo alla denatalità. Ci sono varie cause, ma la principale è che si pensa: come si fa a far nascere un bambino in questo mondo così terribile? Eppure viviamo nell’epoca più sicura che si sia mai vista in tutta la storia umana. In sostanza, pretendiamo un livello di sicurezza irragionevole».
Sempre per evitare rischi tendiamo ad affidarci sempre più alle macchine, all’intelligenza artificiale.
«Sì, rifiutiamo il giudizio umano e tendiamo a stabilire standard uguali per tutti. Il giudizio personale è visto come qualcosa di pericoloso in sé, perché comporta dei rischi. Ma i giudizi troppo standardizzati sono inadeguati alla complessità del reale».
Forse questa è anche la ragione per cui si tende a giustificare «scientificamente» le scelte politiche... E facciamo passare questa idea di infallibilità degli scienziati, quasi che fossero moralmente superiori.
«Intanto dobbiamo considerare che gli scienziati sono esseri umani e quindi spesso, quando cominciano a diventare famosi, perdono un po’ la testa e assumono il ruolo di guru. Ma c’è anche una idea sbagliata di scienza. La forza della scienza non deriva dalla superiorità morale di chi la pratica, ma dall’efficacia del suo metodo, che prevede espressamente che si possa sbagliare».
Eppure gli errori, anche i più evidenti, non vengono mai ammessi.
«È stato sbagliatissimo adottare un linguaggio “di guerra”. E non solo un linguaggio, perché ci sono state iniziative, soprattutto del governo Conte, veramente molto discutibili, con venature autoritarie inquietanti. Ma è proprio l’idea in sé che è sbagliata. In guerra un esercito molto unito e motivato può vincere anche con una cattiva strategia, ma nelle questioni scientifiche non è così. L’unico modo per aver successo è comprendere come funziona ciò con cui abbiamo a che fare. E questo richiede la discussione critica, non il pensiero unico».
Anche in questo frangente entra in gioco la paura?
«Certo, la paura di accettare che non controlliamo tutto. Preferiamo illuderci di avere il controllo attraverso il proliferare delle regole, anche se non è vero. Altri Stati (di cui non si parla mai) hanno adottato un approccio più pragmatico, seguendo le indicazioni della realtà, e le cose sono andate molto meglio. La Nuova Zelanda alla fine del 2021 aveva appena dieci morti per milione di abitanti, mentre l’Italia ne aveva 2.300, cioè 230 volte di più. In un mondo normale andremmo a chiedergli come hanno fatto, invece continuiamo a dire che siamo noi quelli da prendere a modello».
Possiamo dire, citando Jünger, che siamo in un’epoca di mobilitazione totale. Ma tante persone partecipano volentieri...
«Nel mio articolo ho ripreso una storia citata da Václav Havel. Nella Cecoslovacchia comunista un ortolano metteva in vetrina in mezzo alle verdure un cartello con su scritto “Proletari di tutto il mondo unitevi”. Ovviamente l’ortolano non voleva veramente ottenere il risultato che i proletari di tutto il mondo si unissero: quello che voleva era far vedere a tutti di essere un buon cittadino, esibendo pubblicamente la sua entusiastica adesione al sistema. Questo sta succedendo anche da noi».
Per quale motivo, secondo lei?
«Ci sono persone, per dirla con Hannah Arendt, che hanno rinunciato a pensare in proprio e accettano le idee prevalenti, magari per una possibilità di carriera. Ma ci sono anche altri che accettano ciò che sta accadendo più per rassegnazione che per convinzione. E penso che siano tanti».
Non hanno avuto molta visibilità, però.
«I telegiornali sono andati avanti per due anni facendo parlare solamente chi era favorevole al governo o, fra gli oppositori, solo quelli che avevano idee palesemente assurde e si ridicolizzavano da soli. Le critiche più sensate, le posizioni intermedie, non hanno mai avuto molto spazio, il che è inquietante. Intendiamoci: non credo che ci sia dietro un complotto. Ma c’è una certa tendenza, condivisa un po’ a tutti i livelli, che spinge ad andare spontaneamente in questa direzione».
È la versione aggiornata del totalitarismo di cui parlava Václav Havel?
«Sì, è un rischio che Havel aveva già segnalato 40 anni fa nel libro Il potere dei senza potere, che consiglio a tutti di leggere perché sembra scritto oggi. Apre un diverso sguardo sul mondo. Lui aveva detto che quello che stava succedendo nel blocco comunista sarebbe potuto succedere anche da noi, in modi diversi che avrebbero mantenuto tutte le forme esteriori della democrazia. Ciò, paradossalmente, avrebbe reso più difficile riconoscere la natura intollerante e autoritaria del sistema».
Come lei nota, Havel insisteva molto sulla collaborazione delle persone al regime.
«Lui lo chiamava autototalitarismo. Spiegava che nei Paesi comunisti tutti - pur con gradazioni diverse - erano in parte tiranni e in parte vittime, di sé stessi e degli altri. I più mostravano un’adesione che magari non sempre era sincera, ma contribuiva a tenere in piedi tutto il sistema, che altrimenti non sarebbe durato. Infatti, quando il blocco sovietico ha iniziato a creparsi è crollato in tempi rapidissimi. È la storia del re nudo: bisogna che qualcuno cominci a dirlo e se la gente apre gli occhi poi il cambiamento può essere molto veloce».
Questo autototalitarismo dipende sempre dal timore del rischio?
«Sì, al fondo c’è sempre la paura: si preferisce un sistema oppressivo, ma che dia l’illusione di proteggerci. Ecco il vero cambiamento che ci serve: dobbiamo vedere la realtà non come nemica, ma come alleata. È per questo che oggi più che mai è importante difendere la cultura umanistica, perché in questo senso la filosofia e la letteratura aiutano molto».
Oggi sembra che pensare sia una perdita di tempo: siamo in emergenza, non possiamo ragionare...
«È una tendenza sbagliatissima. Si tende a misurare l’utilità sempre sul breve periodo. Quella del pensiero critico invece richiede tempi più lunghi, ma è un’utilità enorme, perché la disabitudine a riflettere ci porta in un circolo vizioso. La paura ci spinge a pretendere subito la soluzione, senza la pazienza di fare i passi necessari, ma così non la troviamo, il che aumenta il panico e via di seguito. Dobbiamo invertire la tendenza e ricominciare a calibrare il nostro pensiero sulla realtà. Altrimenti continueremo ad andare tutti nella direzione sbagliata».


 Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania
Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania