Massa, scienza e tecnica riducono l’uomo alla mercé di ciò che è «finito»
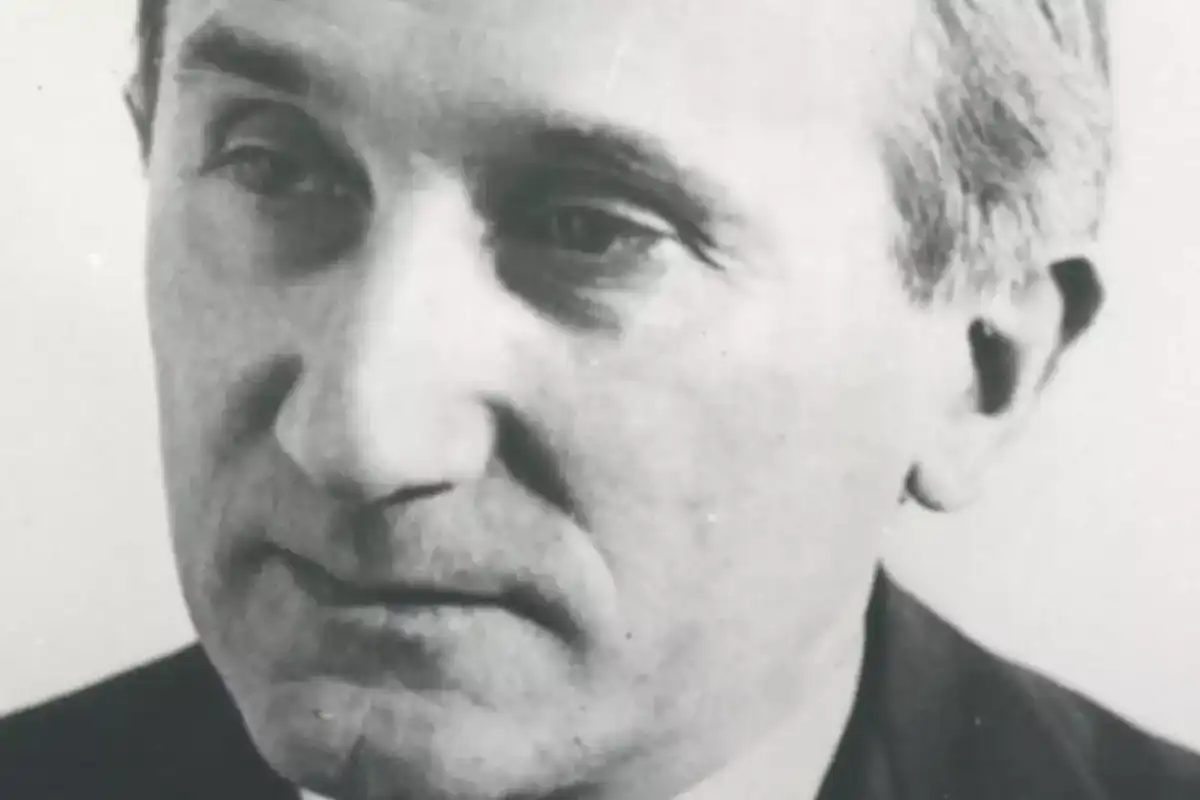
Dobbiamo vedere il mondo in modo nuovo - e il cambiamento in questione è già in corso. Dicendo questo, non affermiamo che il modo precedente fosse semplicemente sbagliato. Era quello possibile per il proprio tempo e anche quello giusto - dato che si tratta indubbiamente, anche e in primo luogo, di qualche cosa di esistenziale, di una forma fondamentale del modo di comportarsi dei viventi. Ma tutto ciò che è tema del sentire, del volere e del pensare dell’essere umano, per come costui è fatto, tende all’estremo. Ebbene, dalla necessità di diventare indipendenti, come cristiani, nei confronti di un mondo sperimentato a fondo, e dalla volontà di mettersi completamente dalla parte di Dio, si è sviluppato un modo di stare al mondo che, anche guardando la cosa dal lato di Dio, non riconosce al mondo i propri diritti. La sensibilità della stagione rinascimentale e moderna ha allora potuto rivolgere presto al Medioevo il rimprovero, errato nella sostanza ma esatto nei suoi effetti secondari, di disprezzare il mondo e di rifuggirlo.
Ciò ha avuto conseguenze pesanti. È sorto un mondo che, in quanto tale, non è intessuto di cristianesimo ma, da un punto di vista religioso, era lasciato in balia dell’incredulità: panteismo, razionalismo, deismo, scetticismo etc. Più precisamente, la coscienza medievale ha conferito anche a esso una forma pienamente cristiana ma, per così dire, suo malgrado: nella fantasia, simbolicamente, al di là di ciò che esso effettivamente è - basti pensare all’arte, alla poesia (Dante), all’ordinamento sociale e politico (gerarchia e idea dell’impero), alla concezione della natura (simbolismo). Il mondo non fu realmente considerato, né compreso cristianamente nella sua realtà né preso in carico con responsabilità. Corrispondentemente sorse anche una cristianità vuota di mondo reale. Di qui è derivato un impoverimento dello stesso pensiero cristiano, una condizione di penuria e di anomalia; un’esistenza cristiana posizionata altrove rispetto al momento storico, come pure un mondo piantato in asso dai cristiani.
A partire da questo stato di cose, ci è affidato un compito: vale a dire una sollecitudine cristiana per il mondo, ma non accordata controvoglia, bensì sinceramente voluta; una sollecitudine che si prende cura non solo delle necessità e dei compiti nel mondo, ma anche del mondo in quanto tale. Ma ciò è possibile solo se il mondo viene visto come una realtà voluta da Dio, a Lui cara, e dotata di un valore enorme; se viene visto come qualche cosa che Egli ha affidato all’uomo.
[…] Il cristianesimo è storico. Il termine non deve essere inteso nel senso storicistico o relativistico della teologia liberale, ma nel senso di quella storia che Dio porta avanti con la sua creazione. Tramite la creazione Egli fissa, secondo le circostanze, le condizioni in base alle quali deve svolgersi l’esistenza umana. Perciò offre anche al pensiero teologico una cornice a partire dalla quale interpretare la Rivelazione e il mondo. […] A me sembra che la coscienza cristiana - e con essa la teologia, che ne offre l’esplicitazione riflessiva - si sia basata, per quanto riguarda il rapporto di Dio con il mondo, sullo schema che segue. Parlo semplificando ed esagerando, poiché si tratta di elevare a uno stadio di consapevolezza qualche cosa che è in gestazione ed è percepito in modo ancora confuso. La coscienza cristiana ha considerato Dio come uno che si trova in uno stato di «olimpica serenità» al di sopra del mondo. Sotto forma di eresia, tale coscienza si è estrinsecata nel deismo, secondo il quale Dio avrebbe creato il mondo e lo avrebbe rimesso radicalmente a sé stesso, sicché da quel momento in poi esso, in quanto natura e cultura, sussiste e si organizza completamente per conto proprio, mentre Dio starebbe in certo modo in attesa degli esiti, per poi valutarli, sottoponendoli a giudizio.
[…] In questo modo di vedere il rapporto di Dio con il mondo si è, credo, sostanzialmente omesso di considerare che, a un dato momento, Egli si impegnò a salvare l’uomo e ciò avvenne con l’incarnazione. Essa non fu preparata. […].
Ora, il punto da considerare è che il rapporto di Dio con il mondo non è olimpico, non rappresenta l’opera prodigiosa di una potenza sovrana, compiuta da una distanza infinita. Dio, al contrario, è coinvolto attivamente nel mondo, sin dal principio e per sempre. Non nel senso - sia detto ancora una volta e ancor più fermamente - che Dio abbia bisogno del mondo, e neppure che Egli coincida ontologicamente con esso; né ancora, che il mondo proceda dalla Sua vita in virtù di un’emanazione di essere [Plotino]; ma perché egli ha voluto così, in pura libertà, con un gesto di donazione inspiegabile, che porta il nome di amore.
Perciò Dio è esistenzialmente partecipe dell’essere, dell’accadere, dell’evolversi e del destino dell’essere umano e, per suo tramite, del mondo.
[…] In questa luce, ciò che da un punto di vista teologico è detto storia (Geschichte), è appunto la realtà inconcepibile, che è l’accadere del mondo in genere, l’opera di Dio, alla quale Egli, l’Eterno, partecipa responsabilmente. Questa inconcepibilità si realizza in modo particolare nella storia dell’uomo. La vita e il destino di Gesù non furono solo la vicenda di questo personaggio, unico e senza pari, ma una manifestazione concentrata dell’evento che si è compiuto in tutto ciò che forma la storia umana. Storia non è solo il divenire e la sorte dell’individuo di turno, di un popolo, dell’umanità, ma è anche sempre storia di Dio, precisamente nella misura in cui Egli vi si coinvolge sul serio. La religione cristiana è però, in ultima analisi, il modello di comprensione di tale evento e della sua corrispondente attuazione pratica, quale ci viene consegnato dalla Rivelazione.
La volontà divina di farsi storia nell’uomo si manifesta in maniera particolarmente caratteristica nel modo in cui l’individuo si comporta da un punto di vista religioso: se crede o non arriva alla fede o la respinge; se vive la sua fede, cresce in essa o la lascia languire; il modo in cui combatte, vince o perde la sua battaglia morale. In tutto questo, Dio non è solo il sommo spettatore, colui che giudica, premia e castiga, ma Egli stesso vi si trova implicato. L’antica nozione di gloria - o di offesa - di Dio, se meditata fino in fondo, è già un tentativo di approcciare questo mistero. […]
L’attuale crisi generalizzata di fede consiste in gran parte nel fatto che - probabilmente sotto l’influsso di ciò che chiamiamo massa, scienza razionale e tecnica - questa esperienza religiosa immediata diminuisce, forse sparisce del tutto; che la finitezza del creato, il mondo e l’uomo sono essi stessi sentiti in certo modo staccati da Dio, e diventano realtà spoglie, puro mondo e mero uomo. Questa condizione anomala, contraria alla natura delle cose, si manifesta in tutto quello che la filosofia, l’arte, l’esperienza medica, la psicologia etc. definiscono come l’angoscia dell’uomo moderno, il suo spaesamento, la sua solitudine, il suo disgusto. D’altra parte riconosciamo che il mondo, tanto il macrocosmo quanto il microcosmo, è sempre più smisurato, e tocchiamo con mano che l’importanza e il potere dell’uomo stanno via via crescendo.
Se ne ricava l’immagine di un’esistenza in cui l’uomo - un mero essere umano, spogliato, ma che continua a diventare sempre più potente e titanico - è da solo con il mero mondo, anch’esso spogliato ma sempre più immenso; in cui l’uomo ghermisce il mondo per farne la materia di un’opera i cui confini si spingono nell’incommensurabile. A mano a mano che ciò avviene, Dio e ogni realtà divina diventano sempre più estranei e irreali. Sono percepiti come nomi di poteri e possibilità, che una volta erano oltre le possibilità dell’uomo, ma che ora sono in suo pugno. Per quanto gli uomini sentano ancora Dio e la religione come qualcosa di reale, chi la pensa diversamente li percepisce come invenzioni di gruppi sociali (le Chiese), che si servono di Dio per conseguire i propri interessi o mantenere il loro potere ostile al mondo. Tra Dio e gli uomini viene posta l’alternativa di quel «o Lui o io», che formulò Friedrich Nietzsche con un’altra tinta ma ugual senso, Karl Marx.
Qualcuno ha detto che si potrebbe intendere questa condizione come una lontananza di Dio, un abbandono di Dio, una eclissi da Lui decretata. Mi pare che questa idea sia sbagliata; mi sembra che Dio stesso sia presente nel processo descritto. Io credo - sia detto con la medesima cautela che vale per tutte queste mie considerazioni - che Dio stesso assuma questa condizione come una propria sofferenza. La sopporta in quanto parte di quella storia che vive nel suo mondo.
Da quanto detto, sorge una domanda: se l’esperienza religiosa immediata sta veramente diminuendo e forse un giorno, in quanto elemento universalmente operante, sparirà del tutto; se, d’altra parte, il mondo acquista un peso specifico proprio sempre più rilevante, l’essere umano raggiunge un potere sempre più grande, la seduzione del mondo lo invade con sempre più forza, il compito mondano diviene sempre più vasto e lo impegna sempre di più - come può arrivare alla conoscenza di Dio, alla fede, ovvero che carattere avrà la fede?
La conoscenza di Dio dovrà cominciare, a mio avviso, dall’analisi esatta e onesta della finitezza del mondo e dell’essere umano. […] Bisogna riconoscere, mettendola a nudo, l’ubriacatura prodotta da ciò che è quantificabile, i cui sintomi sono l’esperienza del vuoto, dell’angoscia, del disorientamento, del disgusto etc. - precisamente sono sintomi del fatto che l’uomo moderno si intrattiene solo con ciò che è finito. Ciò è al tempo stesso la prova che l’esigenza umana di valore e significato rivendica non soltanto qualcosa di numericamente o dimensionalmente sempre più grande, ma qualcosa di assoluto. Ed è la prova che questa esigenza non è una sopravvalutazione di sé, fatta chissà come da parte dell’essere umano, né un’illusione messagli in testa da qualcuno, bensì è assolutamente esatta e può essere occultata solo ad opera delle procedure tecniche.






