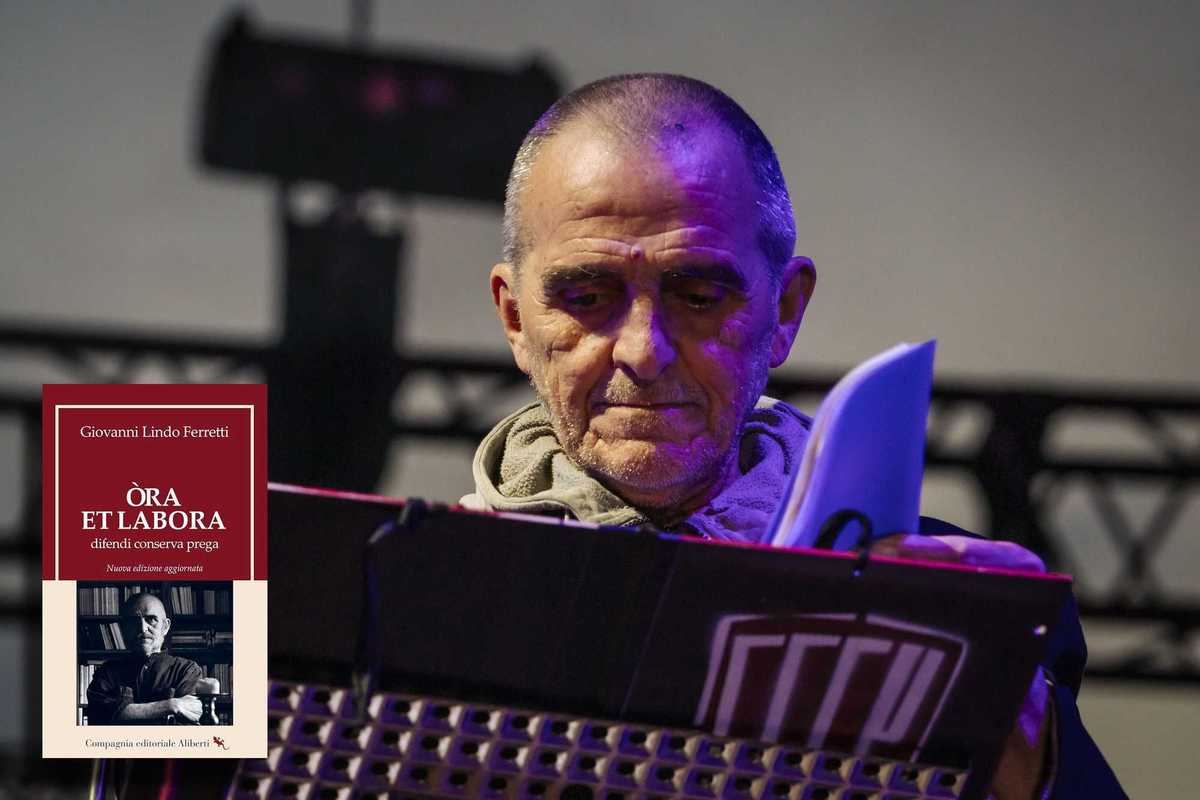L’idea di Boeri in «aiuto» alle aziende: meno investimenti per non far debito

L’economista bocconiano. Tito Boeri, già presidente dell’Inps per qualche anno, in un’intervista rilasciata ieri a La Stampa ha sentenziato che se ci fosse bisogno di altri sostegni o ristori alle imprese di questo Paese - e dunque alle famiglie che, salvo che non siano ereditiere di fortune varie, campano del lavoro che danno loro le imprese - non si deve fare più debito pubblico ma semmai tagliare il Superbonus - quello per intenderci che sta dando fiato alle imprese dell’edilizia e quattrini nelle tasche delle famiglie che vi lavorano - perché sta generando un rialzo dei prezzi cioè inflazione. Certo, se aumenta la domanda di cemento, di pale, di ponteggi e di tutto quello che serve all’edilizia, e nessuno controlla, è chiaro che aumentano i prezzi oltre il dovuto. Ma la domanda da porsi noi riteniamo che sia un’altra e vada in tutt’altra direzione: visto che probabilmente ci sarà bisogno di aiuti e sostegni economici è meglio rivedere il discorso sul debito e sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione italiana del Recovery fund - o dare una mazzata a un settore - come quello dell’edilizia che, come è noto, è ossigeno allo stato puro per la nostra economia in questo momento? Il professor Boeri è uomo preparato, con alle spalle studi e attività di ricerca importanti e certo non gli sfuggirà che in questo Paese per ogni euro investito nell’edilizia se ne generano tra 1,9 e 2,9 e la nostra media è superiore a quella degli altri Stati europei. E allora che si fa? Si rischia di fermare un settore che sta generando ricchezza e lavoro per obbedire ai diktat imposti dalla Ue, dal Recovery fund e dal Pnrr? A noi pare francamente irragionevole.
Ci colse il professor Romano Prodi quando era presidente della Commissione europea e in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Monde sostenne che «Il Patto di stabilità dell’Unione europea è stupido ma necessario». Si riferiva ai vincoli imposti da Maastricht: 3% del Pil per quanto riguardava il deficit annuo dei singoli Paesi e 60% per quanto riguardava il debito pubblico nazionale. Lo definì stupido «come tutte le decisioni rigide» e soggiunse che sarebbe servito «uno strumento con maggiore intelligenza e flessibilità, ma anche più autorità, che nessuno ha, e unanimità». Aveva ragione in pieno. Quelle parole, a nostro avviso, valgono oggi per quanto riguarda il Recovery fund e il Pnrr italiano. Esattamente per le stesse ragioni. È un patto rigido, quindi stupido, poco intelligente, stolto e miope. Anzitutto perché è stato concepito come se tutti i Paesi europei avessero le stesse caratteristiche. Come si fa a concepire un piano dove le regole e gli incentivi messi in campo sono gli stessi per un Paese come il nostro dove le piccolissime, piccole e medie imprese sono oltre il 95% del totale delle imprese e che generano il 45% degli occupati e un Paese come la Germania - ad esempio - dove le grandi imprese fanno la parte del leone e le imprese con meno di dieci addetti generano il 19% degli occupati? Capire che la transizione ecologica in Germania ha un valore economico enorme legato all’industria automobilistica e il passaggio all’auto ibrida e poi elettrica che da noi, ormai, ha un peso irrisorio? Ci vuole molto a capire che la nostra economia con quella tedesca c’entra come il giorno con la notte?
E poi, si può concepire un piano rigido, senza consentire agli Stati di indirizzare le risorse verso i settori che più ne hanno bisogno per vari anni di fronte a un fenomeno come il Covid del quale è sempre più difficile prevedere l’evoluzione e dunque le sue ripercussioni sullo sviluppo economico e la tanto agognata ripresa? Se fosse indetta una gara tra i patti più stupidi dell’Unione europea non so se vincerebbe Maastricht (che tra l’altro - è bene ricordarlo - fu concepito dai firmatari come flessibile e non rigido con il contributo fondamentale di un italiano, Guido Carli) o se il premio andrebbe al Recovery fund. Secondo noi il secondo senza ombra di dubbio.
Non sarebbe semmai il caso di decidersi una volta per tutte a ragionare sull’emissione di debito pubblico europeo, soprattutto in un momento come questo - drammatico - dove certamente ci sarà bisogno di nuovi interventi in economia da parte dei pubblici poteri, nazionali o europei che siano? Che aspettiamo ancora? Lo stesso Prodi formulò una proposta, Giulio Tremonti ne formulò un’altra in tempi nei quali non eravamo nel disastro attuale. Le proposte ci sono e sono credibili, fattibili ma soprattutto intelligenti, cioè capaci di adattarsi alle esigenze reali del mercato e dell’economia e non formulate come se l’economia reale non contasse. Possibile che i diktat della burocrazia prevalgano ancora una volta su quelli della ragionevolezza e sui principi del buon governo?
Cosa succederà nel 2022 tra cartelle esattoriali, la Bce che probabilmente diminuirà gli acquisti del debito pubblico italiano, ma soprattutto imprese che per le varie restrizioni e l’espandersi del contagio si troveranno di nuovo, se le cose non volgono al meglio come speriamo, con l’acqua alla gola? E tagliamo pure il Superbonus? Auguri. Meno male che, per ora, è l’idea di un economista e non del governo.



 Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania
Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania