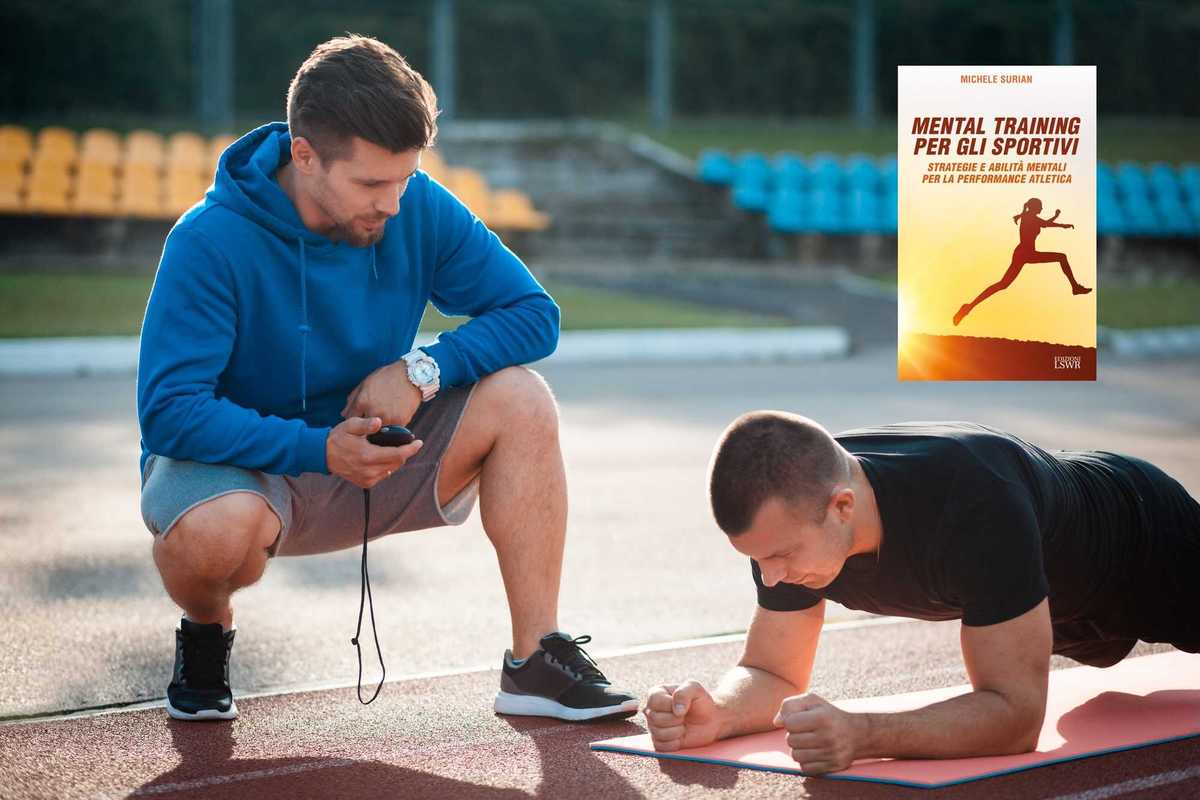Lgbt monopolisti di discriminazioni. Ma quelle vere le subiscono i disabili

Nel regno dell’inclusività non tutte le minoranze sono uguali. Ad alcune, e non da oggi, è garantita costante e strabordante visibilità: un riflettore sempre acceso a illuminare una scena costantemente occupata. Altre minoranze, invece, non hanno sfilate dell’orgoglio, non rivendicano quote nei programmi televisivi, non gridano per ottenere leggi bavaglio, non vengono celebrate da macabre sfilate alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Sono minoranze silenziose che per questo vengono per lo più ignorante dalla maggioranza inerte e raramente suscitano l’attenzione e la solidarietà di altre minoranze, occupate per lo più a pretendere diritti inesistenti.
In Italia una maggioranza piuttosto silenziosa è quella dei disabili. Secondo recenti dati Istat, sono circa 13 milioni, di cui oltre 3 milioni «in condizione di grave disabilità». Tra questi, quasi 1.500.000 ha un’età superiore a 75 anni. Tra i disabili italiani, poi, quasi uno su tre (32,1%) è a rischio povertà. Molti altri sono, oltre che anziani, soli. Eppure l’attenzione che i media e il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento - apparentemente tanto buoni e, appunto, inclusivi - è quasi inesistente. Forse perché i disabili non costituiscono un target commerciale, non sono un mercato che ingolosisce, anzi costano soldi alle casse pubbliche.
Era molto interessante, a tal proposito, la lettura di un bel reportage che ieri Repubblica (senza troppa pubblicità e senza titoli roboanti in prima pagina) ha dedicato ai musei e alle strutture culturali italiane. Vi si leggeva che negli ultimi anni è aumentata la sensibilità nei riguardi dei disabili «ma la strada verso l’inclusività totale è ancora lunga. Lo certificano gli ultimi dati dell’Istat: meno di tre quarti (il 68,2%) di musei e gallerie ha i bagni a norma, mentre solo il 62,2% delle strutture possiede rampe, scivoli o ascensori per permettere l’ingresso alle persone che usano la sedia a rotelle. Dati simili anche per le biblioteche: solo il 65,7 per cento ha i servizi a norma, il 61 è dotato di rampe o ascensori».
I numeri da soli non rendono bene l’idea. Quei dati stanno a indicare che circa il 40% delle biblioteche pubbliche italiane è, di fatto, inaccessibile a persone in carrozzina, le quali sono semplicemente escluse dalla fruizione del nostro meraviglioso patrimonio culturale e librario. Ancora peggiore la situazione per i ciechi: solo il 10,7% dei musei è attrezzato per offrire percorsi alternativi a chi non può vedere. E appena il 5,9% dei contenuti video sono disponibili in lingua dei segni per i sordi. E tutti gli altri? E quel 94% di sordi che non può ascoltare una proiezione al museo? E quel 35% di disabili che non può usare il bagno in biblioteca perché non è a norma? O quel 38% di persone in carrozzina che non può vedere una mostra perché non ci sono gli scivoli o le rampe?
Per altro, questo tipo di difficoltà - benché inaccettabili - sono tutto sommato secondarie rispetto alle altre elencate in documenti come Le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità. Report anni 2016-2023, dell’Anmic-Ente di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità. Leggendo alcune delle storie che vi sono riportate, c’è di che farsi il sangue amaro anche solo pensando alle mostruose difficoltà che i disabili incontrano per passare qualche giorno in vacanza.
Viene da domandarsi allora: dove sono le anime belle pronte a stracciarsi le vesti o a organizzare manifestazioni di piazza per queste persone? Dove sono i registi e gli intellettuali pronti a firmare appelli o a mettere in scena opere «scandalose» per richiamare l’attenzione su chi è realmente discriminato? Eppure i disabili sono numericamente superiori alla minoranza arcobaleno e forse pure agli stranieri presenti sul nostro territorio. Raramente, tuttavia, lì si sente piagnucolare o chiedere la distruzione del regime oppressivo dei «normodotati» o ancora pretendere che sia riconosciuta l’esistenza di un razzismo sistemico nei loro confronti. Anche se, probabilmente, le sole discriminazioni davvero sistematiche esistenti oggi colpiscono proprio loro.
I dati riguardanti i santuari della cultura, benché sfiorino un settore sicuramente meno rilevante rispetto alla sanità o al mondo del lavoro, colpiscono perché segnano il clamoroso dislivello esistente fra le diverse minoranze. Intellettuali e artisti sono i più attivi nella promozione della causa arcobaleno e nella lotta al razzismo verso gli stranieri. Musei e istituzioni culturali di tutto il mondo sono stati invasi, negli ultimi anni, dalla cosiddetta cultura della cancellazione, che ha censurato e oscurato opere d’arte di ogni genere con la scusa di porre fine alle discriminazioni e di non offendere alcuni gruppi sociali.
Solo che, mentre si cancellavano i quadri e le statue antiche per non turbare qualche studente politicamente schierato, molte persone in carrozzina non potevano nemmeno entrare nei palazzi in cui quelle opere venivano esposte. E mentre nelle scuole e nelle aziende si organizzano corsi di sensibilizzazione alle istanze transgender, appena il 2,7% delle istituzioni culturali italiane ha offerto ai propri dipendenti corsi di formazione sulle problematiche dei disabili.
Con tutta evidenza, non si tratta di stimolare un conflitto tra reietti o creare una triste competizione fra discriminati. Si tratta, semmai, di ribadire che la realtà esiste e che esistono le gerarchie: qualcuno subisce discriminazioni vere e dolorose in silenzio. Altri fanno tutto il rumore del mondo per discriminazioni immaginarie.