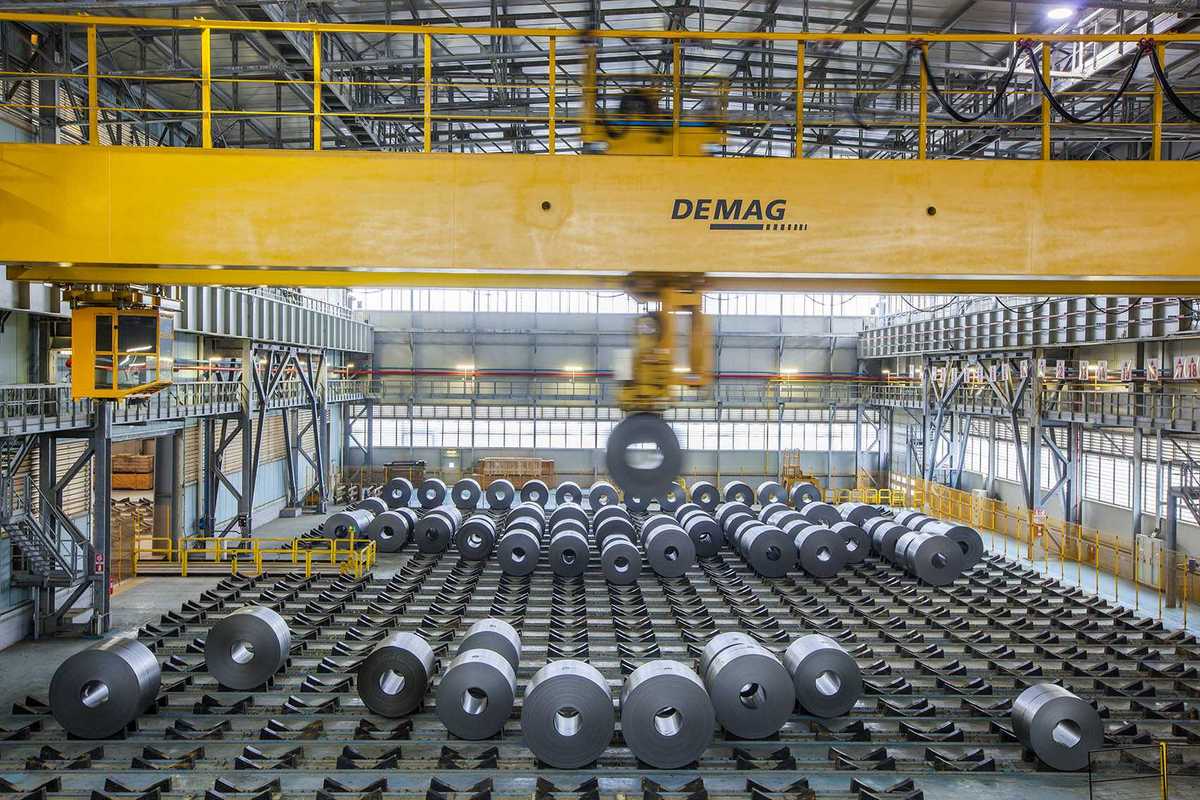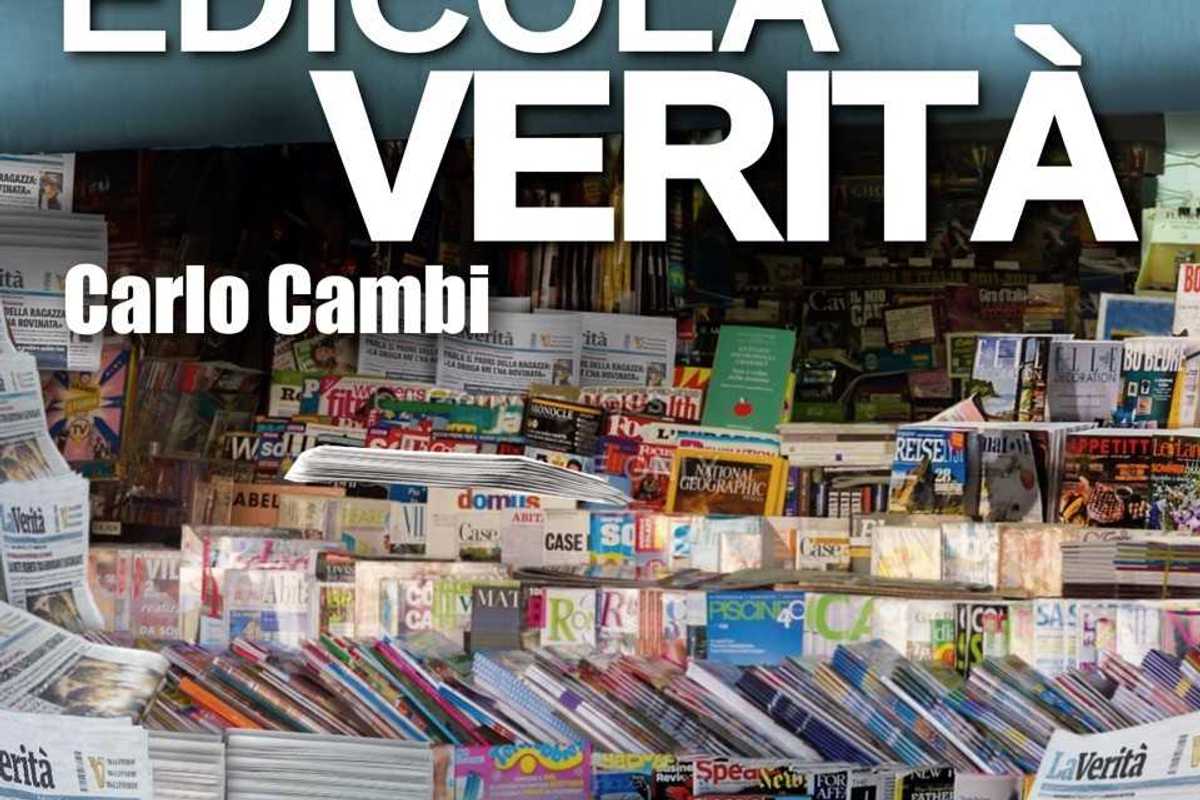A sirene spiegate nelle stalle e nei campi. Ma le api che abitavano nelle arnie sulla terrazza del ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare non c’entrano. Eppure hanno provato a incolpare il ministro Francesco Lollobrigida di questa «moria».
Il ministro, semmai, ha maiali e capre da pelare con le nuove emergenze virali, ma le povere api sono state fatte fuori da un terribile predatore: la vespa orientalis che ha banchettato con le ospiti delle tre arnie. Il ministro le ha volute per celebrare, nel 2023, la giornata delle api, che sono le sentinelle ambientali per eccellenza e la base dell’agricoltura. La Fai - Federazione apistica italiana - che ha in gestione le tre arnie ha fatto sapere che il combinato disposto di caldo e vespe ha creato il danno, ma gli alveari che loro hanno in custodia nel cuore di Roma, sono già stati ripristinati con una nuova popolazione di api italiane.
Se, però, si fosse prestata agli allevamenti in crisi la stessa attenzione che è stata data in questi giorni alle «operaie» in tuta giallo nera di Lollobrigida, per gli allevatori le prospettive sarebbero meno drammatiche. Anni e anni di animalismo ed ecologismo male interpretati stanno mettendo in serissima crisi gli allevamenti. Il danno potenziale? Siamo sopra i 40 miliardi di euro, con alcune eccellenze agroalimentari che rischiano di andare al tappetto con tre ganci micidiali: peste suina, lingua blu e influenza aviaria. Per fortuna quest’ultima è sotto controllo anche se dall’estero stiamo importando più che una zoonosi una psicosi. Ci sono in Italia, allo stato, solo 23 casi segnalati. L’aviaria in Italia si presenta a ondate periodiche e sin qui non è mai tracimata in vera epidemia, peraltro le aziende che aderiscono a UnaItalia (l’Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova, ndr) - presieduta da Antonio Forlini e guidata da Lara Sanfrancesco - hanno protocolli sanitari rigidissimi che hanno posto la nostra produzione avicola ai vertici mondiali di qualità e salubrità. E tuttavia la psicosi sta facendosi largo. La ragione? Si teme una zoonosi perché negli Usa c’è stato - forse - un primo caso di trasmissione del virus uomo-uomo. Il virologo Matteo Bassetti ha affermato che esiste una possibile trasmissibilità, mentre il suo collega Massimo Ciccozzi sostiene che non c’è questa eventualità ma va detto che, consumando carne di pollo e uova cotte, il virus non si trasmette.
Chissà se al proposito qualcuno ricorda la dimostrazione che il mai dimenticato Lamberto Sposini - allora vicedirettore del Tg5 - dette in diretta addentando, nel febbraio del 2006, una coscia di pollo arrosto. Una preoccupazione, semmai, c’è per la possibilità della trasmissione da allevamenti avicoli ad allevamenti bovini. In Italia, però, i virus che sono circolati sono molto diversi da quelli americani. La vigilanza è massima.
Preoccupa molto, invece, il secondo virus che si è riaffacciato in questi mesi e che colpisce duramente la zootecnia già provata dalla peste suina. È una nuova ondata di lingua blu. Un morbo che colpisce soprattutto pecore e capre ma che si diffonde anche ai bovini e porta alla morte degli animali. In una nota, Coldiretti lancia l’allarme: sono migliaia gli animali morti tra Sardegna, Piemonte, Lombardia e Calabria, ma anche in altri territori si registrano contagi. Alcune Regioni hanno già emanato ordinanze e provvedimenti per tentare di limitare la trasmissione della malattia, ma è molto complicato perché il morbo della lingua blu è inoculato nei ruminanti da un moscerino (cluicoide). Sono indispensabili campagne di disinfestazione a tappeto. La situazione lingua blu è particolarmente severa in Sardegna dove sono sotto pressione centinaia di allevamenti.
Va detto che la lingua blu non si trasmette all’uomo con il consumo di latte e carni, ma il danno per gli allevatori è comunque pesantissimo: cala la produzione, devono isolare greggi e mandrie, devono abbattere gli animali che si ammalano perché non c’è cura. La lingua blu è «entrata» con animali giunti dal Nord Europa - le importazioni di pecore sono a +16% - dove l’epidemia dilaga e dove i controlli sono molto blandi.
Continua anche la battaglia contro la peste suina, che da due anni falcidia le stalle. Gli abbattimenti selettivi di cinghiali, i diffusori del morbo, ordinati in tutta Italia stanno limitando i contagi, ma è come chiudere la stalla dopo che i maiali sono morti. I danni sono già miliardari, il contenimento preventivo della fauna selvatica non è stato attuato a causa dei veti «verdi». La peste suina si è manifestata il 6 gennaio del 2022 e l’allora ministro per la Salute, Roberto Speranza, ci mise sei mesi prima di attivare misure stringenti. La prima precauzione fu: evitate di fare jogging negli areali contaminati. Per andare oltre, attese che Roma, dove i cinghiali banchettano tra i rifiuti, fosse dichiarata zona rossa. Oggi il commissario straordinario, Giovanni Filippini - nominato dopo la rinuncia di Vincenzo Caputo - ha avviato un piano di emergenza che ha circoscritto in parte i focolai: sono, al momento, 24 tra Lombardia, dove c’è il grosso del contagio, Piemonte, dove si manifestarono i primi casi, ed Emilia-Romagna. Sono oltre 60.000 i maiali già abbattuti.
Anche in questo caso, la peste suina non si trasmette all’uomo consumando carne di maiale, né prosciutto o insaccati, ma gli allevatori lamentano danni ingentissimi soprattutto perché le scrofe continuano a partorire, gli animali vanno nutriti e le stalle sono al collasso con i prezzi già crollati del 50%. Tutto questo perché non si è saputa controllare l’orda dei cinghiali.